«C’è un ostacolo al leggere – ed è sempre lo stesso, in ogni campo della vita: – la troppa sicurezza di sé, la mancanza di umiltà, il rifiuto ad accogliere l’altro, il diverso. Sempre ci ferisce l’inaudita scoperta che qualcuno ha veduto, non mica più lontano di noi, ma diverso da noi. Siamo fatti di trista abitudine. Amiamo stupirci, come i bambini, ma non troppo». Scriveva così Cesare Pavese in un articolo intitolato Leggere, pubblicato il 20 giugno del 1945 su L’Unità di Torino e successivamente ripreso in Saggi letterari (Einaudi).
Lo stupore, stavolta assoluto, che accolse nell’estate del 1990 la pubblicazione sul quotidiano La Stampa di alcuni appunti inediti e privati di Pavese ad opera di Lorenzo Mondo, si trasformò fin da subito in aperta indignazione: lo testimoniano gli articoli (pubblicati sul quotidiano torinese), accesi e numerosi, raccolti alla fine del volume Il taccuino segreto, curato da Francesca Belviso e pubblicato da Aragno.
Ritrovate e fotocopiate da Mondo (gli originali non esistono più) si tratta di pochissime pagine di frasi taglienti, nette: critiche agli antifascisti, richiami all’ordine, al destino dei popoli, alla violenza, riflessioni amare sulla guerra, e un parallelismo tra il fascismo e la Rivoluzione francese. È la stessa Belviso a fornire in anticipo gli strumenti per avvicinarsi a quelle parole: l’attrazione di Pavese per Nietzsche che, secondo molti, collocherebbe il suo pensiero ai confini del superomismo, e la necessità di leggere insieme al taccuino anche il diario Il mestiere di vivere, per capire, contestualizzare, quasi scagionare lo scrittore. È il 1990 e le parole di Pavese, infatti, offendono e stupiscono, e le ragioni sono sicuramente attribuibili al momento: la caduta del muro di Berlino, la disgregazione in Italia dei partiti storici, la fine della Prima Repubblica, la dissoluzione delle ideologie e dei loro miti. E la presenza sulla scena culturale e politica italiana di chi aveva personalmente conosciuto e frequentato Pavese.
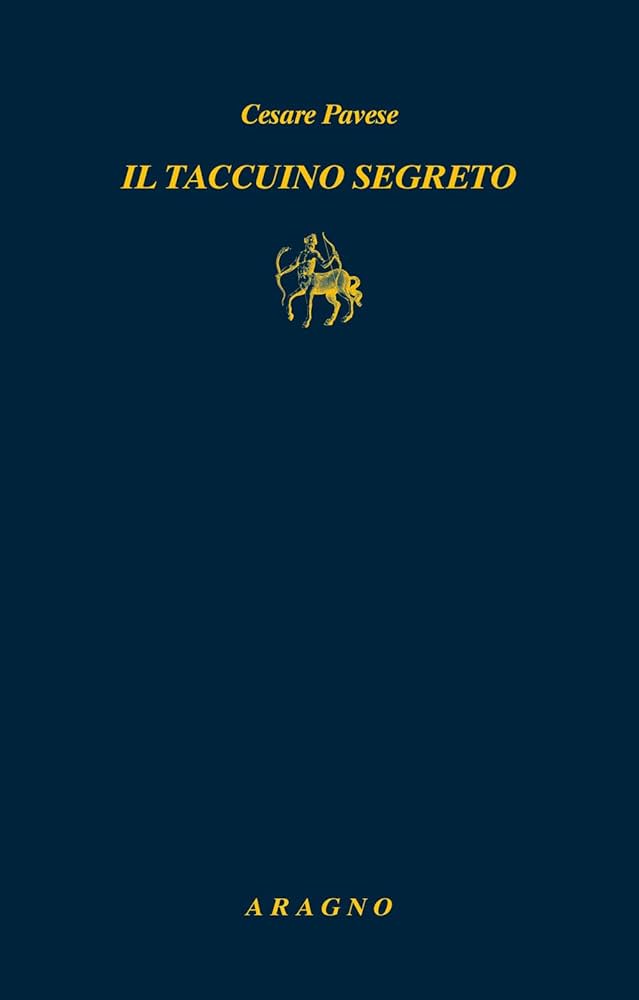
Queste note, scritte con una grafia densa, appuntita, e racchiuse tra le righe di 29 fogli a quadretti, risalgono al 1942: il volume le mostra nell’appendice finale come immagini in bianco e nero, e ciò permette di avere un’idea, seppur solo visiva, dello spazio che queste parole hanno occupato nella vita di Pavese.
L’intera vicenda del ritrovamento degli appunti, raccontata dallo stesso Lorenzo Mondo e ricostruita nell’introduzione di questo volume, è interessante per varie ragioni: la prima ha a che fare con il desiderio di frugare nel privato, nei pensieri nascosti, spesso colpevoli e contraddittori degli scrittori, o almeno degli scrittori famosi. Nel caso di Pavese esiste da sempre una straordinaria coincidenza tra la scrittura pubblica e la parola intima, laddove si intenda per intimo non solo ciò che è segreto, non destinato a essere stampato (come questo taccuino), ma soprattutto ciò che sfugge all’immagine, alla luce, che vive e sopravvive nell’ombra. E le ombre di Pavese sono state (e sono tuttora) oggetto di un interesse viscerale, perché capaci di mostrare a tutti ciò che riteniamo inaccettabile e indicibile.
La seconda ragione è legata al bisogno, altrettanto umano, di far luce sull’oscurità della Storia, ricostruendola e osservandola, ma sempre a una comoda distanza; quella stessa comoda distanza che a teatro permette di sentire le assi di legno scricchiolare sotto il peso degli attori, ma che ricorda, al momento opportuno, chi appartiene allo spazio scenico e chi invece resta a guardare. Non è allora tanto il bisogno di comprendere il fascismo, la guerra, la Resistenza, le lotte partigiane (ossia afferrare tutte queste cose con l’intelletto, la ragione) a rendere il Taccuino interessante, quanto vivere, sentire, provare ciò che è stato vissuto, sentito, provato, possibilmente attraverso le parole nascoste, private perché considerate più autentiche, più aderenti alla realtà. Dimenticando che anche la scrittura personale, quella per sé, può essere talvolta inconsapevolmente contaminata dall’irriconoscibilità dei propri pensieri.
E se è vero, come scrive Angelo d’Orsi nell’introduzione, che i tentativi di appropriazione ideologica del pensiero pavesiano – e in generale della sua figura – si sono susseguiti e intensificati, occorre ricordare quanto essi siano figli indolenti delle loro epoche. E non c’è colpa più grande per chi legge dell’indolenza.
«Accade coi libri come con le persone. Vanno presi sul serio. Ma appunto per ciò dobbiamo guardarci dal farcene idoli, cioè strumenti della nostra pigrizia», scriveva ancora Pavese nel suo articolo Leggere, quasi riprendendo le parole di Flaubert che in Madame Bovary consigliava di non avvicinarsi mai troppo agli idoli.
Se esiste una terza ragione, infatti, che rende interessante la storia del taccuino, essa risiede nel nostro rapporto con la lettura.
Leggere è un atto complicato, tutt’altro che rassicurante, ed è ancora Pavese a ricordarcelo: «Si parla di libri. Ed è noto che i libri, quanto più schietta e piana la loro voce, tanto più hanno costato dolore, tensione a chi li ha scritti. Inutile quindi sperare di scandagliarli senza pagare di persona». E se ciò appare vero per i libri viene da chiedersi quale sia, invece, il prezzo da pagare per inoltrarsi nei pensieri.
Bisognerebbe lasciar riposare chi non c’è più, come scriveva in un eccesso di affettuoso pudore Natalia Ginzburg sulle pagine del quotidiano torinese per placare i contrasti aspri, indignati (figli inevitabili della loro epoca) causati dalla pubblicazione del taccuino. O quantomeno non processare Pavese per azioni mai commesse: «ma la vita d’un uomo è vasta, ed è fatta di istanti dei quali non sappiamo nulla, di atti nobili e meno nobili, di pensieri scritti in qualche lettera o in qualche quaderno, poi contraddetti da nuovi pensieri o dal comportamento nel corso degli anni». Meno personale l’opinione di Gianni Vattimo che prende le distanze sia dallo stupore suscitato dalla pubblicazione del taccuino, sia dal ritratto da eterno adolescente, incostante nella vita quanto nelle idee, che la Ginzburg traccia di Pavese; il ritrovamento degli appunti, infatti, ci mette di fronte a un problema diverso, quello del «Giudizio storico che non è tanto e anzitutto il nostro, retrospettivo, su Pavese; ma quello di Pavese entro le sue concrete dimensioni storico-esistenziali».
Al tradimento privato di alcuni, percepito, tra gli altri, da Fernanda Pivano, che non riconosce in quelle parole il suo Pavese, il professore che spiegava il New Deal, l’«antifascista puro» che frequentava casa sua, si intreccia il biasimo pubblico di molti, che risveglia la questione dell’impegno politico degli intellettuali. Se da un lato persiste la delusione intima di chi ammette di non aver mai conosciuto fino in fondo Pavese, dall’altro avanza il tentativo di quantificarne il coinvolgimento politico. Davide Lajolo scrisse, nella biografia Il vizio assurdo (minimum fax, 2020), che Il mestiere di vivere nasce con lo scopo di essere dato alle stampe solo dopo la morte dello scrittore proprio, «per infierire un’ultima volta contro se stesso, e come un attore capace delle più perfette metamorfosi, per rendersi irriconoscibile a chi credeva di averlo compreso nella vita».
Quello tra Pavese e la politica è un rapporto complesso, ma mai taciuto: anzi, sempre presente nelle sue opere. «Tutti sanno che io non mi sono mai occupato di cose politiche, ma ora pare che le cose politiche si siano occupate di me», scrive alla sorella Maria il 24 giugno del 1935, dal carcere di Regina Coeli: è solo l’inizio di una condanna che lo condurrà al confino, a Brancaleone, a stendere lettere amare, strazianti, persino ironiche sulla sua condizione di vittima inconsapevole del fascismo.
Dell’amarezza di quel periodo rimangono tracce evidenti in Il carcere e Il compagno, con il protagonista di quest’ultimo che implora di poter fare una passeggiata per Roma, promettendo di tornare in cella, una volta dopo aver visto il Tevere. E proprio Il compagno, romanzo del 1947, contiene forse la frase che più spiega il legame tra Pavese e la libertà: «Non è star chiusi, la prigione, è l’incertezza».
Contro quegli anni, contro le «voci soffocate» contro le «chiassose giornate» dell’era fascista, contro quella che lui stesso definisce «assurda vita disoccupata e contratta» (Ritorno all’uomo, articolo pubblicato su L’Unità di Torino, il 20 maggio 1945, e raccolto in Saggi letterari, Einaudi), contrappone la distanza, il silenzio, il conflitto interiore ed esteriore, deluso e sconfitto, di chi ha pagato sulla sua pelle la condanna più dura.
Come ha scritto Giorgio Manganelli, l’antifascismo di Pavese «va oltre la polemica locale e immediata, ma è giudizio su tutta una società ed una cultura, incredibilmente goffe e provinciali, impermeabili a qualsiasi schiettezza di pensiero» (La critica di Pavese, in Altre Concupiscenze, Adelphi, 2022). Le sue opere, la sua scrittura sono una presa di posizione costante e continua contro il fascismo e i suoi mostri.
Molte le ombre che hanno accompagnato, persino sostituito, Pavese: è sempre Lajolo, amico e poi biografo, a mettere in guardia dall’illusione di comprenderle, senza però rinunciare alla necessità di illuminarle, «non chiudere gli scuri dove c’è ancora bisogno di far luce», come scrisse nel saggio Decadente è chi non lotta, raccolto nel volume Pavese e Fenoglio (Vallecchi editore, 1970).
Leggere Pavese ci costringe, da sempre, a fare uno sforzo costante, a guardarci allo specchio e a non riconoscere l’immagine che abbiamo creduto di avere, a dubitare della vita, degli altri, persino di noi; a osservare ombre, fragilità, contraddizioni. All’inizio potremmo esserne turbati, offesi, indignati, ma lo scopo non è provare orrore o sdegno, bensì comprendere, accettare. Ha ragione Lajolo a sottolineare la necessità di far luce, ma non su Pavese, su di noi, sulla nostra anima, sul nostro modo di osservare le cose, di intendere la vita e la cultura.
In copertina, dettaglio dell’illustrazione a cura di Manuele Fior di Le poesie di Cesare Pavese, Einaudi
