Parlare di Violette Leduc è entrare in un vortice creato dalla sua scrittura, un vortice che della vita fa battaglia e romanzo, azione e introspezione, attrazione e magnetica repulsione, e fa del sé un irrequieto oggetto che si muove nella storia, anche editoriale, del Novecento. Lo si comprende già nel volume di Antonella Tarabella La donna brutta. Vita e scrittura di Violette Leduc (enciclopediadelledonne.it, 2019), un tassello congegnato in modo perfetto – e che mancava agli studi sulle scrittrici –, preceduto senza dubbio dal pluriennale impegno di Carlo Jansiti sull’opera della scrittrice francese: dalla curatela di Violette Leduc. Correspondance, 1945-1972 (Gallimard 2007) fino a Violette Leduc. Biographie (Grasset 2013).
Un incessante lavoro di riscoperta della voce di una “dimenticata” è sostenuto ora dall’editore Neri Pozza che, nel 2021, ha ripubblicato Thérèse e Isabelle tradotto da Adriano Spatola, e poi La bastarda, con la traduzione di Valerio Riva, allora direttore letterario della casa editrice Feltrinelli che lo pubblicò per prima, nel 1965.

Il lungo legame con Simone de Beauvoir, che sostenne Leduc e scrisse la prefazione a questo libro, ma anche con Maurice Sachs, che le indicò la via e diventò anche uno dei suoi protagonisti, e l’amore non corrisposto per entrambi, focalizzano l’infelicità e le trame di un’esistenza che si snoda, fino agli anni Settanta, tra distaccamento e mondanità; sono queste le direttrici che stabiliscono i punti nodali di quella vita ancor più vera dove diventa narrazione.
«Donna brutta» e «bastarda» Leduc fu in grado di concepire un «romanzo incendiario» che «non è una cronaca memoriale, un romanzo di formazione, una ricerca del tempo perduto. È la trasposizione romanzesca di una vita», come leggiamo nella postfazione di Jansiti. La prosa autobiografica de La Bâtarde avviluppa, grazie a una densità centrifuga che muove il testo, riportando nelle dimensioni lontane dell’esistenza, dall’infanzia all’età adulta di Violette.
Con una vicenda all’apparenza semplice Leduc reinventa l’idea di autobiografia «falsificando[la]» (Jansiti), parla di sé costruendo una prosa dal movimento centrifugo che, dove spinge tematicamente sull’amore centrale in questo libro – sia l’amore lesbico sia quello eterosessuale ma anche il complesso rapporto col materno –, accoglie una sensibile precisione e scelta della parola.
La sua è una scrittura che volando resta in volo, che non perde ‘la dinamica del giorno’ e che abbraccia un’emotività lacerante, impregnata di solitudine, di rinuncia e di abbandono, temi, cifre e stile insieme. Non ci sono intercapedini per i sentimenti umani nel caso di Violette Leduc poiché essi si librano, in perfetto trasferimento, nella parola autoriale; vengono restituiti nudi, concentrati di una passione irriducibile.
La prosa di Leduc sconfina verso tutte le dimensioni spaziali: l’orizzontale della narrativa, il verticale della poesia e l’obliquo in cui si attua una sintesi. È una scrittura che apre e crea senza volontà di erigere e, in questo, risulta priva di sovrabbondanza – pur essendo il testo del romanzo corposo. L’ordito si elabora di immagini inaspettate, in cui il mentale continua a tessere, a lavorare, creando degli anfratti, che sono carne e corpo, come in una delle scene del collegio, in compagnia della compagna Isabelle:
«La mano si posò sul mio collo. Un sole invernale sbiancò i miei capelli. La mano seguiva le vene, scendeva. La mano si fermò. Il mio polso ora batteva contro il monte di Venere della mano di Isabelle. La mano risalì, abbozzava dei cerchi. Sconfinava nel vuoto, allargava onde di dolcezza attorno alla mia spalla sinistra, mentre la destra restava abbandonata alla notte zebrata dal respiro delle allieve. Scoprivo il velluto delle mie ossa, l’aura della mia carne, l’infinito nelle mie forme. La mano indugiava, traeva seco sogni fumosi. Il cielo mendica, quando qualcuno ti accarezza la spalla: il cielo mendicava. La mano risaliva, mi rivestiva d’un corsetto di velluto sino al mento, la mano convinta ridiscendeva; sottolineava, ridisegnava le curve. Infine fu una pressione affettuosa. Presi Isabelle tra le braccia, ansimavo di riconoscenza.»
La vestizione che Leduc racconta racchiude in sé molteplici significati: è scoperta dei corpi ed è loro incontro erotico. È sorellanza con altre figure femminili, vera di nuovo nel respingimento con il materno (rappresentato dal personaggio della madre Berthe) ma anche scrittura multidimensionale, dal corpo al vuoto, al cielo, con una specificazione peculiare su quest’ultimo: l’insistenza del verbo “mendicare”, che riporta a una considerazione dell’io privo di qualità – e ancora all’abbandono come tematica autoriale – producendo una verticalità poetica inaspettata.
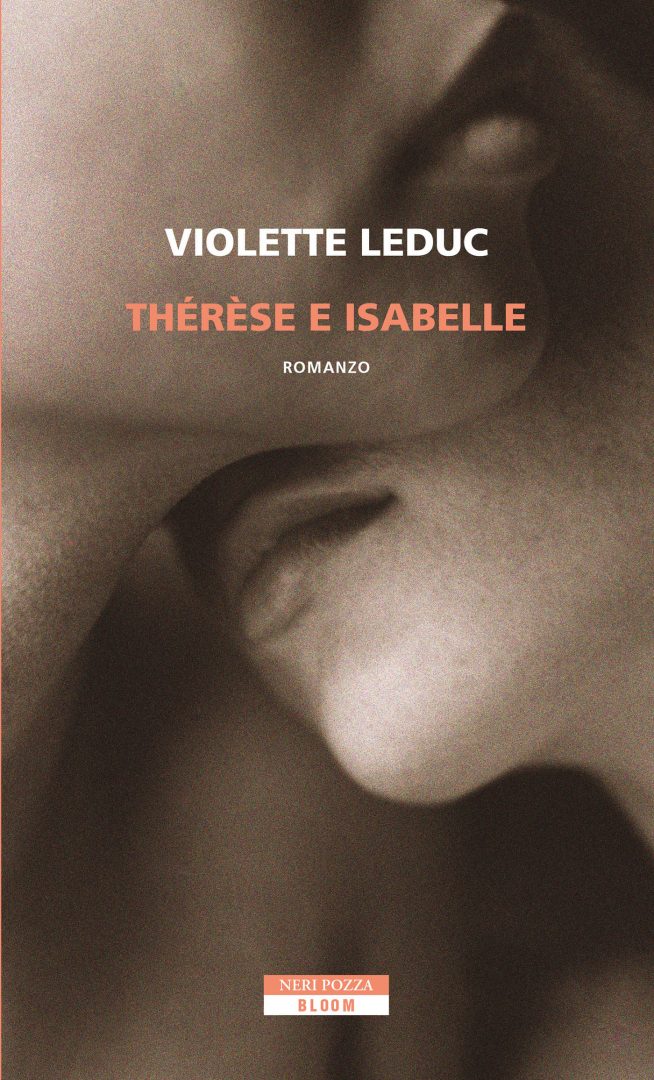
Cosa urla e cosa resta muto nel testo di Leduc, allora? Carlo Jansiti, nel volume di Neri Pozza, parla di un’idea fissa in lei, espressa in La follia in testa: «Scrivere è liberarsi. È falso. Scrivere è non cambiare nulla», rimarcando la prevalenza del vero e del reale sopra ogni cosa. Leduc è una scrittrice che resta estranea all’immaginazione e lavora su un piano di realtà cui aderisce interamente, poiché la realtà è la sua etica della scrittura. Ancora Jansiti parla di Leduc come «estranea alla norma sessuale. È androgina. È una scrittrice pionieristica», che de Beauvoir aiuta suggerendole il modello di racconto autobiografico secondo una cronologia, poi diventato una «spietata requisitoria contro di sé e al tempo stesso una redenzione».
«Je suis un désert qui monologue», scrisse Leduc di se stessa, come ricorda ancora il suo critico: dunque il suo essere desertico (spaziale), la sua figura così potente per la letteratura dell’epoca è stata in grado di mettere al mondo delle eredi? Andiamo a verificarlo con una ricostruzione filologica di alcuni aspetti che riguardano Leduc pubblicata in Italia negli anni Sessanta (che rimanda a uno studio antecedente).
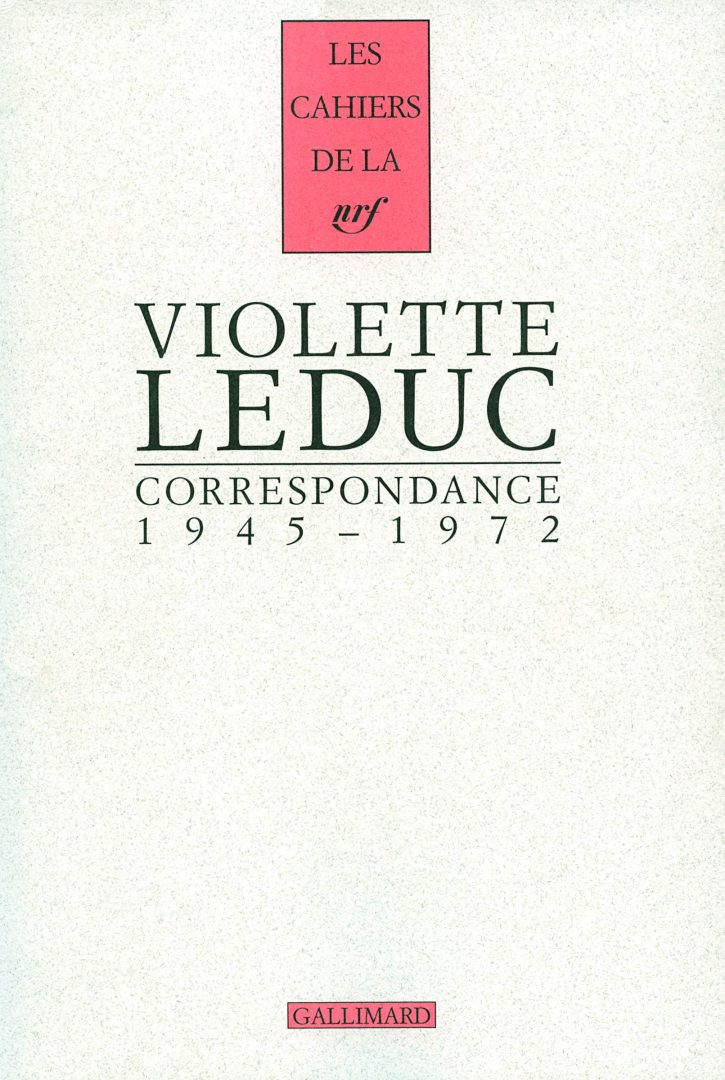
Durante il biennio 1964-1965, La Bâtarde registrò un’esposizione mediatica di Violette Leduc sotto la lente dei riconoscimenti letterari francesi, sia in patria sia nel nostro paese, come evidenzia già Jansiti. La seguirono da vicino alcuni dei principali quotidiani italiani, che dibatterono attorno alla sua candidatura al Prix Goncourt e al Prix Fémina. Purtroppo lei non vincerà alcuno di essi, assegnati rispettivamente a Georges Conchon con L’État sauvage (éditions Albin Michel) e a Jean Blanzat con Le Faussaire (éditions Gallimard), quest’ultimo proprio con lo stesso editore di Violette Leduc. Sandro Volta su La Stampa, nel dicembre ’64, rivendicò due fatti: la vittoria del Fémina di Blanzat per evitare scandali, attribuendo lui stesso comunque a La Bâtarde la definizione di «audace e forte romanzo», e l’affermazione di Monique Witting con il prestigioso Prix Médicis, che rivelava – tuttavia – l’allineamento della giovane autrice allo stile prevedibile del Nouveau Roman di Robbe-Grillet, del tutto lontano da Leduc. Sandro Volta difese nuovamente questa posizione (il 5 dicembre ’64), provando come le autrici francesi di punta dell’epoca, da de Beauvoir a Elsa Triolet, non avessero ancora vinto il Fémina, e aggiungendo:
«anche quest’anno, che avrebbero potuto premiare il libro di una donna, Violette Leduc, autrice de La Bâtarde, un libro cioè che si distacca nettamente da tutta la produzione editoriale dell’annata, hanno preferito l’opera di uno scrittore sessantenne, che pubblica romanzi da trent’anni senza essere mai uscito da una dignitosa mediocrità.»
Il contesto in cui Leduc giunse al successo presso il pubblico, nonostante il rifiuto dell’ambiente intellettuale francese, parve determinare anche il passaggio al mercato editoriale italiano, in cui fu accolta nel catalogo Feltrinelli, collana I Narratori con il titolo La bastarda. Romanzo autobiografico, il volume usciva nell’ottobre 1965, con una seconda edizione già nel novembre 1965. Ebbe dunque un successo considerevole. Inoltre Giangiacomo Feltrinelli – e Valerio Riva – immettevano Leduc in un catalogo in cui figuravano già Nathalie Serraute, Doris Lessing, Magda Szabò, poi Lia Wainstein, Elisabeth Mann Borgese e altri autori ma pochissime autrici, come vediamo. Ciò basterebbe a definire la statura del dibattito in suo favore, a metà anni Sessanta, anni in cui la crisi del romanzo era molto sentita in Italia e in cui lei svetta in traduzione.

Ma fu Leduc una scrittrice determinante dentro il proprio tempo? Una scrittrice le cui tracce sono evidenti anche in altre voci?
Carlo Jansiti ha parlato, per La bastarda, di «numerosi spunti metanarrativi come testimoniano le apostrofi al lettore, il rinvio a testi apparsi in precedenza e le diverse riflessioni sul ruolo della scrittura», tratti di stile tipici – non i soli – anche della prima versione di Lettera aperta di Goliarda Sapienza, scritta proprio in quegli stessi anni. Probabile dunque che la scrittrice siciliana conoscesse il romanzo di Leduc (come argomentato in un articolo pubblicato qui). Nel 1982, in effetti, scriverà proprio di sé a Sergio Pautasso di Rizzoli, prima dell’uscita de L’università di Rebibbia per lo stesso editore:
«Caro Pautasso, le invio alcune cose (pubbliche) della mia non breve vita che, per la curiosità del lettore, si prestano a creare, come lei mi ha detto di volere fare, un personaggio almeno “diverso” nel panorama delle nostre tante scrittrici valide ma pur sempre “timorate di Dio”, che affollano la nostra cultura, un personaggio per intenderci più vicino alla Violette Leduc che a Natalia Ginzburg, come Adele Cambria più volte ha ripetuto sui giornali e alla radio.»
(ora in Lettere e biglietti, La nave di Teseo, 2021)
Un parallelo, questo, che ricolloca due delle scrittrici ristampate in questi ultimi anni su un terreno di scambio comune, muovendo lettrici e lettori alla scoperta dei tanti fil rouge tra loro e altre voci di donne da rileggere.
