Heathcliff – l’oscuro antieroe di Cime tempestose – ossessionava il giovane Beppe Fenoglio. Negli Appunti partigiani Fenoglio scrive che «Heathcliff» avrebbe potuto essere il suo nome di battaglia da partigiano e che avrebbe insegnato a tutti a pronunciarlo, adducendo che la sua fidanzata un giorno gli aveva detto che somigliava proprio al tremendo ma romanticissimo Heathcliff.
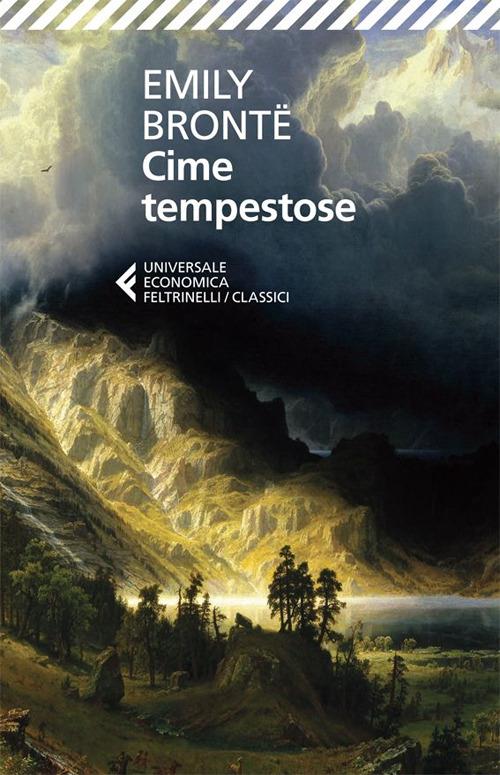
Fenoglio come Heathcliff, dunque, e l’accostamento può stupire. Heathcliff è un uomo duro, spietato, a tratti un mostro, che deve il suo nome a un bambino morto in fasce e che perciò è forse più prossimo alla morte che alla vita. Heathcliff non è al riparo dal Male, dai gorghi dell’ossessione e della vendetta che possono dannare tutta un’esistenza e portarla alla miseria e al delitto morale della crudeltà. Fenoglio invece, perlomeno stando ai suoi scritti e alla sua biografia, era un uomo retto, un partigiano, con un forte senso della parola e della lealtà. Una figura a sua volta tormentata, certo, un romantico scontroso come diversi suoi personaggi, e tuttavia non roso dalla dissennatezza del rancore come l’Heathcliff di Emily Brontë. E allora perché Heathcliff lo affascinava tanto, fino a riconoscervisi? Per quale ragione Cime tempestose è stato uno dei grandi libri della sua vita?
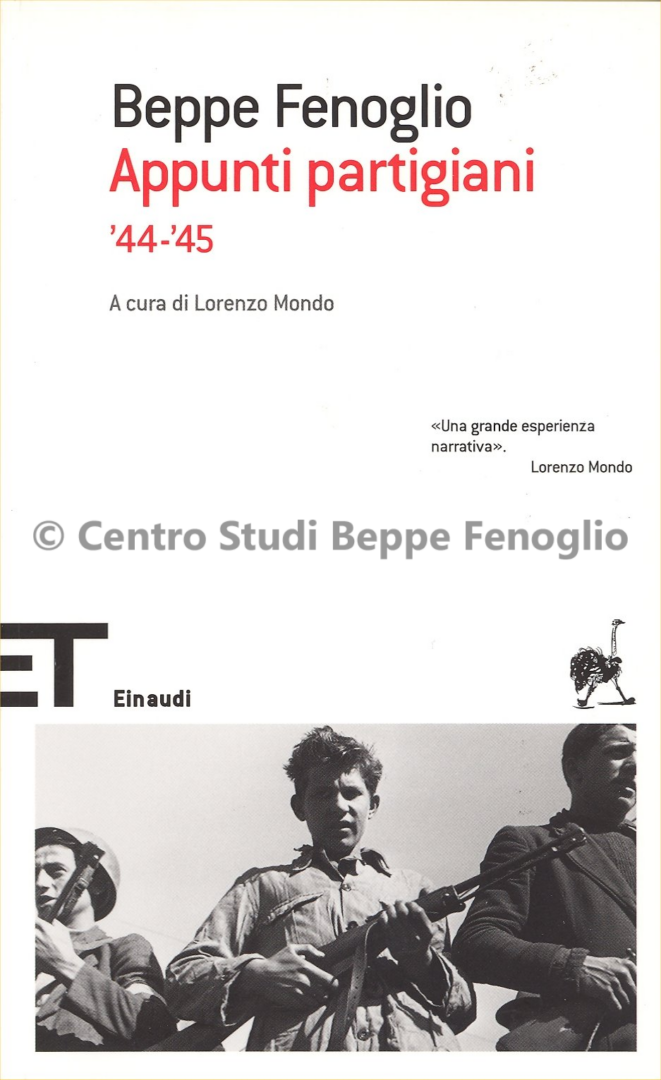
Un raffronto fra il capolavoro di Brontë e le opere di Fenoglio ci sembra facile e forse pretestuoso. Potremmo osservare, per esempio, che la passione del protagonista di Una questione privata(1963), Milton, è votata alla solitudine e alla morte come la terribile derelizione di Heathcliff. D’altronde entrambi i personaggi inseguono un fantasma incarnante un amore impossibile, che sia Catherine o Fulvia attraverso l’amico Giorgio. Si sa anche che Fenoglio aveva lavorato a lungo sul tema brontiano dell’amore disperato, arrivando perfino a scrivere un testo teatrale (La voce nella tempesta) tratto da Cime tempestose. Poi c’è la Malora (1954), il suo primo romanzo edito, con un altro amore impossibile e le langhe che assurgono a vere e proprie “protagoniste” del libro, come la brughiera e il vento e la pioggia in Brontë.
Dopo la sepoltura del padre del narratore, Fenoglio scrive:
«Quando uscimmo di chiesa il tempo s’era girato: il sole era andato a nascondersi e al suo posto c’era il vento; un’ariaccia che arruffava le coperte sulla cassa e una volta che fummo fuori del paese spense i ceri delle carmelitane».
E Brontë scriveva (nella traduzione di Cime tempestose di Laura Noulian, Feltrinelli):
«Un pomeriggio di fine ottobre, o forse dei primi di novembre, un pomeriggio scialbo e fresco, con i prati e i sentieri fruscianti di foglie morte e umide e il cielo azzurro e freddo mezzo nascosto dalle nuvole, vedendo i cumuli grigio scuro che si ammassavano a occidente, lasciando presagire acqua a catinelle…».
I paesaggi tempestosi di Wuthering Heights non sembrano distanti dalle langhe di Fenoglio. Tuttavia quelli che potremmo definire gli “insegnamenti di Heathcliff” per Beppe Fenoglio sono stati altri e forse può profondi e decisivi.
Fenoglio esordisce nel 1952 con una raccolta di racconti pubblicata da Einaudi, I ventitre giorni della città di Alba. Il libro, che avrebbe dovuto intitolarsi prima Racconti della guerra civile e poi Racconti barbari (il titolo definitivo fu imposto dall’editore), venne accolto favorevolmente dalla critica più preparata, specie da Pietro Citati, Anna Banti, Carlo Bo, Giambattista Vicari e Giuseppe De Robertis. Si rimarcò soprattutto l’eccellenza dello stile, rara per un esordiente. Ciononostante un’altra parte della critica, quella che Elio Vittorini definì la stampa “comunista”, attaccò a più riprese il libro.
Giorgio Guazzotti, sull’Unità, scrisse che i personaggi di Fenoglio «si accaniscono contro se stessi, contro ciò che hanno fatto, contro la loro condizione umana, perché manca loro una prospettiva, un obiettivo che vada al di là di loro stessi e che dia un senso di continuità alla loro vita» – e queste parole potrebbero riguardare non soltanto i personaggi di Fenoglio ma anche lo stesso Heathcliff di Cime tempestose, il suo dibattersi di continuo fra la solitudine del disamore e la desolazione di una vendetta ormai impossibile. Qualche mese dopo Davide Lajolo rincarerà la dose, sia pure anonimamente, sempre sull’Unità: a suo avviso la pubblicazione del libro di Fenoglio sarebbe un «brutto capitolo nella letteratura della Resistenza», giacché i personaggi dei suoi «ignobili» racconti combattono «per avventura» o addirittura «per niente o per nessuno», senza morale né idealismi – e anche qui, sebbene con qualche forzatura, possiamo pensare al brutale disincanto di Heathcliff dopo la morte di Catherine, quando ormai ogni possibilità di redenzione è perduta. Pure Heathcliff non ha più ideali. Uno dei personaggi di Fenoglio, Max, un condannato a morte, dice: «Tu te la senti di morire per l’idea? Io no. E poi che idea? Se ti cerchi dentro, tu te la trovi l’idea? Io no. E nemmeno tu.» La sola idea che possa salvare Heathcliff è il ricordo di Catherine; il condannato a morte di Fenoglio non ha neppure quello.
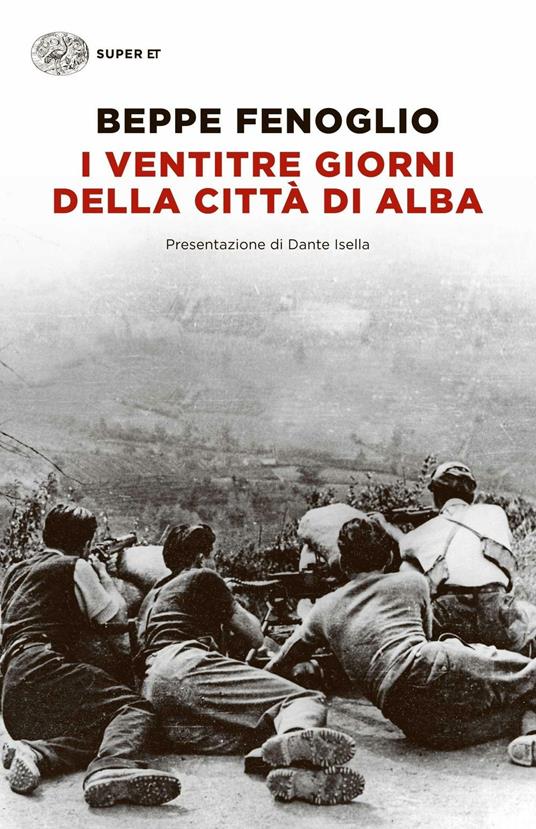
Ma il primo Fenoglio è anche un eccellente scrittore comico, e forse è soprattutto questo a non andare giù alla critica più ideologizzata del dopoguerra: i suoi partigiani sono goffi, sboccati, brutali, talora ingenui e perfino infantili, ridicoli nei loro piccoli impacci umani. Non sono affatto delle figure ideali e occasionalmente possono rivelarsi dei vili. Di certo sembrano impreparati, come se la Resistenza fosse un gioco fra ragazzi inadatti alla vita che combattono per mero sfizio dell’avventura e non (come avrebbe voluto Lajolo) per la libertà o per un ideale. Qual è in fondo la differenza fra i gerarchi fascisti che si impantanano nel fango e i partigiani che vanno ad aiutarli per parlamentare, fino a caricarseli sulle spalle? Non fanno tutti parte della stessa recita improvvisata fattasi racconto, tentativo di un’epica resistenziale?
Le vicende di Alba, che poi saranno riprese nel postumo Il partigiano Johnny (1968), nel racconto I ventitre giorni della città di Alba sono descritte con quella che Nicola Chiaromonte avrebbe potuto definire una tecnica «frammentaria». In Credere e non credere (1971) Chiaromonte infatti oppone la Waterloo de I miserabili a quella de La Certosa di Parma.
«La differenza principale tra la descrizione di Victor Hugo e quella di Stendhal» scrive, «è che, mentre per Stendhal la battaglia di Waterloo nel suo insieme non esiste, o comunque rimane inafferrabile, per Victor Hugo, invece, essa deve essere esistita e aver posseduto la dignità di evento unico e fatale. Per Fabrizio Del Dongo, si potrebbe dire, la battaglia di Waterloo non può esistere nel suo complesso per la ragione molto semplice che egli la vive nel presente e ne è parte, quindi non può vedere che i frammenti che ne sprizzano fino a lui.»
Ciò che vale per l’eroe della Certosa vale ugualmente per i partigiani di Fenoglio: la Resistenza viene narrata per frammenti (anche comici, come si è visto), senza nessuna grandiosità. Così i partigiani possono rivelarsi degli scrocconi, degli ubriaconi, dei ladri, comunque dei ragazzi che sembrano combattere più per caso o per brama di eroismo che per convinzione. Quando il giovane Raoul incontra per la prima volta Marco, un famoso partigiano, lo trova in pieno amplesso, mezzo nudo, fra le cosce di una ragazza. Più tardi il giovane si arrovellerà fra i pensieri più neri, di notte, «nei quali dava la colpa ai partigiani che non erano come lui li aveva immaginati e poi, siccome coi partigiani non poteva sfogarsi e con se stesso invece sì, dava la colpa a sé che aveva sbagliato a immaginarli». Lo spaesamento di Raoul potrebbe fare il paio con quello dei primi lettori di Fenoglio, che lo accusavano, per così dire, di lesa maestà partigiana. Negli anni Cinquanta la Resistenza era una cosa sacra. Come poteva questo Beppe Fenoglio, lui stesso un partigiano, scriverne in tal modo? E come si permetteva Einaudi di pubblicarne i libri?
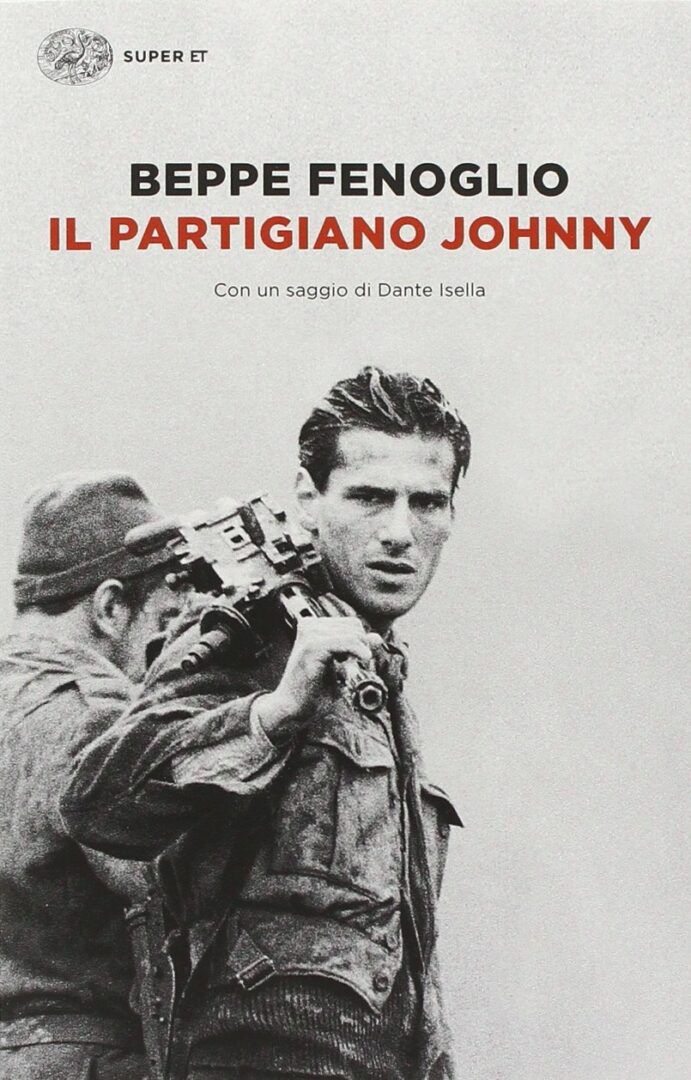
«Stupisce che Einaudi abbia accettato I ventitre giorni della città di Alba nella sua collezione» chiosava ancora Davide Lajolo, nella sua stroncatura. «Le Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana parlano un ben altro linguaggio da quello usato da Beppe Fenoglio.» Di più: l’esordio di Fenoglio sarà criticato aspramente anche da chi gli era assai vicino, come Pietro Chiodi, partigiano, amico di una vita, che pure pubblicamente lo giustificherà ma che non potrà fare a meno di osservare: «Se processeranno ancora qualche fascista, potrà portare in aula, a sua discolpa, una copia dei Ventitre giorni». Fenoglio si difenderà con queste parole: «La libertà e la democrazia ogni generazione se la deve conquistare, e duramente. Non si possono insegnare nei libri» – poiché i suoi personaggi non possono essere dei modelli comportamentali per i lettori, dei fantocci perennemente in posa per mettere in guardia le generazioni future dal pericolo fascista. La letteratura di Fenoglio non è didascalica né propagandistica. Perciò la sua lezione ci è preziosa.
Il punto – e qui torniamo a Emily Brontë – è che gli eroi di Fenoglio sono «maledetti piuttosto che benedetti», per riprendere un’espressione di Nadia Fusini[1] riguardante proprio i personaggi di Cime tempestose. Anche questo è un insegnamento di Heathcliff, della sua terribile oscurità. L’uomo, soprattutto l’uomo novecentesco e di conseguenza anche noi, è scisso fra il bene e un male che il bene non può disconoscere, perché bisogna lasciare all’ideologia ogni facile semplificazione morale. D’altra parte quando uscì il capolavoro di Brontë i critici si lamentarono per la sua cupezza e la sua violenza, oltre che per il fatto che Heathcliff, l’eroe, non si redimesse, togliendo così al lettore ogni parvenza di lieto fine. Allo stesso modo il primo Fenoglio, pur con dei tratti spesso più comici, fra le langhe e non nella brughiera brontiana, si rifiutava di abbellire i suoi partigiani per sottostare ai dettami della morale corrente, cioè della moda antifascista. Pure per questo era e resta uno dei nostri scrittori più grandi. Le sue pagine migliori sono ancora oggi meravigliose e importanti per ciò che raccontano e per come lo raccontano, per il rifiuto di ogni dogmatismo sapienziale, giacché scrivere è una questione tanto di stile quanto di coraggio, lo stesso coraggio che – nelle desolate lande dello Yorkshire – rese Emily Brontë la grande scrittrice che era e che Fenoglio tanto amava leggere.
[1] In Nomi, Dieci scritture al femminile (Donzelli, 1996).
In copertina: foto di Aldo Agnelli, Archivio Centro Studi Beppe Fenoglio
