Fin da quando ero bambino faccio una strana collezione: le ultime parole pronunciate da uomini eminenti prima di morire. Dopo quelle di Gesù, le prime a colpirmi furono quelle di Giulio Cesare: quel grido di stupore e protesta vedendo il coltello fra le mani di Bruto – che già con quel nome si raccomandava alla mia infantile esecrazione.
Poi ne sono arrivate tante altre, quelle sublimi di Goethe («Fate più luce!») o di una sfilza di musicisti da Beethoven a Schubert a Chopin. Amatissimi i congedi in cui il personaggio si conferma uguale a se stesso con un ultimo guizzo beffardo. Voltaire, al prete che durante l’estrema unzione gli chiede secondo liturgia: «Figliolo, rinunzi a Satana e ai suoi seguaci?», ribatte: «Giovanotto, non mi sembra il momento di farsi dei nemici, questo». Rido adesso mentre lo scrivo! Oscar Wilde riprende conoscenza per un attimo, guarda la parete davanti a sé, geme: «O se ne va questa tappezzeria o me ne vado io», e spira.
E il mio adorato Poe, nato il 19 gennaio del 1809, 150 anni esatti prima di me? Quando lo coglie un attacco di delirium tremens, a quarant’anni, è a Baltimora, un giorno in cui i suoi amici credevano fosse altrove. Si sente male per la strada e viene ricoverato in una casa. Anche lui torna in sé solo per pochi istanti e pronuncia un’ultima frase.
È paradossale parlare della morte di Edgar Allan Poe, perché questo artista immenso è vivo fra noi, oggi più che mai.
Poe è l’unico scrittore pop che l’Ottocento ci ha lasciato. Quando un artista (o uno sportivo, un politico…) diventa pop? Quando sfonda il muro che delimita il pubblico degli addetti ai lavori e fa ingresso nel mondo di tutti. Per essere pop bisogna avere una faccia e un nome. Ebbene, tutti conoscono Edgar Allan Poe, perfino quelli che non l’hanno mai letto – perfino quelli che non leggono affatto. Lo conoscono i ragazzini che non hanno mai avuto fra le mani le sue pagine ma hanno trovato le sue grandi storie nei fumetti, nei film, nei videogiochi.
La sua fisionomia è subito riconoscibile, e provate a pensare di quale altro scrittore dell’Ottocento si possa dire una cosa simile; oltre a tutto un autore del primo Ottocento, un uomo morto nel 1849. La fronte alta, svasata, pallida. Gli occhi infossati e malinconici, le labbra sottili, serrate.
Poe compare sulla copertina del celebre album Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, una sorta di assemblea condominiale dei grandi profeti ed eroi di ogni tempo. La sua onnipresenza nell’universo della musica giovane, e non giovane, vale un accredito a cui non si possono muovere obiezioni. Quante Discese nel Maelstrom, quante Cadute della Casa Usher nella musica lirica, strumentale, classica, rock. Quanti Corvi.
Fu un grande infelice, uno di quegli uomini che si caricano sulle spalle il peso del male di vivere per conto di tutti noi.
Nato a Boston da due attori, orfano a due anni. Adottato da un ricco commerciante di Richmond, John Allan, che non era in grado di capirne la precocissima intelligenza e sensibilità; non così la moglie di Allan, Frances, che però morì giovane come tante altre figure femminili amate da Edgar e sottratte anzitempo al suo affetto. Una vita inquieta tutta fatta di traslochi: prima dall’America all’Inghilterra, poi di nuovo in America fra molte città: Boston, Richmond, Philadelphia, New York, Baltimora appunto. Una vita dominata da un’estrema penuria di denaro. Il matrimonio segreto e scandaloso nel 1836 con la bellissima cuginetta Virginia Clemm, che aveva solo tredici anni, e che lo lasciò anche lei undici anni dopo, morendo. Un particolare che sembra uscito proprio da un racconto di Poe: erano così poveri che come sudario si dovette usare il lenzuolo che Virginia aveva portato nel suo corredo di nozze. Il marito non la fece aspettare molto. Morì solo due anni dopo.
D’altra parte immaginare Edgar Allan Poe vecchio è impossibile. Provateci: non sarebbe Poe! Anche questo è un tratto eroico che sta inscritto nel suo mito
Come ha osservato Henry Canby, «è un’ironia che Poe abbia inventato la detective story, che dà da mangiare anche a scrittori scadenti, e lui sia praticamente morto di fame». Ma in realtà il bostoniano dev’essere considerato l’iniziatore di ben tre generi letterari.
Anzitutto il giallo, nel senso appunto di detective story, di racconto che gira intorno a un enigma sanguinoso che dev’essere risolto. Poe ne fissa il canone con i racconti Sei tu il colpevole e in parte Lo scarabeo d’oro, ma soprattutto con le tre short stories che hanno come protagonista il primo detective della letteratura moderna, il cavalier Auguste Dupin: I delitti della rue Morgue; Il mistero di Marie Roget; La lettera rubata.
Lo schema narrativo di queste storie diventerà classico. Il mondo viene presupposto come ordine, un ordine che viene turbato da un evento traumatico – un omicidio, perlopiù. Mentre la polizia ufficiale arranca, compare sulla scena il geniale servo dell’ordine, il detective dilettante: guarda, osserva, scruta, trae le sue conclusioni interpretando quei dettagli in apparenza insignificanti che sono gli indizi, le tracce di bruciato lasciate da quella grande combustione che è il delitto. Il trauma viene ricostruito nel suo svolgersi. Il colpevole viene arrestato, l’ordine è ripristinato.
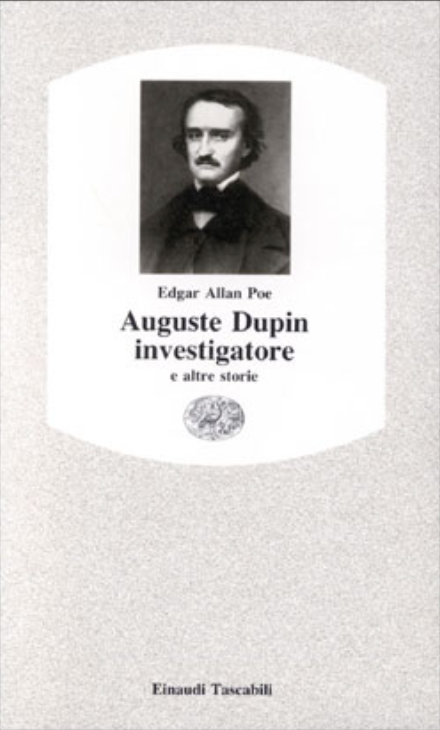
Ma attenzione: al genio di Boston non si deve solo l’opposizione fra detective dilettante e polizia, ma anche l’invenzione della coppia narratore-eroe. Il narratore, qui Poe stesso, ha la semplice funzione di registrare i fatti e di darne un’interpretazione consona a un’intelligenza media – la stessa dei poliziotti e dei lettori – insufficiente a coglierne l’essenza rivelatrice. L’eroe, invece, è appunto il detective, con il suo talento sovrumano. Ne viene fuori una triangolazione che funziona a meraviglia: con il narratore ci identifichiamo, ci è simpatico perché anche lui come noi capisce poco o nulla ma parteggia per il detective mentre la polizia ne è invidiosa; ma è sull’eroe che proiettiamo i nostri sogni di onniscienza e onnipotenza.
Arthur Conan Doyle avrebbe fissato per sempre il pattern con la sua coppia Watson-Holmes, tanto più rassicurante rispetto alla fede disperata nell’intelletto che Poe e il suo detective Dupin incarnano, al loro tentativo di ricondurre alla ragione quelle paure irrazionali che devastano altri eroi di altri racconti… e il loro stesso autore.
Sì, perché Poe codifica anche il noir: il racconto di un’azione criminosa visto dalla prospettiva non del detective ma del malvagio che la compie. Un’azione che presuppone il mondo come disordine, come caos dentro il quale il protagonista si sforza di elaborare un piano perfetto. È il caso di racconti come Il demone della perversità, Il cuore rivelatore, Il gatto nero. Il noir è l’altra faccia del giallo: lo scheletro della narrazione non è più l’indagine bensì, da un punto di vista cronologico, ciò che l’ha preceduta: il piano che il criminale ha ideato per compiere i suoi misfatti e non subirne le conseguenze. Un progetto destinato però a fallire. Alla fine, fatalmente, l’imperfezione del mondo divora la perfezione presunta del piano, e il protagonista si avvia al patibolo.
Non è quello che accade a tutti noi? La nostra vita non è un succedersi di tentativi ed errori, di sforzi per dominare un mondo magmatico? Per questo amiamo gli eroi neri, non solo perché realizzano le fantasie violente che abitano anche i nostri pensieri inconfessabili.
In questi racconti sono già presenti gli elementi tipici del terzo genere letterario che vede in Poe il suo santo patrono: l’horror moderno; o, se preferite, semplicemente l’horror.
Mentre in storie come La maschera della morte rossa, Metzengerstein, La fine della casa Usher troviamo gli ultimi, altissimi esiti del gotico settecentesco, con i suoi castelli, la sua aristocrazia minata nel sangue, le sue rovine, i suoi cavalli demoniaci, in racconti come Il seppellimento prematuro, o i già citati Il cuore rivelatore e Il gatto nero l’orrore sta dentro le case della gente comune. È sepolto nei muri, nelle cantine. È fatto di percezioni abnormi, di notti insonni, di sangue domestico.
Il soprannaturale, in Poe, assume il suo significato definitivo. È la proiezione di fantasmi interiori, è la coscienza tormentata del protagonista che si rende udibile, si fa suono: il battito impossibile di un cuore, il miagolio infernale di un gatto, le porte di una cripta che si schiudono, in lontananza.
Vogliamo esagerare? A Poe dobbiamo anche quello che non va considerato un genere ma piuttosto un formato narrativo: il racconto-saggio, che nel Novecento produrrà capolavori per mano degli autori sudamericani – Jorge Luis Borges e gli argentini in particolare.
Prendiamo di nuovo opere come Il seppellimento prematuro, o Il demone della perversità. L’inizio è lento, digressivo. Una voce, che ci pare quella dell’autore stesso, illustra un tema, lo argomenta. All’improvviso, la verità: la voce si rivela appartenere a un personaggio interno al racconto, e tutto ciò che è stato detto fino a quel momento confluisce dentro una storia personale, dai connotati drammatici.
Proprio nel Demone della perversità ci imbattiamo d’altronde nella più sbalorditiva descrizione di quello che Freud chiamerà prima masochismo mentale, poi pulsione di morte: quell’impulso autodistruttivo che il padre della psicanalisi, nel saggio Al di là del principio del piacere, metterà accanto alla libido come grande motore delle nostre vite.
Il celebre aforisma «la vertigine non è l’orrore dell’abisso, è l’attrazione per l’abisso» non è di Milan Kundera, come molti pensano. È di Poe e si trova in questo racconto, concretizzata in situazioni dalla forza narrativa irresistibile e dalla portata universale. L’uomo che si affaccia sulla voragine, certo, e che è perduto se comincia a immaginare la sensazione ineffabile della caduta. Ma anche quello che differisce fino all’ultimo un impegno improrogabile, rimanda, rimanda, rimanda finché è troppo tardi.
Poe, come molti grandissimi, suona per tutta la vita su una tastiera limitata, ma ne trae melodie ogni volta sorprendenti e varie.
Al centro di tutto troviamo la classica (e romantica) dicotomia fra Eros e Thanatos, libido e pulsione di morte, appunto. Manca qualsiasi accenno alla componente sensuale dell’amore: le sue figure femminili ci appaiono incorporee. In realtà, quando la fisicità del sesso preme per farsi sentire, lo sbocco narrativo che trova è piuttosto quello della violenza e della perversione: lo stupro al centro del Mistero di Marie Roget, trasposizione in ambito parigino di un fatto di cronaca newyorkese; il feticismo dei denti di Berenice che troviamo nel racconto omonimo, e che spinge il suo innamorato a strapparli dal cadavere dell’amata. Un feticismo parente dell’attrazione per i capelli di altre eroine di Poe, in prosa come in molte poesie. Non a caso queste parti del corpo, i denti, i capelli, sono prive di carnalità quasi quanto di vitalità. Si conservano nella tomba, e proprio quello è il luogo in cui l’amore del poeta sembra esprimersi con più ardore.
In Poe l’Eros si risolve in Thanatos, la morte prende il posto dell’amore, e il rimpianto per colei che se n’è andata diventa, in egual modo per il protagonista dei suoi racconti e delle sue liriche – The raven! – il sentimento predominante.
Oggi che tutto è diventato così veloce, che il tempo ci incalza e con lui distrazioni infinite, il peccato peggiore di cui la pagina scritta possa macchiarsi è annoiare il suo lettore. Ci sono libri nobili e fondamentali per la nostra storia e identità che probabilmente non verranno più letti, almeno non interamente, perché sono diventati un impegno troppo grande, per noi. Poe è agli antipodi dello scrittore dal passo lento e meditabondo: attira interesse a ogni riga, ci inchioda, ci incanta. E le sue storie sono meravigliosamente belle. Tutto qui.

Nella casa di Baltimora l’uomo dall’aspetto miserabile, che mani pietose hanno steso sul letto senza sapere chi sia, combatte la sua battaglia finale e disperata. La mente che ha concepito disegni immensi, esplorazioni degli abissi dell’anima, geometrie di bellezza assoluta, affiora solo per pochi istanti dal maelstrom che se la sta portando via. Seduti idealmente intorno a lui – come i grandi del regno che, nel racconto di Kafka Il messaggio dell’imperatore, assistono alla morte del più grande di tutti – generazioni di lettori si sporgono per coglierne l’ultimo sospiro. Quale frase geniale sarà l’epitaffio di questo gigante?
Poe socchiude gli occhi, nella penombra della stanza disadorna, e riesce solo a balbettare: «Mio Dio, mio Dio… abbi pietà della mia povera anima».
Only this and nothing more.
Non muore da scrittore. Muore come un contadino, una sarta, un’operaia, un muratore. Come nostro padre e nostra madre. Tutto ciò che doveva essere detto, e molto di più, quest’uomo l’aveva detto prima. Ora rimane spazio solo per la più indifesa delle preghiere: parole poverissime, ingenue. Disarmate.
È per questo che mi commuovono tanto?
