La prima volta che ho avuto in mano Disagiotopia (D Editore) mi trovavo in un bar di San Lorenzo a suo modo paradigmatico del venturismo. Ero accerchiato da rappresentanti del ceto intellettuale «troppo ricco per rinunciare alle sue ambizioni ma troppo povero per realizzarle» quando la cameriera, che poteva essere anche la proprietaria del bar, non ha potuto fare a meno di commentare l’apparizione di una parola per lei evidentemente familiare. «Disagiotopia… ma che è… qui se volete ce n’è un sacco, di disagio…» Come approccio al problema mi sembrava perfetto; buona parte della questione sollevata dal libro – terzo episodio della collana Escathon pubblicata dall’appassionato D Editore – sembra svolgersi del resto in una pervasività tanto astratta quanto immanente. Il disagio è appunto qui, al bar di san Lorenzo, nella testa della commessa-proprietaria, in Italia, ma anche un po’ ovunque – nelle particelle dell’aria, nel bisogno di pronunciare la parola per esorcizzare il disagio e allo stesso tempo evocarlo, secondo una logica fantasmatica cara ai derridiani.

Un po’ a corto di materiale terapeutico mi sono rivolto alla mia psicologa (apropos) dopo essermi accorto dell’uso ricorsivo dell’espressione nel corso di una seduta. «In effetti è una parola che uso molto. Mi aiuta a incominciare il discorso, definisce il primo strato di malessere da cui partire per andare poi avanti e capire meglio qual è il problema» – una definizione che qualcuno stigmatizzerebbe come negativa. Il disagio, per far finta di capirci qualcosa di più, sembrerebbe dalle sue parole una sorta di canovaccio di malessere, uno strato pre-terapeutico di infelicità: pervasivo ma anche condiviso, legato cioè davvero al sentire comune. Il riconoscimento che qualcosa di losco era già in opera e da chissà quanto al di sotto delle nostre esistenze, troppo impegnate e distratte per trovare il tempo di sbrogliare la matassa ma abbastanza deste per accorgersi che qualcosa non va. Un’indicazione però che sembra portarsi appresso notevoli problemi. Fin dove è comune questo sentire? E come liberarci di qualcosa che ancora non identifica l’accesso a una vera e propria malattia da curare?
Raffaele Alberto Ventura, a cui più volte era stato rimproverato di non svolgere una pars construens nel suo Teoria della classe disagiata (minimumfax, 2017), definisce il disagio un «effetto collaterale» della nostra contemporaneità. Ma è possibile risolverlo in quanto tale, venendo incontro alle probabili aspettative della cameriera/proprietaria? Proprio nel momento dell’umiltà epistemologica Florencia Andreola, curatrice della raccolta, non si trattiene dal portare la questione sul piano squisitamente terapeutico, prognostico. L’idea che sottende Disagiotopia è quella di attraversare esattamente questa pervasività nota (e ignota) della malattia custodendo dentro di sé l’intento in qualche modo di superarla, di identificarne gli effetti e forse addirittura le cause per uscirne diversi: una dichiarazione che appare però tanto dovuta quanto coraggiosa.
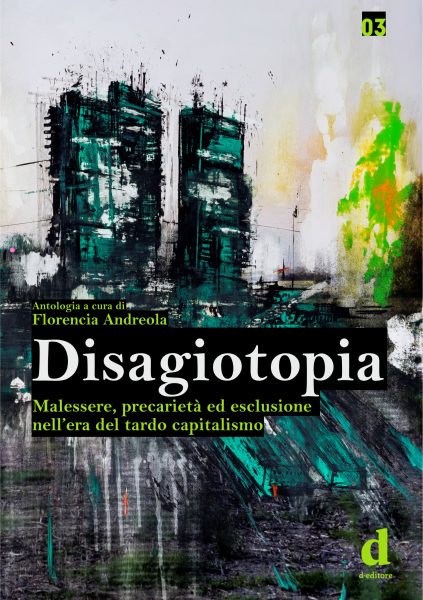
Poiché, come qualcuno avrà compreso, la natura di questo disagio sembra dover fare i conti con la sua invincibilità, è innanzitutto necessario operare almeno una distinzione. Da un lato è impossibile trattenersi dall’indicare una qualche via d’uscita, una speranza di gregge, dall’altro è necessario indagare i limiti di questa universalità del malessere. L’aspetto condiviso del disagio ci dice infatti quanto appartenga alla sfera sociale degli esseri umani, è il nostro disagio, dove il mal comune ha a che vedere con il nostro inserimento all’interno della sfera sociale come ambiente che ci completa, contraddistingue e che forse è capace persino di salvarci (via alla colonna sonora di Morricone). Per evitare di tradire l’intenzione di uscirne non credo si possa allora mettere da parte quest’aspetto: laddove il disagio è mio nascono presto le contraddizioni, laddove diventa nostro si intravede una speranza – una constatazione che suonerà buonista, mi rendo conto, ma che attraversa il libro per intero, magari in modo irrisolto ma senza dubbio con buone intenzioni.
Chi ha avuto familiarità con un processo psico-terapeutico (io pochissima) sa bene infatti che il momento dell’accettazione dei propri limiti non è troppo procrastinabile – il vecchio gnosi te auton, per intenderci. Del resto non è da questa fine delle illusioni che prende le mosse Disagiotopia? Quando si parla del mio disagio, ecco – per esempio quello di un maschio bianco trentenne eterosessuale italiano – non mi pare si possa parlare di miglioramento in alcun modo se non passando per questo momento di disillusione e disincanto. Questa raccolta di saggi muove oltre, è vero, una correttezza epistemologica obbliga gli attenti autori ad accogliere un mondo globalizzato e a ragionare su questa base, eppure credo che il lettore target del libro non possa eludere la questione di fondo che solletica lui in particolare, cioè che a lui solo si rivolge davvero. Vale a dire: di chi si sta parlando davvero qui? Chi è davvero il disagiato? È l’essere umano, nella sua condizione universale, o l’uomo (ricorro apposta all’espressione uncorrect) occidentale? E in maniera ancor più problematica: fin dove ci è possibile condividere questo disagio senza sentirci in colpa, senza che questo assuma le sembianze di una lagna? Un problema del genere può sembrare banale, e forse lo è, ma raggiunge il cuore dell’attualità non appena solleviamo il problema dell’empatia, e dell’ipocrisia, di chi giudica un sentimento di malessere dalla posizione del privilegiato, come per esempio durante i recenti riots seguiti alla morte di George Floyd negli Stati Uniti.

Per la vaghezza che il concetto si porta dietro, legata appunto al suo aspetto condiviso e pervasivo, nonché per il desiderio di «guarigione» che solleva immancabilmente, chi ha scritto di disagio in questo libro ha oscillato fra un malessere finto-universale, la sua versione occidentale, e il suo corrispettivo reale, appartenente a un essere umano, nella sua trasversalità, che forse non esiste ancora ma che in qualche modo viene auspicato – per una sorta di illuminismo definitivo, extra-vergine. Ed è vero che proprio in questa oscillazione, si è riusciti a in qualche modo tratteggiare consapevolmente o inconsapevolmente un vettore terapeutico. Il libro si muove davvero in senso intimo da Freud a Bauman, dall’uomo inserito in ogni società all’essere umano di questa società, attraverso la decostruzione del proprio io desiderante, attraverso l’identificazione delle aspirazioni dell’uomo occidentale e il riconoscimento del loro avvenuto cortocircuito. Ciò che forse dovrebbe interessarci davvero è ancora oltre, chissà dove (Baldwin? Fanon?), ma un sesto senso rimane attivo durante la lettura: il disagio dell’Occidente, se di mio disagio si tratta, è giunto finalmente al momento improcrastinabile dell’accettazione; il nostro disagio prevede invece una forma di uscita completamente diversa, che esonda dall’indagine, parafrasando Marx, e si inserisce a mio avviso nella sfera della politica, del vecchio ad-agio secondo cui è il mondo, prima e insieme a noi, a dover essere «cambiato». Questo non possiamo smettere di crederlo, e non è detto che non sia parte di un problema ancora più grande.
Il punto, infatti, è che le cose non sono così semplici.
È davvero difficile sintetizzare in poche linee guida la varietà dei luoghi scandagliati da Disagiotopia, e l’interesse che suscita è spesso legato alla profondità più che all’ampiezza dei topoi che tocca, ma se dovessi scegliere una direzione legherei quantomeno il sentire dei sei saggi a una simile visione fisheriana del tardo capitalismo – una visione che rinvigorisce le mie ansie e in questo senso mi rinfranca, da cui sono persuaso ma anche in un certo senso atterrito, sotto la quale non riesco a non percepire la presenza di un bug. Per esplicitarla mi sento di usare quest’espressione: il capitalismo è diventato un’ipostasi, come per la prova ontologica di sant’Anselmo all’interno del suo stesso concetto è stata inserita la categoria dell’imbattibilità, dell’inviolabilità. Il problema che forse non appartiene al solo uomo occidentale, ma che probabilmente è stato lui a identificare con i propri strumenti anche emotivi, è che un futuro non è più immaginabile, e che il presente non è modificabile. E su questo punto difficilmente saremmo in grado di individuare una buona novella che tenga, per pacificarsi tramite l’accettazione dei nostri limiti e uscire finalmente dal malessere che ci avvolge.
La prima interessante summa di Guido Mazzoni, che non a caso pur indicando le ragioni delle crisi della contemporaneità mantiene saldo il tono di chi illustra una serie di fatti, rende bene questo momento eerie dello Spirito. Le sue analisi sono implacabili. La democrazia persegue il consenso e non guarda abbastanza a lungo termine. La crisi del 2008, espressione perfetta degli esiti finanziari del capitalismo, avrà forse impoverito le persone, ma ha mantenuto perfettamente in piedi e intatto il sistema che l’ha scatenata e anzi prevista. Che si guardi ai populismi e alla voglia di gated communities (a destra) o alla difesa delle identity politics (a sinistra) il risultato è uno solo: la mancanza di coesione sociale, il crollo di quei valori comuni sufficienti a tenere insieme una società per come è stata intesa per secoli. In poche parole, mi verrebbe da dire, game over. Ci rimane il contentino chimerico di una social-democrazia fatta in casa e neppure seriamente replicabile, che nel dibattito sollevato poco sopra significa fondamentalmente una cosa: la rinuncia alla soluzione del disagio degli altri, l’accettazione di una forma di sfruttamento su scala globale, l’abbattimento dei suoi simboli e l’invariabilità della sua sostanza sfruttatrice e colonialista. Lo scenario dipinto nel secondo saggio di Federico Chicchi, dedicato al lavoro, non è in fondo tanto lontano; l’olio dello sfondo è commisto di frustrazione, una categoria di questo disagio che vuole qui rendere il suo legame con l’impossibilità di agire per una soluzione. Non si tratta solo di fragilità nei contratti, l’atomizzazione e la gassificazione del lavoro esercita su di noi una forma di vero e proprio biopotere del tutto paralizzante e irrimediabile, la lotta di classe non ha più una classe a cui essere affidata – adesso nel primo come nel terzo mondo. E mi verrebbe da aggiungere: in fondo la robotizzazione sembra consacrare un destino preparato già da Aristotele, e conciliare la fine del lavoro con l’ideazione di un reddito astratto e universale appare a molti tanto necessario quanto problematico. Quanta speranza abbiamo di uscire da questo tipo di disagio, cioè di paralisi? Loretta Lees ci parla di gentrificazione evitando appositamente di inquinare il discorso applicando una sola metodologia, ma la visione delle nostre città – in ultima analisi, tutte – appare sempre più destinata alla versione descritta da Simone Pieranni in Red Mirror, quando ci avvisa che crediti sociali e telecamere a riconoscimento facciale non descrivono semplicemente un modello cinese, ma un esito a cui tutto l’Occidente aspira ammirato. Sulla scorta di questa visione che chiamo fisheriana – precisa, convincente, implacabile, come molti passaggi di questo libro – che rapporto può esserci fra disagio e malattia? Uscire dallo stato pre-terapeutico significherà per molti, che ci credano davvero o no, una terapia d’urto, sollecitare l’esplosione dei sintomi: lo scatenamento di una vera crisi (ammesso che ciò sia ancora possibile). Che ciò sia risolutivo o meno, qualcuno si chiederà poi se questa crisi da scatenare non sia auspicabile soltanto dalla prospettiva di chi ha più chance di uscirne tutto intero. Eppure un’uscita graduale e riformista dal capitalismo – parliamoci chiaro, perché di questo si tratta – manterrebbe le medesime contraddizioni: chi può permettersela di fronte alle urgenze che stabilisce? Quale storia, per esempio, quale escatologia, potrebbe mai convincere quei brasiliani espropriati delle loro case e malmenati dalla polizia all’alba delle Olimpiadi di Rio? Ammetto che il circolo vizioso ha imbrigliato anche me. Anche se una cosa mi sento di dirla, e questo da trentenne intellettuale wanna-be: altro che daimon.

La prima volta che devo aver sentito questo tipo di soluzione al malessere dei «giovani» da parte di Galimberti, autore dell’ultimo saggio, deve essere stato più di dieci anni fa. E poiché ammetto di non essere particolarmente avvezzo ai suoi scritti – dando quindi per scontato che la questione sia più complicata di quello che sembra – posso però constatare quantomeno che i «giovani d’oggi» sono gli stessi da almeno un decennio, a prescindere dall’ascesa di Trump, dalla crisi finanziaria, l’Isis e la pandemia. Da una parte penso che sia vero, dall’altra ho l’impressione che questa versione edulcorata del concetto di daimon, a cui tutti noi dovremmo dare ascolto per stare meglio, non sia davvero utile a chi intende affrontare seriamente la questione del disagio per come è stata impostata, nella sua criticità, nel resto del libro. E lo dico, come tutti i veri disagiati venturiani, comprendendo la portata del problema, forse in maniera ancora più netta degli altri, avendo un padre che da musicista ha seriamente dato ascolto al proprio daimon, e che mi sembra, nonostante questo, estremamente lontano da qualsivoglia forma di agiatezza (per fortuna, mi viene da dire mentre scrivo). Negli anni in cui il problema del riconoscimento si è fatto sempre più vivo, in cui ho cominciato ad ascoltare lo scorrere del tempo con inquietudine, in cui detto schiettamente ho iniziato a morire un po’, mi sono chiesto spesso come sia possibile conciliare questo concetto di daimon, di aspirazione interiore, con un mestiere come quello dell’impiegato. Ma anche con quello dell’editore – specie nella sua versione post-industriale e tardo-capitalista – che tipo di aspirazione può suscitare di per sé, di fronte all’infinità delle possibilità e delle facoltà che si sentono proprie naturalmente? Qual è il rapporto fra la tecnica, che crea e definisce il lavoro in base agli strumenti che inventa, e questa destinazione? Semplicemente, credo, nessuno. E credo che chi il daimon ha potuto ascoltarlo, in qualche sua declinazione moderna, lo sappia bene, e che abbia bene in testa questa fatale contraddizione, quanto sia pervasiva l’impossibilità di esprimersi completamente in libertà, secondo le proprie aspirazioni. Questo è parte del disagio, anche per chi ci è meno vicino: non riesco a pensare altrimenti. L’ascolto di una spontaneità dal nome greco, di un mondo in cui il rapporto con la naturalità non può davvero essere replicato in alcun modo oggi, non mi è stata fin qui di nessun aiuto. Se ascoltassi davvero il mio daimon mi direbbe di cacarmi sotto per la crisi climatica invece di inseguire le aspirazioni calate chissà da quale sovrastruttura. È insomma di questa versione dell’io, credo, che dovremmo iniziare a sbarazzarci prima di ogni altra cosa.
Photo credits
Illustrazione di copertina: Monica Gutierrez Serna
Foto del Bar Maraini: Jesper Storgaard Jensen;
Ritratto di Raffaele Alberto Ventura: Vito Maria Grattacaso per LUZ.
