Talvolta il destino di un’idea è strano. Spesso un’idea è molto meglio della sua realizzazione, forse perché un lampo di follia costa meno caro di un lavoro da artigiano delle parole. Questo è il caso – nel senso di vicissitudine – del libro di Julian Barnes, Elizabeth Finch (Einaudi, tradizione di Susanna Basso). Un libro – anche se sarebbe meglio chiamarlo un canovaccio, sicuramente minore rispetto agli ammirevoli Il pappagallo di Flaubert e Il senso di una fine, che a tratti, nei suoi lunghi excursus su Giuliano l’Apostata risulta persino soporifero. Eppure molte volte, se non desistiamo dagli ostacoli, questi libri apparentemente trascurabili, rivelano qualcosa al singolo lettore cui il messaggio è indirizzato, come se in una stanza gremita di folla il libro sussurrasse direttamente alle sue orecchie, al suo intimo.
La trama è assai povera e ancillare – altri sono i livelli semantici su cui si gioca questo libro.
Neil, il narratore – quasi un filtro, un fantoccio, un fantasma –, ci presenta una donna che è stata fondamentale nella sua vita: la sua insegnante Elizabeth Finch. EF, come viene chiamata nel libro, teneva il corso “Cultura e civiltà” alla scuola per adulti. Neil frequenterà EF con la cadenza di tre o quattro pranzi all’anno per una ventina d’anni. Alla sua morte, l’insegnante lascia proprio a lui i suoi quaderni e la sua biblioteca, e Neil dovrà decidere se raccontare di Elizabeth, seguire la di lei opera, o, da bravo “Re dei progetti incompiuti”, lasciare perdere e dimenticare, abbandonarsi al caso.
Il libro si concentra così sulla figura di Elizabeth Finch e sui sentimenti che Neil sviluppa per lei.
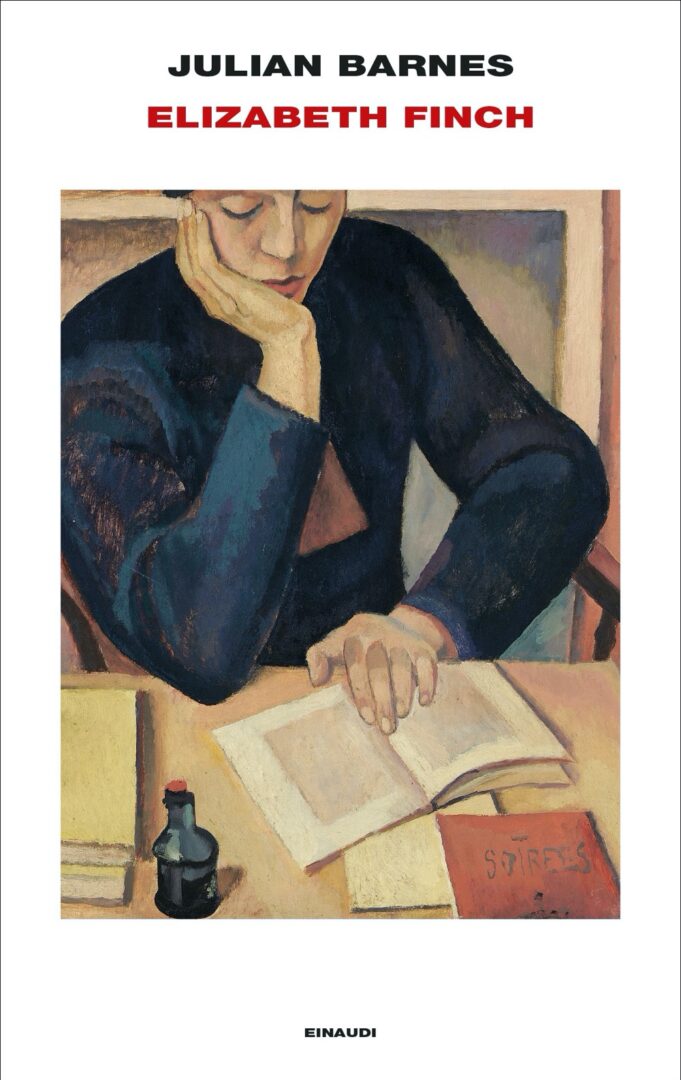
Julian Barnes ci riporta in resa pittorica una donna che da un’importanza cruciale alla Storia, esclusivamente tramite il suo pensiero, le sue teorie, i suoi imbarazzi. Tutto ciò che risulta troppo reale viene amputato e rimosso dal quadro. Le lacune della sua storia – e anche tutto ciò che ignoriamo di Neil, sono fondamentali alla resa poetica. Come diceva T. S. Eliot, «Ciò che non sapete è la sola cosa che sapete, e ciò che avete è ciò che non avete».
Ma ciò che lega i due personaggi è delimitato dai confini del rapporto tra maestro e discepolo. Elizabeth è un personaggio difficile, criptico, presentatoci tramite la lente disformante degli occhi di un alunno innamorato. Insegna tramite “un approccio Socratico” per mezzo di dialoghi liberi. Via via che la sua saggezza decanta, si libera dal razionalismo storico che erige una barriera di insensibilità tra l’anima e il mondo. Più tende alla nuda esistenza, più si carica di dettagli peculiari e accumula un tesoro di contingenze bizzarre, di tratti umani stravaganti o sublimi. Con lo stesso gesto col quale si libera del razionalismo, si separa anche dal cristianesimo, e da altri concetti cardine dell’Occidente, primi fra tutti ogni forma di monomania e l’amore, una menzogna provocata dall’amore per la falsa grandezza, una parola «mistificata, abusata, fraintesa, estensibile a livello di significati e di propositi, contaminata dagli sputacchi di miliardi di lingue bugiarde». Secondo Neil, Elizabeth Finch, per quanto inconsueto e improbabile, è una romantica e una stoica in parallelo. Non è così sorprendente, se ci ricordiamo delle parole di Fitzgerald «I sentimentali credono che le cose durino… I romantici hanno una fiducia disperata che non durino».
Il libro è fondato sui dialoghi: dialoghi tra EF e i suoi alunni, e tra Neil e altri discepoli, sempre riferiti a lei. Neil è la forma pura del discepolo socratico, che cerca di trasformare tutto ciò che in EF era ricerca, problema, aporia, interrogazione, in lezione, dottrina, dogma. Ciò che era fondativo nella vita dell’insegnante, in lui diviene mezzo per comprendere il pensiero prestato al “maestro”. Dovendo il maestro a priori essere uno, la funzione dell’allievo è quella di pensare gli insegnamenti come un tutto. Neil pensa e riporta il pensiero di Finch privandolo della sua tensione, delle sue contraddizioni, dei suoi limiti. La sua funzione è moltiplicare il discorso dell’insegnante. Nel caso dei Socratici, inoltre, la relazione maestro-discepolo è non solo asimmetrica, ma unilaterale. Socrate infatti dice di non avere allievi.
Neil prova a sottoporre e chiedere consiglio a Elizabeth per tutti quei vent’anni che trascorreranno assieme, credendo e nutrendo l’illusione che la sua maestra avesse un potere illimitato e che potesse liberarlo da tutte le sue difficoltà. Ma questa relazione di dipendenza non lavora alla sua maturazione come individuo, non gli permette di sperimentare le cose in prima persona e di ricercare il proprio cammino che forse lo porterebbe a ritrovare se stesso. Prima di accedere a una realtà metafisica Neil dovrebbe trovare una collocazione nella vita reale. Negli anni invece Elizabeth si convince sempre di più dell’ignavia e della mediocrità incurabile degli uomini che la circondano. «Si indurisce sempre di più», come diceva lo Zarathustra. Smette di comunicare sensibilmente, si rende conto di non aver mai vissuto davvero. Per questo è tanto più commovente il gesto di Elizabeth nei confronti di Neil: lasciargli i suoi libri e quaderni.
EF non si limita a interpretare l’uomo, lo forma con un artifizio che è segno della vera autenticità. E in primo luogo insegnandogli a non considerare gli opposti come mutuamente esclusivi, ma a mantenerli tali e quali appaiono al suo sguardo, nell’unità superiore della verità che rivelano. Qual è il suo metodo? Come convertire all’autentico, senza la speranza della vita eterna, la creatura vuota e bisognosa? Come farle sentire il suo vuoto e la sua condizione di bisogno? La prima parte del compito consiste nell’utilizzare la negazione socratica per dissodare la tirannia dell’abitudine, il dispotismo delle idee preconcette, per dissolvere nella relatività del divenire i concetti e i dogmi che separano l’uomo dal reale. Il suo scopo non è “aiutarvi”, ma “stimolarvi a un pensiero autonomo”. A sua volta lei stessa, con l’ascetismo di Socrate, la sua immunità ai bisogni materiali, la tecnica elenctica di domanda e risposta non trasmette conoscenza in alcun senso ordinario o didattico. Mira a innescare nell’interlocutore un processo di incertezza, un domandare che si approfondisce fino a una messa in questione di sé stessi. L’insegnamento di Socrate è un rifiuto di insegnare, che potrebbe essere stato il modello remoto di Wittgenstein.
È difficile avere un maestro verso cui ci sentiremo sempre infinitamente grati ed eternamente mancanti e inferiori, a cui sentiamo di non essere in grado di spostare una virgola, di far crescere un suo pensiero in noi senza paura di recargli un’ingiusta offesa.
Non credo di osare molto nel dire che scrivere una biografia è sempre un’indagine, un’operazione spaventosamente simile allo scrivere un libro giallo. Il biografo deve esaminare tutti i fatti in suo possesso, decifrare i segni con il pugno dello storico e l’attenzione del manierista. Al fondo di tutta la vicenda, deve tentare di rispondere non alla domanda centrale: “Chi l’ha ucciso?”, bensì a “Come ha vissuto? Chi era?” Le domande si propagano in un’induzione floreale come sepali che proteggono i fiori nei loro boccioli, una risposta non gli è data, si aprono davanti a lui migliaia di possibilità. E questo continuo sondare, questo tentativo di calarsi nell’Io altrui e al contempo impicciarsi di qualche pettegolezzo, ha risvolti e aspetti più emozionanti di molti romanzi gialli. Ci possono essere meno colpi di scena, ma quei pochi sono enigmatici, imperscrutabili, misteriosi, persino più appassionanti.
Al pieno della sua paranoia originaria, il biografo deve riuscire a dare forma al mondo, a organizzare in un sistema coerente una nebulosa di dati incerti; è una paranoia indissociabile dalla conoscenza, un mettere a ferro e fuoco e sotto inquisizione la vita di una persona, nella speranza che rispondere a quella domanda non darà pace – o giustizia – al defunto, ma al biografo stesso, per cui quella vita è significativamente più importante rispetto a quanto lo è stata per il suo beniamino. Quanto sono inquietanti le domande e rassicuranti le risposte! Che eroico tentativo di arginare la propria angoscia, che motivo speculare di intrecciare e potenziare la propria vita! Le risposte come polvere e cenere, si depositano sulle nostre paure e sulla nostra vita, nel tentativo di dimenticarcene.
È evidente che Neil, nel raccontare EF, non vuole veramente scoprire tutto di lei, non vuole scoprirla vera e fallibile. Sacrificare se stessi al punto da mettersi in ombra per raccontare la storia di qualcun altro viene reso possibile solo dall’amore, e comunque smarriti in quella comunione segreta con colei o colui del quale scriviamo ritrovata tra le pagine, ci mette comunque in contatto con quella fonte d’amore. Neil non fa altro che raccogliere le briciole cadute a terra di un’immensa portata per lui forse persino indigesta. Le poche cose che scopre dal fratello di Elizabeth dopo la sua morte, le rifiuta nel profondo, perché è proprio della creazione che lui ha bisogno, è certo che solo in lei scorre l’oro che gli serve per dare un significato alto alla sua vita di fallimenti, come se da lei – o dal suo ricordo – potesse emanare un potere salvifico di integrità di cui ha disperatamente necessità.
Essere discepoli – così come essere amanti – è in un certo senso un’arte, che implica la capacità di trasformarsi e andare fuori dal proprio sé precedente, ma anche un oscurare tutto ciò che ci obbliga a vederci davvero per quello che siamo e da cui sfuggiamo. Il vero maestro ci lega alla nostra verità. Neil ha bisogno di quell’incontro paideutico per acquisire un proprio sé trasfigurato dalla relazione duale, per divenire a sé attraverso l’altro. Ma nemmeno ponendo come vero tropo della paideia la ribellione del discepolo, riesce a ridefinire la natura della verità trasmessa, e della trasmissione stessa. La grande tristezza che avvolge Neil è che questo incontro capitale a lui non è servito a nulla, che il vuoto della sua vita e la sensazione che lei potesse colmarlo, non hanno fatto che ingigantirsi. Nell’abbandono del lutto, quella di Neil è una resa totale, un abbrutimento disfattista e negazionista. Neil resta solo un prodotto di Elizabeth, una caricatura, che prova persino a essere lei, prolungando i suoi sogni, rimaneggiando i suoi testi, scrivendo per lei, ma senza riuscire alfine a fagocitarla, inglobarla, superarla. Il dominio su di lui è totale, così totale da spingerlo a continuarlo nella morte, a crederlo imprescindibile. Questa tristezza è l’ombra della figura socratica, che è quella dell’allievo che è interprete, e commentatore, del suo maestro; ma anche dell’incomprensione ultima – pari al livello di ammirazione – che Neil ha per Elizabeth. È stato al suo fianco per anni, cercando di tenerla solo per sé, come una pietra preziosa in suo esclusivo possesso, convincendosi che i detrattori non erano in grado di capirla. Ma è lui, infine a non capirla, è lui a compiere la scelta di non capirla.
Il vero maestro è colui che sa rimanere da solo, alla fine. Ci indica ciò che non siamo e cosa non vogliamo essere, e la verità è che per molti di noi la cosa più importante è non essere banali. Ogni uomo trae una leziona diversa dallo stesso maestro, quella di cui ha più bisogno. E il senso è saper amare non solo quello che ti dà, ma anche quello che non ti dà o di cui persino ti priva. Così tutte le lacune di EF diventano a un tratto inevitabili. Mentre la coscienza di Neil si affida completamente all’attitudine, alla tendenza naturale della mente ad accostare fra loro fatti sparsi nello spazio non appena possa scorgere fra essi una ragione che li leghi, e a superare rapidamente tempi e luoghi in un certo senso vuoti, per giungere dalla causa agli effetti, riesce a intravedere l’umano che c’è in EF, e si ritrae. La sua coscienza, così come ce la presentava Hillmann «rimanda a momenti di intensa incertezza, a momenti di ambivalenza. Esplora le parti in cui ci disgreghiamo, nel renderci conto che tutto il nostro conoscere è solo un conoscere in parte, perché noi conosciamo solo attraverso le parti archetipiche attive in noi, ora in questo complesso e in questo mito: la nostra vita un sogno, i nostri complessi, nostri daimones». E da quel pulpito preferenziale che è il punto di vista del discepolo che ama il maestro, nulla è possibile scoprire, perché nessun mito personale può essere autonomamente distrutto. Neil accetta di mantenere intatto il mistero di EF dando prova di vero rispetto. D’altronde il solo modo di possedere veramente qualcosa è rinunciarvi.
Ma resta per me l’ultimo mistero. Perché la recondita Elizabeth Finch lascia i suoi libri e quaderni a Neil? La mia risposta è: proprio perché, a dispetto delle apparenze, è umana. E come fa un essere umano a non commuoversi davanti a un altro che ha tentato di capirlo per tutta la sua vita e a cui si è sempre sottratto? Io credo che Elizabeth, una donna che in parte negava la sua vocazione all’insegnamento – che in fondo pareva dire: «Se volete imparate qualcosa, altrimenti non mi interessa», che nutriva verso se stessa una profonda gelosia e che trovava rassicurazione sapendo che Neil fosse sempre lì ad ascoltarla e a voltarsi verso di lei, avesse deciso di lasciargli non una prova, ma un dono. È come se lei non si reputasse abbastanza importante da battersi per se stessa, disillusa in uno stoicismo metafisico. È come se gli dicesse «Hai provato a conoscermi per tutta la vita, tu lo desideravi e io segretamente desideravo che tu ci riuscissi. Ora leggi tutto questo, fallo tuo, che è l’unico modo di comprenderlo. Esci dallo spazio libero, entra in questa effusione che è una fusione. Unisciti con stoicismo e lucidità e infine con amore. Sarà così anche la tua storia. Forse finalmente, sarà possibile la doppia liberazione del vincitore e del vinto, del maestro e del discepolo».
E così tutto quello che ha scritto, detto e lasciato, non fa che esprimere la supplica, l’intenzione, la necessità di essere compresa. E questo riscontro postumo, questo desiderio legato alla coscienza, il bisogno di sfuggire alla nostra ontologica solitudine, il bisogno di qualcosa di più dell’empatia – una comune spiegazione, una grazia, una penetrazione che finalmente unisce proprio in virtù della comprensione; aggrapparsi a tutto questo, dopo una vita di continua elusione e solitudine, mi sembra degno di una venerazione per la vita nel suo insieme, che implica il riconoscimento della sua impenetrabilità protettiva: mi sembra degno della mia più estrema pietà.
