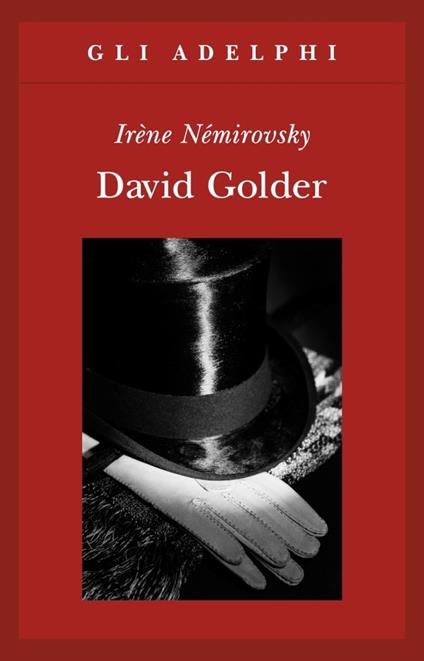Qualche mese fa è stato pubblicato per Adelphi l’epistolario di Irène Némirovsky, la scrittrice francese attiva negli anni Trenta e oggetto di una recente rivalutazione. In quest’occasione si propone di tornare indietro nel tempo e di parlare del suo primo romanzo, David Golder, uno spietato ritratto della società borghese che le valse l’ingresso a pieno titolo nel panorama letterario francese. Come nei vari Tom Jones, David Copperfield ed Eugenie Grandet di una lunghissima tradizione europea, anche qui il titolo ha il sapore di una presentazione, nome e cognome del protagonista, che già dalle prime pagine inizia a disvelare il proprio mondo. L’inizio è disarmante: il tesissimo dialogo tra Golder e il suo socio Simon Marcus, un incipit molto teatrale che serve a spiegare l’antefatto. Si apprende che i due sono soci e che la loro impresa non versa in buone acque. Ma soprattutto si fa conoscenza col personaggio di Marcus, che prima da vivo, ma ancor più da morto, è il motore della trama. Una trama dall’andamento inesorabile, in cui le scene si susseguono con ritmo incalzante, quasi geometrico, stringendo Golder in un turbine di sconfitte e delusioni da cui non riuscirà a liberarsi se non con la morte.
Tutto ha inizio con una telefonata: è la notizia del suicidio di Marcus a seguito dell’estromissione dall’azienda. L’episodio agghiacciante colpisce Golder non meno del lettore, perché basta questo breve paragrafo per scoprire il gioco del narratore. Con la morte del socio si delinea il baratro di morte e spregiudicatezza nel quale Golder sta per precipitare, e il ricordo non può non correre a Balzac, Papà Goriot, che è il lento disfacimento del protagonista; o a La morte di Ivan Il’ič di Tolstoj, dove il decadimento è fisico ma rispecchia una condizione mentale. Del resto Némirovsky aveva ben presente la tradizione europea del diciannovesimo secolo, basta pensare a un altro capolavoro della Comédie Humaine, Eugenie Grandet, dove è l’immagine del padre morente che conta denaro a richiamare l’ossessione con cui Golder, in vita, non aveva fatto altro che accumulare ricchezze, ricchezze, ricchezze, prima dell’esplosione dell’ordigno.
Sì, perché David Golder non è solo una storia borghese narrata con grandissima penetrazione psicologica: è un meccanismo, una bomba a orologeria, un vaso che non aspetta altro che la goccia che lo faccia traboccare. L’autore predispone le carte con cura infinita, ma una volta che il gioco è avviato l’impressione è che le pedine si muovano da sole. Si manifestano i primi sintomi della malattia di Golder, poi fanno il loro ingresso la moglie e la figlia. Ogni scena o personaggio è un giro di vite nel cuore affaticato del protagonista, nella sua capacità di sopportazione che si fa via via più debole. La comparsa della figlia, per esempio, è uno scoppio, una deflagrazione. Non a caso il suo ingresso nel romanzo è affidato a un urlo e a una risata:
«‘È arrivato Dad?’ gridò Joyce.
Golder la sentì ridere. Chiuse involontariamente gli occhi, come per ascoltarla più a lungo. Quella ragazza… Che voce, che risata sonora aveva… Con una sensazione di piacere indefinibile pensò:
‘Sembra oro…’»
‘Sembra oro’, sì, perché Joyce è vitale e disinibita, ma è anche capricciosa, viziata, egoista. Figlia illegittima non solo in senso biologico, della lungimiranza e del pragmatismo di Golder non ha niente. Ma Joyce è allegra, Joyce è la vita. come si può negare qualcosa alla vita? Golder paragona la risata della giovane all’oro senza pensare che è proprio l’oro – il denaro – la sua fortuna e la sua condanna. «Paga, paga, paga…» si lamenta Golder, «dalla mattina alla sera… per tutta la vita…»
Joyce è la soddisfazione del padre e allo stesso tempo è la negazione del padre stesso, quanto di più gradevole, scusabile, lodevole Golder possa immaginare. Del resto, quale è la colpa di Joyce? Vuole tutto – soldi, amore, spensieratezza – insomma sa godersi la vita, lezione che il padre non ha mai appreso; e poi è così giovane, ha appena 18 anni. Golder, vecchio e amareggiato, l’osserva da lontano come un naufrago che guarda i superstiti sulla riva. Ma chi è salvo veramente? Nel romanzo, nessuno. Persino Joyce sarà costretta a soggiacere alle dure regole della realtà. La felicità non esiste, sembra dire il libro, e spesso vive solo nell’idea che abbiamo degli altri.

Per capirlo basta guardare al rapporto del protagonista con la moglie: Gloria è certamente più simile a Golder – spietata, distante, infida – e per questo immensamente odiata. Perché Golder odia prima di tutto sé stesso. L’odio per la moglie e per i soci è solo un residuo dell’immenso odio che nutre per sé stesso, per quel poveraccio vagabondo divenuto un imprenditore tanto arido. La catabasi emotiva e intellettuale di Golder, il suo inesorabile scivolare nella fossa che la sua stessa fortuna gli ha scavato, ricorda certamente la parabola di mastro don Gesualdo. Anche Golder ha fatto una bella scalata sociale: dalla condizione di povero mercante, rinfacciatagli con disprezzo dalla moglie, al rango di alto borghese. Entrambi non traggono dal cambiamento alcun tipo di soddisfazione duratura, ma solo freddezza da parte della famiglia e invidia sociale, eppure la figura di Golder appare – a mio avviso – più amareggiata e senza speranze. Gesualdo non si odia, non si disprezza; prova ne è il suo continuo attivismo. Pensa a tutto lui, risolve tutto lui – quando sposa la moglie, quando quest’ultima si ammala – prende su di sé le responsabilità altrui, addirittura a tratti sembra mosso da una sorta di altruismo. Golder invece, giunto al termine della sua vita, non agisce più: subisce. È vittima dei maneggi della moglie e del suo amante, perfino della figlia. Anche Gesualdo si rifugia nella figlia, ma ama più la roba; altro tratto comune col personaggio di Némirovsky. Golder ama la figlia nello stesso modo in cui ama il denaro. La cara Joyce che non fa altro che divorare i suoi beni, è lei stessa un bene di lusso, l’unico regalo che Golder ha fatto a sé stesso: una figlia allegra e spendacciona – a differenza del padre, a spese del padre – che può fare quel che vuole. Golder disprezza sé stesso e sa di essere disprezzato. Come Shylock sa di vivere ai margini. Ma i suoi non sono margini sociali: sono margini emotivi.
Shylock è ai margini della società, mentre Golder, della società, è al centro. La sua esclusione è di ordine morale, e per capirlo bisogna pensare alla Francia di primo Novecento, quel quadro di capitalismo selvaggio descritto da Némirovsky stessa nei Falò dell’autunno. In un contesto di sogno americano tout court, in un mondo in cui dal nulla puoi ottenere tutto ma se non ottieni niente è solo colpa tua, l’ossimoro è perfettamente comprensibile: avere il mondo che ti gira attorno ed essere completamente solo. Nessun sentimento sincero, nessuna comprensione, nessun interessamento se non per secondi fini e, come se non bastasse, un codazzo di gente sempre pronta a invidiarti. Tra invidia e disprezzo, Golder si barcamena come su un filo teso sull’abisso, un filo – che poi è la sua vita – talmente usurato che è pronto a spezzarsi a ogni movimento repentino, come nella scena finale sulla nave:
«Aveva lasciato ricadere la testa sul petto. Per un attimo gli parve che il frastuono del vento e del mare si allontanasse, divenisse un brusio confuso, una sorta di nenia… All’improvviso sentì la voce del ragazzo chiamare aiuto. Si alzò in piedi, barcollò violentemente, poi, a braccia tese, annaspò nel vuoto e crollò a terra».
In fin dei conti David Golder è la storia di uomo che muore. Dopo il suicidio di Marcus, è Golder che inizia, lentamente, a spegnersi. La morte, poi, lo coglie in circostanze simili a quelle del personaggio verghiano. Sia Golder sia Gesualdo muoiono lontani da casa, di notte, a seguito di una lunga agonia che si conclude all’alba. Ma l’affinità più evidente è la solitudine pressoché totale nella quale affrontano il momento estremo. Gesualdo è circondato da servi interessati, il cognato arrogante e la figlia che, occupata a versare lacrime su lacrime, non lo ascolta neanche. Golder si trova in viaggio. Nel momento del trapasso, la loro intera esistenza si condensa in un solo istante che rivela ancora una volta come sia impossibile negare le proprie origini. Le mani di Gesualdo tradiscono l’estrazione popolare, e Golder ricomincia a parlare in yiddish.
Una differenza però c’è, ed è tutta qui: Gesualdo, in punto di morte, appare al lettore come una vittima – vittima dell’egoismo dei parenti, della diffidenza dei servi, dei pregiudizi sociali, persino di sé stesso, della sua avarizia e dell’incapacità di emanciparsi veramente, ma pur sempre vittima. Golder invece è un carnefice, è l’origine della catena di cattiverie e interessi che finisce per soffocare lui stesso. Per Gesualdo si prova compassione, per Golder no. Colpevole della morte di Marcus, dell’infelicità della moglie, della crudeltà spensierata della figlia. Le accuse gli cadono addosso come pioggia battente. E i suoi occhi si chiudono sulla struggente immagine di un uomo, un padre, un lavoratore fallito.
In copertina e nel corpo del testo: Irène Némirovsky