Tutto ciò che ora esiste, e si tiene aggrappato ostinatamente all’esistenza, esiste pur avendo perso molto. Qualsiasi cosa ha in sé quello che andrà a disintegrarla, incenerirla, scioglierla e così via. Dopotutto il mondo produce polvere e persino noi lo siamo, polvere potenziale, futura.
Essere questo significa essere predisposti alla perdita. Il corpo, l’anima, nostri, degli altri, il passato, il presente, tutto è polvere e si può disperdere. Anche trattenendolo non rientra più nei bilanci della nostra vita.
La vita, selvatica, a volte crudele a volte dolcissima, ci cammina addosso più e più volte, lavorandoci, qualche volta togliendo, estorcendoci, decurtando, pesando, prendendo a piene mani. Quanto si riesce a preservare dal processo, quanto riusciamo per volontà a salvare e portare altrove, è quanto ci appartiene.
Addio di Cees Nooteboom, traduzione di Fulvio Ferrari, postfazione di Andrea Bajani (Poesia Iperborea, 2020) è questo: una raccolta breve, trentatré poesie che sono quanto l’uno, l’uomo-poeta, «l’uomo nel giardino d’inverno» è riuscito nei suoi quasi novant’anni a preservare da sé, dagli altri, dagli eventi e portare sull’orlo di.
È probabile – o quantomeno viene da pensarlo – che l’ultimo uomo sulla Terra dovrebbe essere un poeta. Perché possa rispondere a quella domanda che Nooteboom mette in apertura della raccolta e che è il centro pulsante dei versi scritti, percorrendo questo tempo così fuori dal tempo e dalla misura:
«la fine della fine, cosa poteva essere?»
E cosa può essere davvero? L’inizio della raccolta ha un luogo, reale – il giardino d’inverno, le piante mediterranee, il fico spoglio, la nuvola di piombo – ma finisce per perderlo, oltrepassando sia il tempo che lo spazio, dove prima è la memoria a dare le coordinate.
Compaiono i ricordi della guerra e i soldati («Se lo ricordava bene, schiene umiliate/ che ora rivedeva, lui non era un esercito ma/ sentiva la lezione come un coniglio il castigo del cacciatore/ una misura senza perdono, e/ tutto era finito») il padre («un uomo in smoking appoggiato al parapetto/ del lungomare») la madre («accanto a quel futuro/ morto, già avvolta nel tempo che sarebbe venuto»).
È tutto popoloso, affollato e il poeta «riascolta le voci di un tempo:/ deliri come saggezza – tante guance cresciute/ senza collo, braccia nude, private/ delle spalle, vagano qua e là, occhi/ solitari privi di fronte errano intorno, membra/ staccate, forme spettrali, fantasmi/ intessuti di malvagi racconti, ma/ si accomodi, prego.»
Chi abita e cosa viene abitato. Dove si muovono e verso dove vanno le «innumerevoli teste,/ generali, amanti viaggiatori/ tra le stelle. Ogni testa la sua/ storia, nascosta tra le pieghe/ del cervello, lungo sottili fiumi di sangue/ canneti sulle rive, paesaggi/ segreti cui nessuno può accedere, tranne un airone solitario».
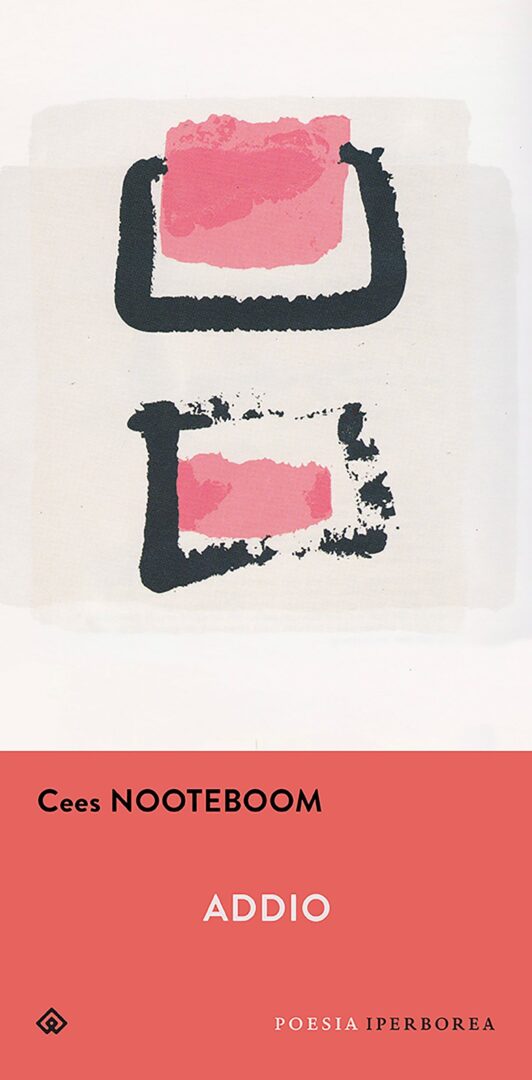
Il movimento appare predirezionato e la fine premeditata. Sotto il cielo dove il poeta è l’airone, le teste sono le medesime – colate lungo i secoli in forme quasi uguali, con intenzioni quasi simili – e nel mondo visto in volo aereo «non c’è amore, solo violenza,/ solitudine, malinconia, il profilo di/ una bestia, un uomo in compagnia dalla sua/ ghigliottina, un bambino senza bocca». Gli esseri sono «in cammino tra destino e sorte» e ogni cosa è dolorosa, angosciante.
Il poeta, camminando verso il non-luogo da dove deve arrivare la fine del mondo, fa bilanci in versi, una contabilità mortale. Dove la vita, la realtà (la pandemia, la quarantena) plasmano la direzione nella poesia e viceversa.
Quanto ha perso l’uomo-poeta, quanto ha perso l’essere umano? Cosa si è scrollato di dosso, da dove è andato via, senza voltarsi indietro.
E cosa se ne fa il mondo del mondo? Cosa fanno i viventi di altri viventi e dei morti e quanto in grado siamo di disertare e disertarci?
Non c’è pietà, il poeta non la desidera, perché trasfigura le cose. Tutto quanto accade per coazione a ripetere, più e più volte, le cose persistono immutate nell’essere dolenti, ci saranno «vittime sotto gli stessi cieli/ di sempre, niente di nuovo». La vita non permette di desiderare «solo l’oro, l’azzurro/ del cielo, l’amore, il sole?» perché «Niente qui è gratis, raccogli/ il morire in tutte le sue forme».
L’essere umano abita un pianeta che fa parte del pulviscolo universale, abitandolo lo annienta e si annienta, e abbandona e viene abbandonato, per poi sparire dicendo addio e «svoltando a sinistra/ o a destra, sono scomparsi come spettri,/ ognuno solo con se stesso».
Rimane così perpetua solo la Terra («Che rumore fa la Terra/ nella casa dello spazio? Ronza, canticchia,/ balbetta, piange tra sé senza mai/ arrivare.») e i suoi crolli interni ed esterni, abitabile ma trapunta di macerie, dove il poeta continua a camminare piano piano allontanandosi, avendo solo «la luce che accanto a me/ si muove».
La postura del poeta è estrema. Disposto a perdere ogni cosa, o destinato a farlo, perché la poesia nasce dalla depredazione e dall’autodepredazione, da quanto si è stati in grado di perdonare d’aver perduto, di strappare da sé. In modo da diventare l’ultimo uomo della Terra.
Ultimo a congedarsi, colui che è giunto più lontano da sé, perdendo più del necessario per trovarsi immerso nella polvere, lui stesso polvere compressa e guardare dal bordo della vita, del mondo, dell’universo prendendo congedo infine anche da se stesso, diventando lentamente nessuno.
Ma è questa davvero la fine? Davvero dopo il congedo non c’è altro che la dissoluzione? E se il congedo fosse solo l’ennesima trasmigrazione, l’ultimo avamposto, solo un punto nello spazio che precede il successivo e se l’uomo-poeta non fosse l’ultimo uomo sulla Terra ma il primo di quelli a venire?
Perché in fondo, quanto davvero rimane di un uomo – che siamo tutti noi – quando ogni cosa viene dissipata, è la condensazione della polvere in un minerale durissimo e luminoso che qualcuno chiamerebbe anima. E che Cees Nooteboom ha voluto disseminare nella sua raccolta, devolvendo qualcosa di sé e qualcosa degli altri, a favore di tutti noi, talvolta ultimi uomini e allo stesso modo primi, su questa Terra, che pur non arrivando mai, continua ad andare.
(I) 9.
Sento la musica ma non le parole,
movimento di danza, senza lì nessuno.
Poesia, ma senza un lettore.
Tempo, ma senza numeri.
Quanti enigmi si possono sopportare?
L’amico morto senza poter più parlare
l’altro amico che sull’ultimo letto
tracciava con le mani un cerchio,
e voleva dire viaggio. Era
un addio, e io l’ho compreso, dovevo
viaggiare ancora e più lontano, cerchi sul mondo
fino a tornare da lui,
o lui da me, una promessa vana.
(II) 3.
Quante vite stanno in una vita?
Quante volte la stessa testa è qualcun altro?
L’assassino spinge via l’amante
o si inventa un nuovo enigma?
Di fiabe se ne è inventate tante, per ogni
testa ha pensato una vita, se non lo
vedevano lui le guardava. Soprani cantavano
in lontananza e lui osservava.
Le teste che ha fabbricato, che
non volevano conoscerlo, estranei,
compagni di ventura di un’altra esistenza
con cui niente voleva spartire
tranne l’angoscia.
(III) 9.
Ora i miei piedi contano il cammino, lo so,
voltarsi è proibito. I miei passi misurano il tempo
una poesia oscura senza pari, un ritmo
che più lento non si può. Provo
a vedere di tutto come ho sempre
fatto. Lassù ancora quell’uccello
che fingeva di seguirmi, un ultimo
compagno di viaggio che sapeva dov’ero diretto,
conosceva la mia strada. Tante strade
ho percorso, sempre in cerca di qualcosa
che doveva trovarsi più lontano, che quando
infine scorgevo svaniva come un miraggio
o appariva come poesia.
