Con Le schegge Bret Easton Ellis torna a quarant’anni fa, all’epoca della giovinezza e di Meno di zero, il romanzo di esordio che generò il mito di Ellis. La mia lettura di Meno di zero risale davvero a una montagna di anni fa. È un’esperienza di cui conservo ricordi fin troppo sbiaditi. Se una commissione mi rinchiudesse in una cella sotterranea, obbligandomi a redigere una scheda di Meno di zero senza l’aiuto di Internet, non riuscirei a buttare giù più di qualche riga. Scriverei che l’esordio di Bret Easton Ellis non andava al di là di un modico numero di pagine (vado a memoria, appunto), che il libro in Italia venne pubblicato prima dall’editore Tullio Pironti (la copertina era pop e colorata, bella) e successivamente da Einaudi. Inoltre direi che la vicenda si svolgeva nei primi anni Ottanta a Los Angeles e descriveva i rapporti all’interno di un gruppo di ricchissimi adolescenti bianchi, ossessionati dalla cura del corpo e dal mito della bellezza, assuntori di cocaina (e psicofarmaci, se ricordo bene), specialmente in occasione di feste che si tenevano a bordo piscina nelle ville dei rispettivi genitori. Ricordo che gran parte dei presenti alle feste indossava occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer. Era come il video di Club Tropicana degli Wham, ma senza gioia e senza euforia.
Aggiungerei alla scheda che lo stile letterario di Meno di zero ha rappresentato una novità, che il suo tratto più evidente consisteva nella reiterazione (per esempio, come noto, gli elenchi di canzoni pop rock e new wave, per quanto la nozione di new wave di Ellis sia un po’ più ampia e comprensiva di quella di noi europei). Altre caratteristiche di Ellis erano l’asciuttezza e i dialoghi, che spesso erano aperti dalla ripetizione di formule piatte e rituali («Ciao bello, come butta?», mi pare, proprio come in Le schegge). Il sex appeal dei personaggi era basato sulla vacuità spettrale delle psicologie e sulla prevalenza di toni algidi e minimali. Anche da questo punto di vista Meno di zero fu una novità, avendo messo in scena il fascino di psicologie bidimensionali, stagliate sullo sfondo di palme, giardini e cieli tersi californiani.

Divago: a proposito di cocaina e anni Ottanta, consiglio un TV movie prodotto dalla NBC nel 1983. S’intitola Cocaine’s – One Man’s Seduction. Il protagonista è Dennis Weaver, un bravo attore che fu molto popolare negli Stati Uniti. Poi ci sono Pamela Belwood, già nel cast della soap opera Dinasty, e James Spader, che reciterà in Sesso, bugie e videotape di Steven Sodebergh e in Crash di David Cronenberg. Cocaine’s – One Man’s Seduction è la storia commovente di un agente immobiliare in crisi, che grazie alla cocaina riesce a tornare efficiente e a recuperare il rapporto con la moglie. Se volete sperimentare un’immersione negli appartamenti e nell’intimità domestica del ceto medio americano degli anni Ottanta e assaporare l’innocenza e la disinibizione con cui si abbandonò alla cocaina in quegli anni, Cocaine’s – One Man’s Seduction è un’ottima occasione. L’opera è apprezzabile anche per la sua medietà e per l’assenza di grandi ambizioni artistiche, trattandosi di un film scritto per la televisione. Per gran parte del film, gli attori si toccano le narici, tirano su col naso e sorridono come nella pubblicità di un dentifricio. Ellis apprezzerebbe.
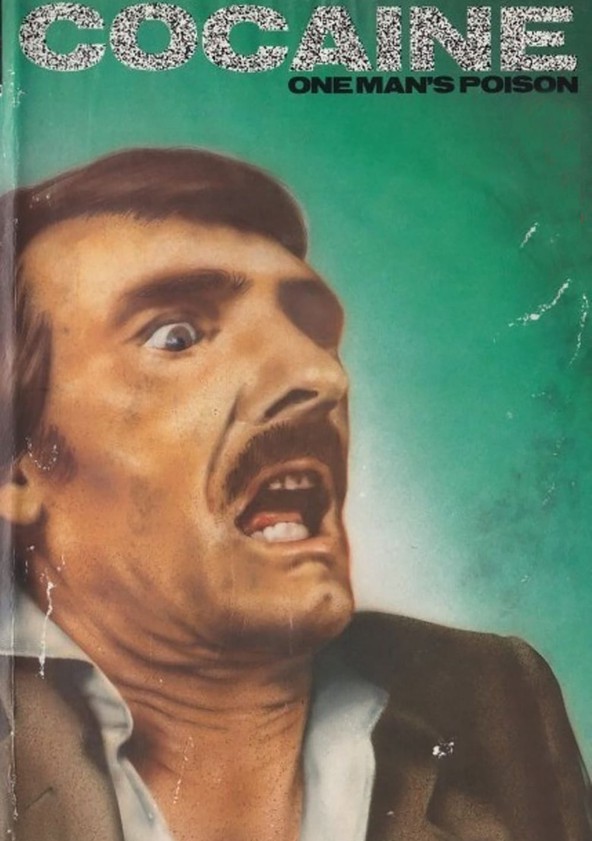
American Psycho, terzo libro di Ellis (uscito in America nel 1991), diventò un romanzo di culto per un gruppetto di miei vecchi amici. Ci divertivamo a ripetere la famosa scena del ristorante, dove Patrick Bateman e il fratello giocano a una specie di gara a chi possiede la carta di credito più esclusiva. Ho amato alla follia anche altri due romanzi di Ellis, Lunar Park e Glamorama, ma pure in questo caso i ricordi sono appannati. Con l’ultimo romanzo di Ellis, Le schegge, edito da Einaudi – oltre 700 pagine – la partenza è stata lenta, anche perché il tempo, nella mia vita come in quella di tutti, scarseggia. È diventato sempre più difficile affrontare libri così lunghi. Anche per l’assedio portato dagli altri media e dai social. Lo sappiamo. Bisogna avere fede e trovare spazio. Perciò mi sono stupito per una dichiarazione dello scrittore Diego De Silva. De Silva ha intervistato Bret Easton Ellis al Circolo dei Lettori di Torino qualche settimana fa e in quell’occasione ha confessato che ogni anno rilegge per ben due volte American Psycho. Mi è sembrata una dichiarazione un po’ sfacciata e poco verosimile. Ma voglio crederci. In quel momento De Silva mi è apparso come una specie di sovrano assoluto del tempo, un Luigi XIV che a differenza dei comuni mortali dispone di riserve temporali illimitate e tutto imparruccato sfoglia romanzi passeggiando lungo i corridoi di Versailles. Ellis ha commentato l’esternazione di De Silva dicendo che forse, se davvero De Silva rilegge due volte l’anno American Psycho, deve avere qualche problema. Non ho capito quanto fosse ironico il tono di Ellis. Più tardi De Silva ha fatto un’altra considerazione: la scrittura di Ellis è «costantemente attraversata da una corrente ridicola», il sarcasmo appartiene «biologicamente» a Ellis e il romanzo Le schegge, da questo punto di vista, non fa eccezione.
Mi sono preoccupato. American Psycho, nonostante sia la storia di un serial killer, è senz’altro un romanzo ricco di sarcasmo e capace di accendere un ghigno malefico nella mente del lettore, spingendolo in una zona grigia di simpatia con la violenza e la crudeltà. Là dove si diventa empatici con il male, più che con il bene. Ma Le schegge, no. Almeno, così mi sembrava mentre stavo leggendo il romanzo. Perciò, guardando l’intervista sullo schermo del computer, mi sono messo con trepidazione in attesa della reazione di Ellis. Se Ellis avesse confermato la tesi di De Silva, allora non stavo capendo nulla del romanzo che avevo in lettura (e che stavo gustando boccone dopo boccone come un cibo prelibatissimo). Ho guardato con apprensione il momento in cui Ellis, scrittore di un metro e ottantadue di altezza e dal fisico piuttosto corpulento, ha avvicinato il microfono alla bocca. La risposta di Ellis è stata spiazzante. Prima di tutto si è scusato. Era distratto, ha detto, perché stava cercando di capire chi fosse il più bello e la più bella tra il pubblico seduto in sala al Circolo dei Lettori, e quindi ha chiesto: qual era la domanda? Poi ha risposto: no, nessun sarcasmo in Le schegge. «Sarchasm… Sarchasm… I’m not sure there is so much sarchasm in this book… […] It’s a book about compassion and it’s a book about love». Ho tirato un sospiro di sollievo. Non mi ero sbagliato.
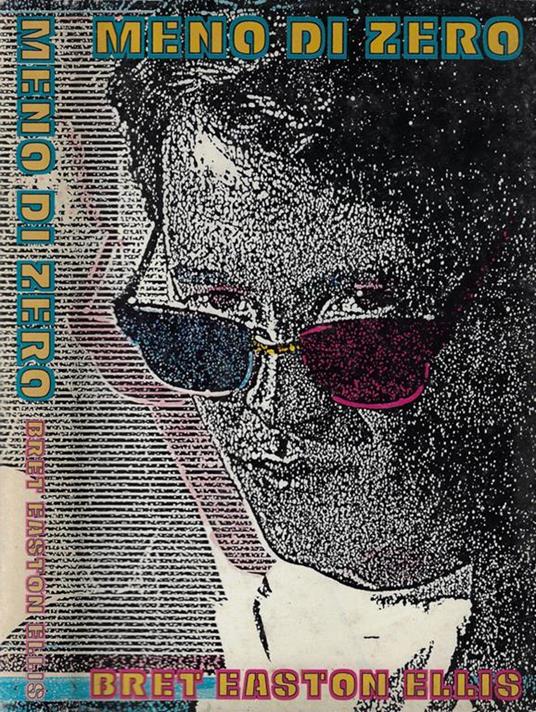
Con Le schegge Ellis torna all’anno 1981 e all’epoca in cui, giovanissimo, stava iniziando a lavorare al manoscritto di Meno di zero e si stava avviando alla carriera di scrittore (per quanto Ellis oggi non si definisca uno scrittore di professione, ma uno scrittore per hobby). Il progetto di riprendere in mano quel tempo lontano della propria vita è dichiarato nero su bianco nella prima pagina del romanzo. Ellis parla direttamente al lettore. Grazie a un’altra intervista ho poi scoperto che Ellis ha cominciato a lavorare al libro durante la pandemia, quando Los Angeles era una «ghost town»; e in qualche modo la circostanza si sente, è percepibile, cioè si avverte un sommovimento non frequente della coscienza, quel moto forse favorito dal silenzio calato nel mondo durante il lockdown, che ha portato molti di noi a riavvicinarsi a luoghi perduti della propria esistenza e della propria memoria (io, se può servire come esempio, durante la pandemia ho ricevuto telefonate da amici che non sentivo da secoli).
Il romanzo parte con un piede nell’autofiction. La voce narrante è il diciassettenne Bret e i protagonisti sono i suoi compagni di liceo. Ben presto, però, il romanzo cambia fisionomia e diventa un thriller. Un misterioso assassino seriale, infatti, si aggira per Los Angeles. Sfoggia uno splendido nome da B-Movie dell’orrore, “Il pescatore a strascico” (la traduzione del romanzo è di Giuseppe Culicchia). Tra un episodio delittuoso e l’altro, Ellis costruisce lunghe scene di transizione dedicate al sesso e al desiderio. Le schegge è, in questo senso, anche un romanzo di formazione e di conoscenza del mondo attraverso il piacere carnale. La prima metà del libro è intervallata da pagine e pagine di sesso gay (ma non solo), esplicito, pornografico, dal gusto aspro e scabroso per il lettore etero. Culi, pompini violenti, sperma, triangolazioni erotiche che vanno ben al di là dell’Edipo e di Freud (no spoiler).
È impressionante la capacità di Ellis, all’età di 56 anni, di ricreare sulla pagina quello speciale e fragile campo di forze psichico che lega fra loro i gruppi di amici adolescenti. Il personaggio di Bret sente con dolore l’equilibro del proprio gruppo sgretolarsi a causa della separazione di una coppia. Susan, infatti, vuole lasciare Thom. Ma è soprattutto l’arrivo a scuola di un nuovo e misterioso studente, un certo Robert Mallory, a minacciare l’integrità della compagine (no spoiler).
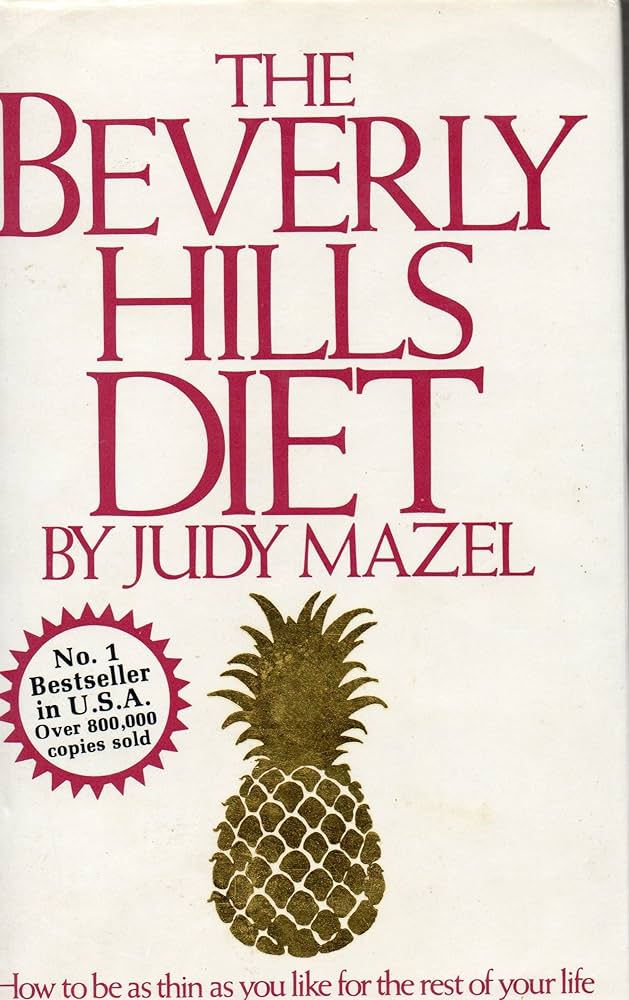
Come in Meno di zero, Bret e i suoi amici sono ricchi e bellissimi. Tutti sniffano cocaina, soprattutto Susan e Debbie, due figure femminili memorabili. Per ammorbidire la tensione e gli effetti della cocaina ci sono il Valium, il Quaalude e l’erba. All’azione calmante del Valium e del Quaalude, Ellis dedica passaggi di notevole delicatezza e sensibilità pittorica. È come se stesse descrivendo le sottili variazioni di luce in un tramonto.
C’è una qualità da cui Bret è affascinato: è l’insensibilità. Bret ammira l’insensibilità di Susan. Ammira il suo volto e il suo portamento, sempre in controllo e impermeabile alle emozioni. Con l’apologia dell’insensibilità, ci troviamo così catapultati in un’atmosfera morale irresistibilmente algida e anni Ottanta. Ellis, inoltre, ci porta di nuovo a Los Angeles, nelle ville, nei ristoranti messicani, negli appartamenti minimal descritti con il linguaggio esatto delle brochure di architettura («Un enorme soggiorno dal pavimento in marmo con una soffusa illuminazione a incasso»), nei locali e nelle gallerie d’arte più esoteriche («La sola fonte di luce era il sottile neon rosa pallido che contornava alla base le pareti, dando all’ambiente il minimo di luminescenza necessaria a farti navigare nella stanza senza perdere l’equilibrio»).
Lo sguardo di Bret a volte si posa sulla copia di un best seller del momento (La dieta di Beverly Hills, notato nell’attraversamento di una sala da pranzo). A volte invece si posa su un quadro di LeRoy Neiman, pittore noto in America, autore fra l’altro di un ritratto di Sylvester Stallone. È l’arte di disseminare il testo di references perfette, squisite, che fondano la densità e la veridicità dell’ambientazione.
Ha ragione Diego De Silva quando dice che la scrittura di Ellis è una musica. Musica, per esempio, sono le innumerevoli sequenze di pedinamento in automobile. Interi blocchi di testo costruiti su una sapiente e ipnotica alternanza d’inquadrature: lo specchietto retrovisore, il semaforo rosso, il lunotto, lo specchietto laterale, la mano sul cambio, la marcia scalata, l’auto da superare, la svolta per Benedict Canyon o per Santa Monica.
La voce di Ellis, insomma, è tornata e il suo potere è simile a quello di una sostanza. A un certo punto la sostanza fa effetto e riconosci quel vecchio e inconfondibile piacere: è lui, è Bret Easton Ellis.
