La realtà non ci accontenta mai. È, appunto, una malattia.
In un’epoca contrassegnata dal dilagare di deepfake, fake news, supportati dall’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa, e che ci sta anche apparentemente ponendo di fronte a eventi prima inimmaginabili – dalla pandemia globale del 2020 al ritiro dell’attuale presidente Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca – il cervello umano, già portato per sua natura a risolvere puzzle, a ricercare un ordine laddove non c’è, a identificare pattern che non esistono, è spaesato, rischia di perdersi e confondersi ancora di più tra dietrologie e complottismi alla disperata ricerca di dare un senso a qualcosa che un senso non avrà mai.
A questo, va aggiunta un’altra componente a cui stiamo assistendo sempre di più: «Il pubblico ci prende gusto al pathos della denuncia del mostro» (C. Dederer, Mostri, Iperborea, 2024). Un mostro che, sempre usando le parole di Dederer è una «valigia piena di rabbia», è qualcosa in grado di sconvolgerci, profondamente, come esseri umani, ma, dall’altro lato, anche di rassicurarci, di darci delle risposte, di mettere un po’ di ordine all’interno del caos in cui ci troviamo immersi. E, spesso, sfortunatamente, nel riportare eventi drammatici alla memoria, sono i colpevoli, non le vittime a rimanere impressi nella mente: i mostri, appunto, in grado di permetterci di dire «abbiamo trovato una soluzione, la soluzione ha un nome, un volto, una carta d’identità». Ma, dicevamo, la realtà non ci accontenta mai e, infatti, non ci basta nemmeno questo: abbiamo bisogno, vogliamo, esigiamo anche un sonoro “perché”, una giustificazione, senza la quale, incuranti di gradi giudizio o prove scientifiche, non sentiamo di aver risolto il nostro enigma.
Il rischio, nel parlare di mostri, di casi risolti più che di quelli irrisolti, è scivolare nei battutissimi territori delle ipotesi, sia scagionanti sia riabilitative, ma con l’evidente obiettivo dell’intrattenimento, laddove, per una basilare questione di rispetto, informare e non svagare sarebbe il servizio migliore da poter rendere a colpevoli, vittime e pubblico più in generale. Tendenzialmente, con successo, come dimostra il recente documentario di Gianluca Neri per Netflix, Il caso Yara, che affronta la contronarrazione di un caso (risolto) doloroso, dove i protagonisti sono Massimo Bossetti e la brama di un pubblico che ha bisogno di un passatempo e affronta delitti come se si trattasse di un gioco a premi.
Donato Bilancia, serial killer italiano, quando confessa gli omicidi commessi, dice «non chiedetemi perché l’ho fatto: non lo so». Io, lo stesso avrei voluto domandare all’autore di Che venga la notte (Nottetempo, 2024): perché l’ha fatto. La risposta c’è stavolta, è contenuta all’interno delle pagine di quello che è difficile definire romanzo e, al contempo, è inesatto definire giornalismo.
Avrebbe potuto, Ceccherini, fare leva su dinamiche consolidate nel coinvolgere il pubblico, avrebbe potuto anche limitarsi a una distaccata disamina di quelli che sono solo fatti. Avrebbe potuto e avrebbe, con ogni probabilità, avuto successo in entrambi i casi, ma Ceccherini fa di più e fa meglio: come dalla sua stessa nota «questa è […] prima di tutto un’opera letteraria, e all’interno della narrazione vi sono sia personaggi reali che fittizi, così come ciò che viene raccontato […] è rielaborato dall’immaginazione», l’autore, utilizza la letteratura per portare in vita, per dare tridimensionalità a personaggi che hanno abitato le nostre cronache su pagine di giornale a due dimensioni, con titoli attraenti, facendolo senza ricercare spiegazioni, senza immedesimarsi né nel mostro, Donato Bilancia, né nelle sue vittime. Eppure, grazie all’immaginazione, riesce a farci qualcosa che ci coinvolge in quanto esseri umani e non solo come spettatori. Ceccherini aggiunge i colori a una storia in bianco e nero, restituendole le emozioni. E, quando la si prova, un’emozione, non è possibile de-sentirla.
Esistono, infatti, passaggi all’interno Che venga la notte che non parlano di Donato Bilancia, non parlano di mostri, di colpevoli, di vittime: parlano di noi. Di chiunque. «Stai ridendo anche tu con gli altri ma dentro senti che vorresti urlare perché sei cieco, tutto ciò che avresti potuto vedere e non hai visto non lo vedrai mai, il mondo ti ha chiuso fuori lasciandoti dove la luce non ha voglia di arrivare, nella periferia noiosa e anonima, nel grigio assoluto ai margini dell’universo», io, questo, me lo ricordo, l’ho vissuto, sperimentato sulla mia di pelle, dentro alla mia insoddisfazione, io, questo fotogramma ce l’ho anche di me stessa e delle tante persone che conosco, che sono cresciute con me. Ceccherini, nel suo muoversi chirurgico, questo fa: cuce. Sutura le nostre esperienze di essere umani con quelle di altri esseri umani prima di tutto e, leggendo queste pagine, non capiamo ma sentiamo. Che è qualcosa di molto più complesso da conquistare e permanente.
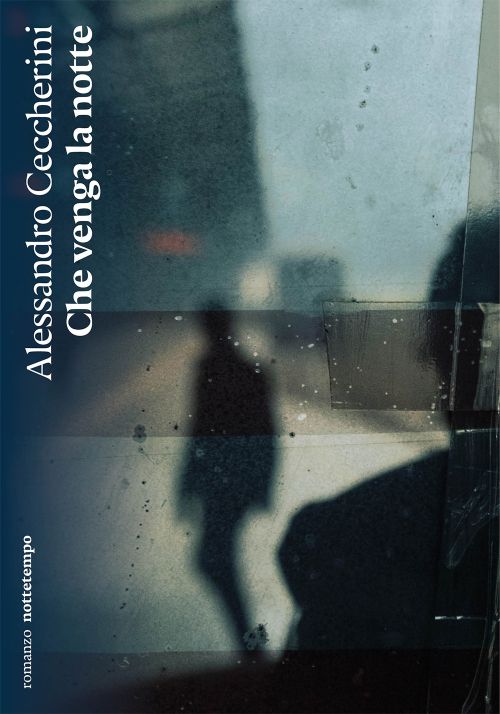
L’autore, muovendosi nel buio, tappando tutte le nostre finestre perché al buio anche noi dobbiamo stare per ricordarci gli anni in cui eravamo spaventati dai mostri che nel corridoio ci aspettavano se fossimo dovuti andare in bagno, ci lascia cadere, come negli incubi, preparandoci a quando, questi, diventeranno reali. «Lontano dall’incubo straripato dal regno del sogno a quello dell’atto»: noi ci siamo, siamo lì, in quelle notti, in quelle stanze, con quella paura, che è ed è sempre stata solo nostra. Quando, nel descrivere l’omicidio, Ceccherini scrive «di colpo lei si muove e le sue gambe cadono sulla moquette», si sente il tonfo. Che è lo stesso del cuore che stantuffa e si tuffa nell’angoscia. Era, questo, qualcosa a cui non avevo mai pensato, Che venga la notte mi ha permesso di provarlo.
Non voglio più chiedere all’autore perché l’abbia fatto, voglio dirgli grazie.
Grazie per averci permesso di sentire «un urlo che tutti conoscono ma nessuno vuole sentire» e di averlo fatto con una delicatezza che avevo dimenticato esistere.
