Solare: «spalancato nel coraggio della luce».
Dopo tre anni da Alfabeti della gioia, Gianluigi Gherzi torna di nuovo insieme ad AnimaMundi a porgerci il suo invito all’azione, alla creazione di destini, personali e collettivi. Ci riconsegna alla gratitudine, esorta a perderci in piccole piazze, a «sentire il petto fradicio d’esultanza».
Poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Insegna teatro e scrittura, negli ultimi anni ha tenuto numerosi seminari dal titolo La poesia nella voce in cui esplora il rapporto tra scrittura poetica e oralità, in cui insegna come agire le parole e il corpo della poesia.
Anche questo è un libro generoso, che «si fa largo per proteggerci perché il nostro canto continui ad essere dono per chi passa distratto».
Solare apre alla commozione del buio. È un libro vivo che sancisce la fine della paura di guardare e di essere. Un libro pieno di luce «del tutto esposto, tutto aperto, tutto acceso».
È nato come diario dell’estate, ricco di strade, luoghi e percorsi che tentano di tracciare un cammino nuovo, capace di rendere più leggero l’attraversamento dell’oscuro.
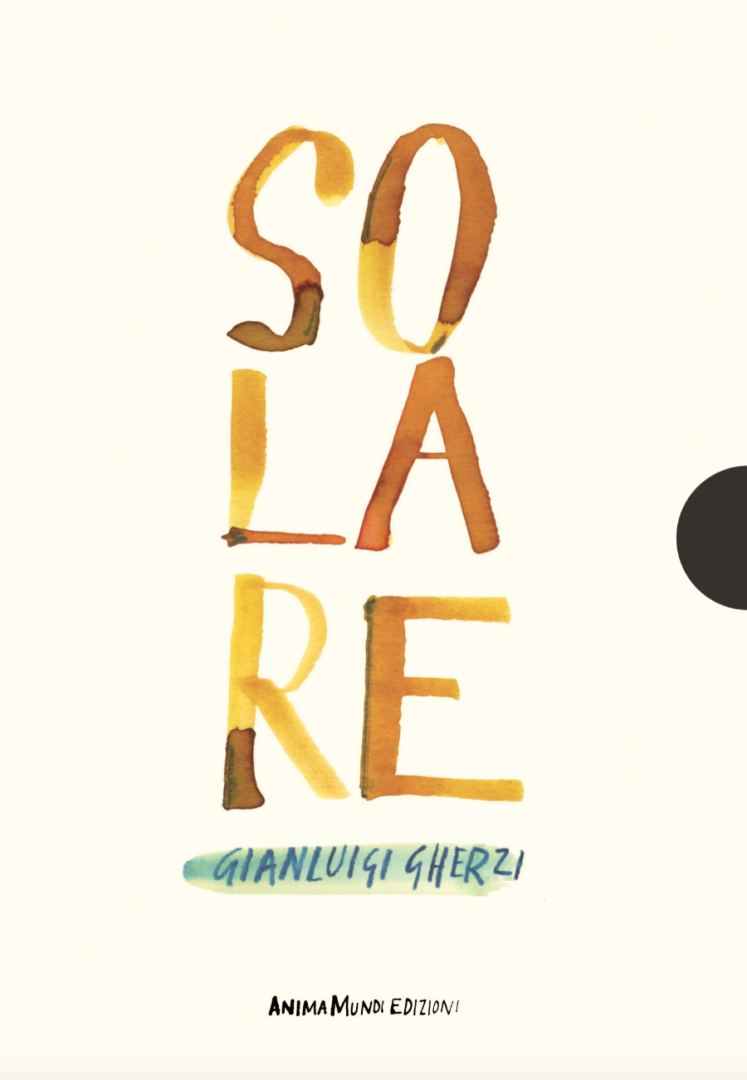
In questa conversazione, che ha la grazia e l’intimità di una foglia che vola tra paese e paese, che è dono e cerimonia, abbiamo provato a sondare l’origine di questo incanto dei sensi. «Che il bello non è folgore di un attimo, è costruzione».
Anche in queste pagine torna a scrivere con la voce, animato dall’urgenza di dire.
Che cosa vuole dirci con questa nuova raccolta? Perché ha scelto la parola Solare come sigillo?
Solare è una parola strana, quasi difficile da pronunciare soprattutto in tempi in cui la dimensione del buio, del lutto, dell’oscuro, sembra la dimensione dominante all’interno delle vite di tante persone. Forse proprio per questo accettare di scrivere un libro sul tema della luce, dell’apertura, del viaggio, del cammino, mi è sembrato un atto giusto per onorare una resistenza a questo clima e a questo contesto culturale. Una resistenza che non si ammanta semplicemente di pessimismo, di denuncia, ma che mette in primo piano queste grandi forze organiche umane ma anche culturali e politiche che ci permettono di essere testimoni di questo tempo senza diventare fino in fondo tutto il brutto e tutto il lutto del nostro tempo.
Torna anche la connessione profonda con gli elementi della natura, con il «meraviglioso selvatico dentro di noi»: il cielo, la terra, la pietra, gli alberi, le foglie. Rinnova la sua dichiarazione d’amore per i cammini?
Sì rinnovo la mia dichiarazione d’amore per il naturale, per il selvatico, per i cammini. Ci sono momenti e dimensioni della vita che ci permettono di approfondire lo sguardo sulla realtà, di essere pienamente presenti alla vita. Quelle dimensioni non vanno relegate solo a un momento di distacco, di vacanza, un momento che normalmente corrisponde con quei giorni di estate in cui siamo, a volte, un poco più liberi del solito, ma quelle dimensioni vanno ricordate sempre, in tutti i giorni e in tutti i mesi dell’anno, perché sono dimensioni che ci fondano e ci allargano l’anima, e nel momento in cui fondano e rifondano ognuno di noi, diventano anche parte di un linguaggio universale e popolare, con cui creare anima nel mondo che ci sta attorno.
Sono frequenti i versi in cui sembra sollecitare l’anima e lo sguardo a favore della bellezza, intesa «come suono che arriva dall’origine».
Avevo molta voglia di parlare di bello e di bellezza, di parlare di un bello e di una bellezza che a volte non si presentano immediatamente come una dimensione facile, esauribile nello sguardo che magari attraverso uno scatto, una fotografia, una cartolina, esaurisce il nostro rapporto con questa dimensione. Bello, bellezza, sono dimensioni che ci coinvolgono profondamente e ci richiedono impegno fino all’ultima energia, perché non sono dimensioni facili, ma sono conquista dello sguardo che riesce a trovare il bello e la bellezza appunto nei punti più oscuri, nelle caverne preziose che portiamo dentro di noi. Bello e bellezza richiedono quindi non il rapporto facile con due dimensioni romantiche o estetiche, ci chiedono di parlare di quello che di più prezioso noi riusciamo a distillare nel nostro rapporto con il mondo.
Quando riusciamo a farci carico della bellezza abbandonata?
Certo ci tocca farci carico della bellezza abbandonata, e il primo farsi carico sta dentro la dinamica dello sguardo che osserva e non dimentica, che rende prezioso quello che è dimenticato, ma farsi carico della bellezza abbandonata è anche un atto politico nel momento in cui incontriamo luoghi che sembrano fuori dai riflettori, trascurati, lasciati andare, paesi e quartieri che cadono a pezzi. È compito di chi si pone in un’altra maniera all’interno del mondo riattraversare quei luoghi dove c’è bisogno: restaurare, curare il mattone malato, ridare senso e gioia dello sguardo e ai percorsi che che noi possiamo fare all’interno di tutti quei luoghi.
Come si fa a cercare ogni giorno il passo che ci solleva?
Il passo che ci solleva nasce dal rifiuto di tutti quei passi che ci fanno strisciare dentro un malinteso realismo, troppo aderenti e succubi rispetto alla realtà, percepiamo il passo che ci solleva in ogni secondo, in ogni ora, in ogni giornata, lo pratichi nel momento in cui senti che il tuo muoversi può diventare parte di un canto e di una riflessione umana e culturale e politica sul mondo, il passo che ti solleva è quello di cui abbiamo bisogno per non annegare nella scontatezza e nello sguardo diventato cieco.
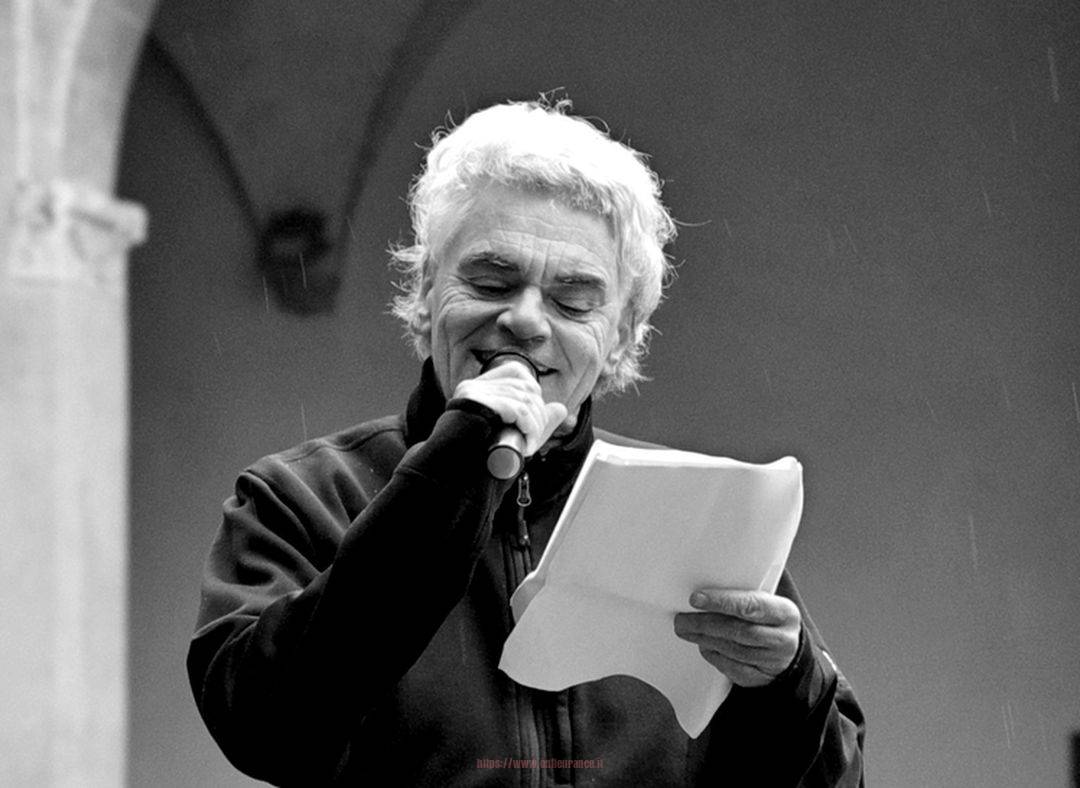
«Di tutti i momenti, i più profondi dentro di noi sono quelli in cui siamo non stati». Che cosa intende esattamente?
Per momenti in cui noi «siamo non stati» intendo quei momenti in cui la dittatura apparente dell’esserci, della presenza, si è incrinata per lasciare spazio a un ampliamento dell’io e del rapporto con le cose, con i mondi, per lasciare spazio all’irruzione anche di mondi come quelli vegetali e naturali che accompagnano e sono presenti nella nostra vita e che spesso dimentichiamo. Parlo di “non essere”, per lasciare spazio alle grandi forze che animano la nostra anima: la meraviglia dell’amore e dell’erotismo, non essere vuol dire esserci stati più profondamente e con un’attenzione meno centrata sull’ego sul pensiero contingente, sui piccoli calcoli utilitaristici che a volte prendono il sopravvento nel nostro agire.
Poesia e teatro.
Qual è il filo che li tiene uniti? Come ha imparato a intrecciarne le trame?
Io so che la poesia è nata perché una voce ha deciso di portare delle parole alle orecchie, al cuore, alla presenza, di chi la stava ascoltando, io so che la poesia è nata orale. Omero non scriveva libri, non li poteva scolpire sulla pietra, io so che quindi il rapporto tra poesia e teatro, inteso come momento del qui e ora in cui si sta davanti una persona, è profondissimo e antichissimo. Credo davvero che questa nuova ricerca di un rapporto col teatro che è presente nello sviluppo delle opere di molti poeti – non a caso molti poeti tra l’altro vengono da un’esperienza del teatro e dell’essere attori, penso un nome tra tutti, Mariangela Gualtieri ma ne potrei fare anche molti altri; penso al rapporto intensissimo col teatro che ha avuto un grande poeta che è Franco Loi, questo per dire che non si inventa niente – quel rapporto con il teatro è strutturale, organico nell’atto poetico, è il rapporto in cui la poesia prende vita in un tempo, in uno spazio preciso, guardando negli occhi pubblici e persone precise. Quel rapporto così strutturale e organico diventa fondante oggi per tutte le pratiche che vogliono fare uscire la poesia da circoli troppo ristretti e troppo specialistici di ascolto e commento tra persone che pensano di avere già capito tutto dei testi con cui entrano nel rapporto.
Ha portato spesso l’esperienza della scrittura poetica all’interno di centri per migranti, nei centri sociali giovanili e nelle periferie delle città.
Che cosa (o chi) le è rimasto?
Ho capito che la poesia poteva essere una dimensione assolutamente popolare e condivisa quando stavo in Nicaragua lavorando in un progetto con i bambini di strada di Managua, parlando con le persone. Lì mi sono accorto che qualsiasi persona, anche la più umile, anche qualsiasi contadino analfabeta, se gli chiedevo della poesia, quasi sempre teneva a memoria una poesia che recitava con la stessa semplicità e la stessa forza che se avesse cantato la propria canzone preferita, poesia-canzone.
Mi sono ritrovato questa dimensione un’altra volta in un reading, in una situazione occupata a Milano, dove si incrociava il lavoro dei musicisti e dei poeti, io ero molto preoccupato perché dovevo leggere dopo un rapper, un cantante per me molto importante che si chiama Rancore, in quel luogo sentire che non cambiava l’atteggiamento del pubblico rispetto a quello che arrivava, che con la stessa semplicità e forza e potenza si accoglievano i versi della poesia come atto musicale e i testi che portavano i cantanti come testi poetici è stato un altro grande segnale che era possibile incontrare anche pubblici vasti, estremamente popolari, molto giovanili in quel caso, e sentire che la poesia era un linguaggio forte e dell’oggi.
L’ultima cosa che voglio raccontare è che per anni ho lavorato in un quartiere di Milano, con il teatro, quel quartiere si chiama via Padova, una delle zone più multietniche di Milano. Avevo organizzato una biciclettata, facendo imparare a ogni persona che partecipava una poesia a memoria, una poesia scritta da un autore non europeo. Quando eravamo tutti insieme in bicicletta avevamo dei corali in cui insieme lanciavamo una di queste poesie, poi si arrivava davanti a una panchina di giardino, davanti al tavolino di un bar e si chiedeva con umiltà alle persone se potevamo leggere una poesia, quel dono non solo non è stato rifiutato ma è stato accolto con un sorriso e con un rispetto straordinario, alla fine quando regalavamo alle persone un fogliettino con scritto sopra il testo della poesia che avevano ascoltato, c’era interesse e riconoscenza per questo gesto. Così, per tentativi, si è sviluppato il mio rapporto fra la poesia e pubblici anche non convenzionali o chiamiamoli pure strani, con cui sono entrato in rapporto e tutte le volte c’è stata la sensazione di una grande felicità e di uno slargamento forte nel senso di recitare e di produrre poesia.
«Ci sono giorni in cui l’amore chiede la carne come campo fiorito».
Da quale fondo di se stesso è emersa questa immagine?
Perché l’amore è fatto anche e soprattutto di corpi e di carne, e allora riconoscere il rapporto con tutta la poesia dei corpi, degli incontri, dei baci, mi sembrava qualcosa di importante. Sicuramente questo fa parte della mia vita ma vorrei dire che fa parte anche della necessità di non scindere più tra il cosiddetto spirito e la cosiddetta materia, tra l’anima e la carne, tra il pensiero che si pone sempre alto e la pratica dei sensi che sembra essere destinata a una zona apparentemente inferiore. La poesia non può vivere se accetta queste divisioni così manichee, se non s’incanta del concreto incontrarsi ed amarsi dei corpi.
La prima volta e l’ultima. È questo il segreto del tempo e della poesia?
Credo proprio di sì, credo che tutte le volte che noi rompiamo la linearità del tempo, una cronologia scontata delle cose e delle emozioni, per renderci conto che davvero ogni momento ogni esperienza che noi stiamo vivendo la stiamo vivendo per la prima volta, perché ogni volta è diverso, perché non è vero che tu certe cose le hai già fatte e quindi le conosci già perfettamente, perché sono cambiate le cose, perché sei cambiato tu, perché è cambiata l’emozione. Tutte le volte che fai questo e senti l’attimo come l’attimo che parla di una prima volta, ma anche tutte le volte che senti l’attimo come qualcosa che parla dell’ultima volta di una cosa che non potrai più rimandare o pensare di rifare all’infinito, e che quindi dovrai raccogliere nella dimensione struggente dell’unicità di quel tempo e di quell’esperienza, tu senti che il tuo rapporto con la vita diventa molto più intenso e molto più profondo e quel rapporto intenso e profondo alimenta la poesia e forse davvero la poesia parla sempre di esperienze che si pongono fuori dalla scontatezza della ripetitività per dichiararsi come primo o ultimo momento, come prima o ultima volta. Mi piace pensare questo.
«Mi piacciono i paesi
dove attaccare
a ogni angolo di pietra
una targa in ceramica e una poesia,
che quel canto non si perda».
In copertina: fotografia di Andrea Semplici
