Non c’è dubbio che la letteratura condivida col sacro alcuni elementi di fondo che ne fanno un terreno in cui muoversi con la massima circospezione. Riti iniziatici, interdetti, protocolli obbligati, caste sacerdotali a presidiare ingresso e uscita e persino una cosmogonia ufficiale con cui s’intronano i custodi dell’universo mentre i perduti si assegnano all’infelicità eterna. Questo complica, e non di poco, la vita del lettore occasionale, sempre esposto al rischio del turista che nel Duomo del centro città cammina importuno tra i banchi mentre il sacerdote celebra la messa: lo sguardo di biasimo dei fedeli si salda al sussiego istituzionale dell’officiante in un clima che consegna il turista a un’esperienza feroce e fatale di disagio e spaesamento. L’esito è il più terribile dei dispositivi di inibizione del piacere: il senso di colpa.
Il pericolo è tanto più serio quanto monumentale è l’edificio in cui il lettore vorrà tentare le sue frivole sortite: i riti saranno tanto più lambiccati, i protocolli tanto più cavillosi, le caste tanto più gelose del sapere riservatissimo di cui si giudicano depositarie. E questo è senza dubbio il caso di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust: un ciclo di sette romanzi, storia di una vocazione letteraria che, dice il suo autore, danno forma a una cattedrale. Ed è chiaro che il rispetto e la devozione comandati da un parallelo talmente audace fanno appello non tanto alla facoltà di giudizio estetico quanto alla grazia della fede – di cui, si sa, il fedele non può far dono a se stesso, ma sempre viene dall’Alto.
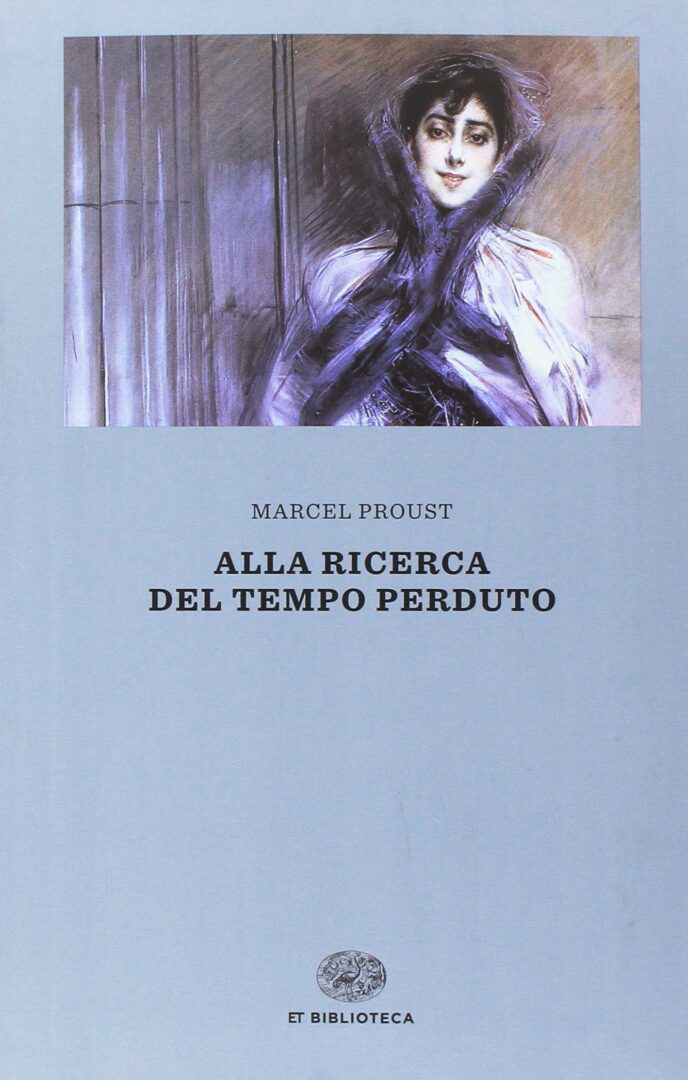
Non stupisce quindi che Alessandro Piperno, in Proust senza tempo (Mondadori), evochi esoterismi, orfismi, idolatrie, che segnano un confine rigido tra devoti e laici. Si confessa infatti «seguace di una vera e propria consorteria che annovera tra i suoi adepti individui tra i più disparati, e non tutti raccomandabili […] Quindi, snobismo e idolatria. Ma non solo […] non si può prescindere dal sentimentalismo». Insomma, c’è tutto quanto fa di un oggetto a prima vista profano come un libro un’autentica ierofania: l’esplosione del senso primordiale e metafisico di un’esperienza che scarnifica l’umano e lo riconduce a una mostruosa e vorace conoscenza di Dio. Questo è decisamente troppo per il profano che tenta qualche timido carotaggio, magari alla ricerca di un poco di piacere.

Ma esiste un Proust che non costringa a una devozione quasi sacrificale, che consenta una visita rilassata, affatto ignara dei richiami al dogma? La risposta, benché misurata, è affermativa, se si legge un libro che meritoriamente raccoglie alcuni scritti di Francesco Orlando, In principio Marcel Proust, a cura di Luciano Pellegrini (Nottetempo). La chiave di questo Proust possibile e alternativo è la “mondanità”, in virtù della quale Orlando rivendica un gusto legittimo della frivolezza a piena disposizione del lettore profano. Senza dubbio, una tale disposizione al superficiale potrebbe stupire, e invero stupisce, se è vero che il critico palermitano ha sempre fatto propria un’ermeneutica che investe il profondo, ricerca i rimossi, evoca lo spirito freudiano per individuarei nessi in cui emerge la dinamica tra repressione e represso. Se non bastasse, Orlando ha nel tempo messo su una poderosa casistica sensibile alla storia e all’avvicendarsi di fatti ed eventi. Un critico, insomma, che ha congegnato il suo mestiere in una dimensione interamente psicologica, diacronica, storicistica. E qui, per il divertimento e la frivolezza c’è poco spazio. Ma In principio Marcel Proust, con tutta evidenza, ci presenta un altro Orlando per tramite dell’altro Proust e un altro Proust per tramite dell’altro Orlando. Tutto questo sa di doppio, che è figura stantia e un poco noiosa, eppure in questo caso sa promettere divertimento. Seguiamone quindi le tracce.
Il libro apre con un testo postumo, Proust e la madre, le lettere, in cui sin da subito Orlando offre la chiave del tradimento di se stesso che si consuma in questa raccolta di saggi:
«Sciolsi il nodo presentando Proust come il critico radicale di ogni illusione che concepisca l’identità del soggetto e dei suoi oggetti come una sostanza, che accordi loro la minima stabilità: al punto da non lasciar quasi sussistere altro, del nostro io, se non contraddizioni e metamorfosi».
Per Orlando, Proust è un discepolo tardo di Spinoza, che mette a punto un colossale progetto di smantellamento dell’idea moderna di soggetto unitario, che ha inizio con la nascita e si congeda con la morte. Proust espone chi legge all’esperienza di una metafisica del disfacimento e della parcellizzazione. Altro che le solide fondamenta del notissimo freudo-marxismo orlandiano: nel Proust di Orlando si traballa e si rischia di cadere per ritrovarsi frantumati come in un’eterotopia di Manganelli, in una sciarada di Borges, in un’antilirica di Sanguineti. La Ricerca, suggerisce Orlando, è innanzitutto luogo di frantumazione dell’io, ingresso nel marchingegno che scompone i frammenti sedimentati di chi legge per impastarli di dettagli che ne fanno un assemblaggio interamente nuovo. Non importa, quindi, quando si entri e in che punto dell’opera. Sembra davvero il Kafka di Deleuze e Guattari, fatto di molteplici ingressi, tutti volti a impedire l’intrusione del nemico, vale a dire la vorace propensione a dare un’interpretazione univoca di un’opera che si vota solo alla sperimentazione.

Conferma di questa lettura la troviamo nel saggio forse più importante, Marcel Proust dilettante mondano, e la sua opera, risalente al 1972. Se si lascia da parte una sintesi che non interesserebbe nessuno, possiamo ricavarci subito il nocciolo esperienziale prima che teorico: se Balzac e Zola credevano ancora in una letteratura che potesse rispecchiare il reale per denunciare quei rapporti di dominio che su di essa si irradiano a farne campo di sfruttamento parassitico, quest’attitudine per Proust era del tutto fuori tempo, oltreché fuori fuoco. Il mondo, come Parigi, era cambiato, era davvero diventato mondo: impossibile da rappresentarsi come totalità persino nella scala ridotta che un romanzo pure consente. Mentre la critica della società era operazione da racchiudere in un archivio di storia della cultura, il testo proustiano optava per la deflessione, che si faceva ripiegamento su sé: «La tendenza che presto avrebbe portato, anche nella narrativa, l’arte a parlare dell’arte, l’opera a rispecchiarsi all’interno dell’opera, il linguaggio a farsi metalinguaggio che prende per oggetto se stesso».
Intuizione, questa, più che acuta: quando il mondo si fa irrappresentabile, il testo letterario prende a rappresentare sé stesso, a intendersi come mondo da presentare e presentificare. Il romanzo si fa metatesto, che non si esercita su alcun testo che “sta sotto” e “si fa oggetto”. Un autentico cortocircuito tra parola e mondo. Ma c’è di più: operare questo scostamento di portata epocale, secondo Orlando, era possibile solo a chi fosse un outsider, fosse cioè rigettato dalla casta sacerdotale che distribuisce i crismi e assegna quarti e quinti di nobiltà. È per questo che Valerio Magrelli, in Proust e Céline. La mente e l’odio (Einaudi), torna a più riprese sul «balletto editoriale» che interessò il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto. Storia nota: Proust subisce un bruciante rifiuto da parte di Gallimard, con un André Gide consulente editoriale che neppure legge il manoscritto, e pubblica a sue spese Ducôté de chez Swann con Grasset. Irresistibile la tentazione, per chiunque scriva su Proust, di richiamare il testo dell’agnizione tarda di Gide: «Per me, lei era rimasto il frequentatore dei salotti di Madame x… ez…, quello che scrive sul Figaro… La credevo – posso confessarglielo? – ‘dalla parte dei Verdurin’. Uno snob, un mondano dilettante, quel chec’è di più fastidioso per la nostra rivista» (Marcel Proust, Lettres à André Gide, Ides et Calendes, Neuchâtel-Paris 1949).

«Mondano dilettante», per Orlando, è la chiave di una condizione unica e drammaticamente fortunata, ossia quella di dover fare di necessità virtù a partire da un’esclusione che sanciva un’impossibilità e che favoriva il ripiegamento della vita sul testo: il testo come «la vera vita, la vita infine scoperta e illuminata, la sola vita di conseguenzarealmente vissuta» (Le Temps retrouvé). In questo ripiegamento, in questa necessità di distogliere lo sguardo da un mondo irrappresentabile, sta la chiave della prima persona messa a lavoro nel testo proustiano: «Qui preme solo sottolineare che il vero supporto di questa prima persona è per l’appunto il fatto, altrettanto nuovo e inaudito, che il romanzo sia romanzo del romanzo». Questa l’ulteriore traccia nel testo orlandiano che il lettore frivolo (come lo scrivente) non può lasciarsi sfuggire: il testo si permette di dire “io” perché i fatti narrati non sono che l’esito di una diavoleria, una sequenza di menzogne, l’ostentazione di una onniscienza che invero non sa un bel niente. Una sorta di rottura «del patto sottinteso tra autore e lettore», là dove «non c’è un sottinteso di veridicità, non c’è nessuna pretesa di raccontare la propria vita; e il personaggio che dice io non deve minimamenteessere confuso col signor Marcel Proust sotto pena di fare una lettura distorta».
Insomma, un dilettantismo mondano che si consente di vivere solo del suo testo e si permette di volgere le spalle a ogni grande progetto di critica della società. Un tradimento sfacciato e sofferto dell’aspirazione aurorale e critica della letteratura da parte di un Proust escluso dal sagrato, inibito a salire il gradino sopra elevato rispetto al livello della strada dove sempre rimane assieme al lettore occasionale e frivolo: questo l’ingresso a un Proust molto più accogliente del mirabolante cattedraliero della letteratura mondiale. Piuttosto, «un uomo oppresso da così gravi limiti di sanità psichica,di nevrosi, di equilibrio sessuale, di snobismo proprio nel senso più ristretto della parola, cioè desiderio di avere frequentazioni aristocratiche, un uomo così interamente fuori dalla vita sociale attiva del suo tempo» che elabora un caleidoscopio di dettagli, scene di vita minima, affetti vissuti e denegati, fantasticherie, considerazioni di ordine moraleggiante, non già volti a descrivere un mondo, ma a edificarne uno – un mondo in cui chiunque possa ritrovarsi proprio in forza della studiata infondatezza dell’io narrante: un io ordinario, certo affetto da un’ipersensibilità che ha dello psicotico, ma che nondimeno disinnesca qualsiasi tentativo di proporne una ricostruzione ordinata e unitaria.
La Ricerca è così l’alleluia del frammento, di una congerie di parti che non trova né d’altronde chiede composizione in un tutto irrealizzabile. Ogni singolo frammento si offre come ingresso nell’opera e al contempo come punto di vista sull’opera che è ingresso nella natura frammentata di chi legge e al contempo punto di vistasu di essa. Così Deleuze in Proust e i segni (Einaudi) rendeva bene l’edificio proustiano, sì come cattedrale, ma mai come compiuta totalità: struttura che pretende per sé un diritto all’incompiutezza, ai rattoppi, ai lavori di generazioni future che aspirano a un impossibile completamento. Così come il tempo della Ricerca non è mai una totalità che possa raccogliersi in un sistema chiuso, in cui il soggetto si possa ricostruire e ritrovare come per tramite di un’ininterrotta catena associativa. L’unità del testo proustiano è costitutivamente impossibile, come impossibile il suo soggetto, il quale piuttosto vienevia via catturato in frammenti incomponibili, entro una catena associativa spezzata di continuo.
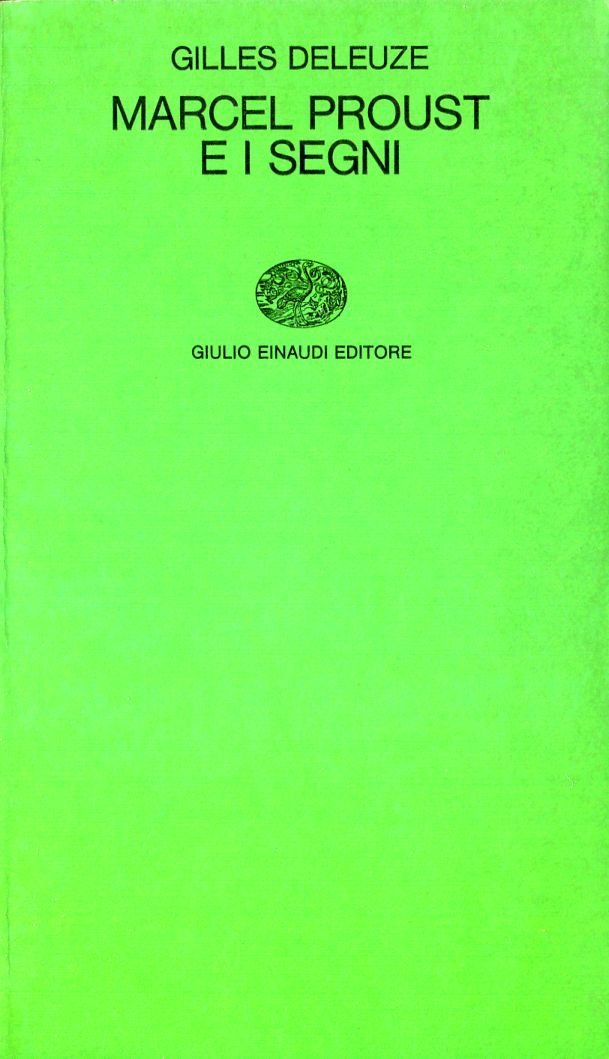
L’ammetto: il salto da Orlando a Deleuze è ardito. Eppure, mi pare plausibile, proprio perché ambedue insistono su quell’esperienza impossibile della totalità che apre a una lettura legittimamente frammentaria, quasi arbitraria, senza alcun ossequio per i rituali. L’autore consegnatoci da In principio Marcel Proust è, come il lettore occasionale, tenuto fuori, espulso, rigettato perché non partecipe dell’esperienza sacra di un lavoro certosino e devoto sul testo. Il Proust di Orlando concepisce la propria opera come un apparato o una macchina che funziona efficacemente nella dissezione del soggetto – tanto chi scrive tanto chi legge – favorita dall’ingresso in un ordine convoluto di dettagli privi di montaggio. Questa lettura credo possa offrire una risposta alla domanda, che fa da leitmotiv della Postfazione di Luciano Pellegrini, sul perché Orlando non abbia mai dedicato un saggio unitario e completo alla figura di Proust: un saggio che aspirasse alla totalità avrebbe fondamentalmente tradito l’aspirazione alla frammentarietà che innerva la Ricerca e che la rende un testo adatto al profano. Un’opera, quella proustiana, che rifiuta ogni sacralizzazione perché resta sensibile allo sgomento di chi si sente escluso dalle cerchie sacerdotali e ne fa cifra di un’esistenza mai del tutto recuperabile. Ogni pagina della Ricerca si fa così esperienza di frammentazione che vive «nello stordimento di un’incertezza simile a quella che si prova a volte davanti a una visione ineffabile quando si sta per prendere sonno» (M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto). L’esito è tra i più potenti dei dispositivi di produzione del piacere: il perdono compiaciuto della propria frivolezza.
