«Senza esser poeta non si può tradurre un vero poeta».
Giacomo Leopardi
| « […] Così nella mia selva d’esilio a piene gote un antico Ricordo suona il corno e s’accora: penso ai naufraghi, a gente sparsa in isole ignote ai prigionieri, ai vinti, e a molti altri ancora.» | «Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor ! Je pense aux matelots oubliés dans une île, Aux captifs, aux vaincus !… à bien d’autres encor !» |
Così Romano Palatroni («chi era costui?») traduce negli anni Cinquanta l’ultima strofa del Cigno (Fleurs du mal, 89) di Baudelaire. Traduce con pathos ed eleganza, scegliendo di conservare (qui come spesso fa altrove, per B. e non solo) la struttura metrico-strofica dell’originale (il verso alessandrino, le rime alterne, la quartina). Questa fedeltà alla fisionomia esterna del testo baudelairiano lo “costringe” – sul piano lessicale e sintattico – a una sua creativa rielaborazione. Palatroni procede di volta in volta, per far tornare i conti del ritmo e delle rime, per contrazioni («dans la forêt où mon esprit s’exile» > «nella mia selva d’esilio») e per espansioni («aux matelots oubliés dans une île »> «ai naufraghi, a gente sparsa in isole ignote»). Si impegna in uno strenuo lavorio formale, di scalpello, di lima e di stucco. Attiva, dove servono, le “vecchie” figure retoriche («un antico Ricordo suona il corno e s’accora»: una sovrapposizione di assonanze e paronomasie che esalta – oltre l’originale – la forza imitativa ed evocativa del verso). Deve insomma fare di necessità prosodica e metrica virtù poetica. Ma è proprio questa la virtù che si richiede da sempre a un vero traduttore di poesia. Poesia è sintesi di suono e di senso. Se si traduce il senso e si trascura il suono spesso si combinano disastri. Si creano “mostri” utili forse per una comprensione scolastica del testo originale, non traduzioni poetiche degne di questo nome.
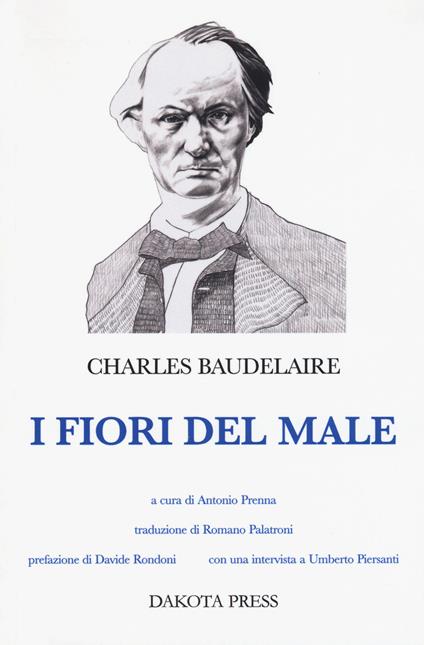
Vediamo per confronto come, pochi anni dopo, Luigi De Nardis (Feltrinelli 1964), rendeva gli stessi versi:
«Così nella foresta ove in esilio/si ritira il mio spirito, un antico / ricordo suona a perdifiato il corno./ E penso ai marinai dimenticati / sopra uno scoglio solitario, ai vinti /ai prigionieri, e a molti altri ancora.»
De Nardis rinuncia a riprodurre l’impalcatura metrico-strofica dell’originale e si limita all’adozione dell’endecasillabo sciolto. Di fatto però questa maggiore libertà metrica non riesce a produrre molto di più di una traduzione decorosa, parafrastica, tendenzialmente prosastica, dove il pathos e la struggente malinconia dell’originale si affievoliscono.
Ancor meno entusiasmante, persino scolastica, mi pare la prova che ci fornisce anni dopo (BUR 1980) Luciana Frezza:
«Così nella foresta dove il mio spirito s’esilia / un vecchio ricordo suona il corno a pieni polmoni! / Penso ai marinai dimenticati in un’isola, / ai prigionieri, ai vinti! … a quanti altri ancora!»
Questo primo campione di analisi comparata tra Palatroni e altri traduttori dei Fleurs mi pare già rivelare abbastanza della raffinatezza e della duttilità del suo modo di intendere e di praticare la traduzione poetica.
Ancora più istruttivo, in proposito, apparirà un confronto più ampio in una sfida tra le più ardue per un traduttore di poesia, data l’irrinunciabile ma pressoché irriproducibile musica dell’originale: l’Invitation au voyage. Vediamone l’inizio:
«Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.»
(FdM 53)
La strofa, conclusa da un refrain, è in pentametri+eptametri rimati secondo lo schema aaBccBddEffEGg. Quanto più misterioso e sfuggente è il fascino di quel lontano mondo di sogno tanto più B. cerca di chiuderlo in una geometria metrico-ritmica modulare: di affidarsi cioè, per evocarlo, allo studiato sortilegio di una nenia incantatrice. Ci vuole poco, traducendo, a guastare questo incantesimo. De Nardis, ahimè, ci riesce:
«Andare o sorella o fanciulla / come sarebbe dolce / laggiù andare (ci pensi?) / a vivere tu e io! / Amare a sazietà / amare e morire /nel paese che ti rassomiglia! / I soli inumiditi /di quegli inquieti cieli pel mio spirito /hanno l’incanto così misterioso / dei tuoi occhi ingannevoli, / spendenti tra le lacrime. /Tutto laggiù è ordine e bellezza, / lusso calma e voluttà.»
De Nardis scompagina con un certo arbitrio l’architettura strofico-ritmica del testo di partenza, rinuncia alle rime, riduce la cadenza carezzevole dell’originale a un balbettio aritmico dissonante, sgraziato mélange di piatti colloquialismi («ci pensi?… ti rassomiglia…») e di vieti aulicismi («o fanciulla… pel mio spirito»).
Vediamo adesso Frezza:
«Bambina mia, sorella / Che dolcezza sarebbe /Andarcene laggiù, vivere insieme! / Amare in libertà, /amare e morire / in quel paese che ti rassomiglia! / I soli stillanti / Di cieli nuvolosi /Hanno per il mio spirito gli incanti / Così misteriosi / Dei tuoi occhi infidi / Che brillano attraverso il loro pianto. /Là tutto è ordine e beltà, / lusso, calma e voluttà.»
In bilico tra un’anodina fedeltà alla lettera dell’originale e l’intento di riprodurne l’aria musicale Frezza si arena, a mio avviso, in un compromesso incoerente: conserva in qualche modo la fisionomia strofica, ma poi, non riuscendo a scegliere una delle due strade, cura senza uno schema rigoroso il ritmo e applica la rima soltanto quando le riesce.
Ma a parziale attenuante di questi tentativi poco brillanti, va riconosciuto che l’impresa in sé di tradurre l’Invitation era e rimane di quelle che fanno tremare le vene e i polsi. Tanto che Giorgio Caproni (Marsilio 2008, ed. postuma) rinunciò deliberatamente ad affrontarla ripiegando con dichiarata umiltà su di una versione in prosa:
«Bambina mia, sorella mia, pensa alla dolcezza di andare a vivere insieme laggiù! Amare a nostro piacimento, amare e morire nel paese che ti somiglia! I soli umidi di quei cieli offuscati hanno per me gli incanti, così misteriosi, dei tuoi occhi traditori, che brillano fra le lacrime. Là tutto è ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà.»
Di recente però altri traduttori sono tornati a raccogliere la sfida. Tra loro ricorderei almeno un fine critico e letterato come Antonio Prete (Feltrinelli 2003):
«Piccola mia, sorella, / quale favola bella /vivere insieme laggiù dolcemente! /Amare a non finire, /amare e morire, / in un paese che a te è somigliante! / Dove i soli inzuppati / di quei cieli imbronciati / hanno per la mia anima l’incanto / davvero misterioso / del tuo sguardo insidioso /che manda lampi pure in mezzo al pianto. / Tutto laggiù è ordine e beltà / tutto è lusso, quiete e voluttà.»
Prete cerca, per quanto possibile, la cadenza molle e avvincente dell’originale rispettandone in qualche misura la struttura ritmico-strofica: ma per tener fede a questo intento egli, mentre perviene a qualche soluzione apprezzabile («sorella~ favola bella»; «incanto/…misterioso~ sguardo insidioso»), scivola anche in alcune scelte espressive e fono-lessicali un po’ ingombranti, talvolta cacofoniche rispetto alla Stimmung del contesto («dolcemente~ somigliante»; «inzuppati~imbronciati»; «sguardo… / che manda lampi») e in qualche riempitivo inerte del metro («davvero… pure…tutto…/ tutto»).
Vero è che tutti costoro sono traduttori del secondo Novecento e oltre, un periodo in cui è avvenuta in poesia, come si sa, una vera e propria rivoluzione formale. Ma B. è poeta dell’Ottocento e non riesce ancora a riversare il suo tumultuoso e moderno vissuto interiore fuori dalle matrici della poesia classica. La forma metrico-strofica non è per B. orpello della tradizione ma conditio sine qua non per la genesi “alchemica” della sua poesia. Perciò un traduttore attuale dei Fleurs, secondo me, non può sempre e impunemente ignorare quelle matrici. Forse perché consapevole e convinto di questo, Romano Palatroni nutre, ancora a metà del secolo scorso, un grande rispetto per le forme della poesia di B. Vediamo, nel caso dell’Invitation, con quali risultati:
«Mia sorella, mia cara,
pensa che gioia rara,
fuggircene da qui per miglia e miglia;
amare in una immensa
calma e morire, pensa,
nel paese laggiù che ti assomiglia.
I soli, effusi appena
di brume nella piena
luce azzurra del cielo, hanno l’incanto
e quei vaghi misteri
d’occhi poco sinceri,
come i tuoi quando brillano di pianto.
Là, v’è solo bellezza,
ordine e voluttà, calma e chiarezza.»
Limito l’analisi a questa prima strofa. Se metto mano, da pedante, alla matita rossa e blu sottolineo subito: «gioia rara» (che non è propriamente «douceur»); «per miglia e miglia» (che non c’entra nulla con «vivre ensemble»); «immensa calma»(che ignora il senso di «à loisir»); «pensa e laggiù», per non parlare della successiva «nella piena luce azzurra del cielo» (che sembrano, tutte, a prima e miope vista piccole e grandi zeppe arbitrarie). In realtà le ampie “libertà” che Palatroni si concede sono scelte ben consone alla partitura musicale e allo spirito della sua traduzione: sia perché integrano o esplicitano senza tradirli i valori semantici dell’originale, sia soprattutto perché contribuiscono a riprodurne senza dissonanze e senza apparente artificio – anzi, con cantabile e naturale fluidità – il ritmo e la rima, senza cui la magia incantatoria dell’Invitation svanirebbe. E poi una espressione quale «i soli effusi / appena di brume» è una autonoma ma splendida riscrittura di «soleils mouillés / de ces ciels brouillés», così come «occhi poco sinceri, come i tuoi quando brillano di pianto»rendono con rara delicatezza – per litote – «tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes». Nel ritornello, infine, la sequenza dei pregi inestimabili di quel mondo ideale viene conservata ma altrimenti riordinata: diversamente dall’originale («ordre et beauté / luxe, calme et volupté») quattro dei cinque componenti della serie nominale, infatti, sono dislocati nel verso finale in una duplice coppia, l’ultima allitterante: órdine e voluttà, càlma e chiarézza; una soluzione ritmico-sintattica notevole, perché accentua, con la parallela e oscillante alternanza degli accenti tonici interni ai due emistichi, la cadenza “cullante” del ritmo, l’effetto incantatorio del dettato. Un solo elemento della serie, dislocato in clausola, viene metri causa reso più liberamente: «luxe» diventa «chiarezza», un termine che tuttavia meglio di “lusso” (e comunque in armonia con gli altri astratti della sequenza, oltre che con le diverse immagini di luce sparse nella poesia) di quel mondo ideale ed esotico trasmette una suggestione visiva, la nitida percezione soggettiva del suo ordine geometrico e della sua composta eleganza.
Nel resto della traduzione dell’Invitation Palatroni non devia da questa impostazione approdando ad una riscrittura poetica che nel suo insieme invidia poco o nulla, secondo me, all’originale:
| «Sì splendido a vedersi l’arredo, con i tersi specchi antichi; una stanza solitaria la nostra, dove odori di vaghi e strani fiori si fondono a un odor d’ambra nell’aria. E gingilli e amuleti sulle ricche pareti: l’Oriente e gli sfarzi di una volta; tutti un loro segreto diranno con discreto sussurro nell’orecchio che l’ascolta. Là, v’è solo bellezza, ordine e voluttà, calma e chiarezza. Vedi, sul mare, quanti bei vascelli cullanti sull’acque il proprio umore vagabondo: per soddisfare in ogni desiderio i tuoi sogni, giunsero a te, dai limiti del mondo. Là, quando il sole cade riveste campi e strade, monti e canali, ogni albero e l’intera città, d’oro e giacinto; e cede il mondo, vinto dal sonno, fra le braccia della Sera. Là, v’è solo bellezza, ordine e voluttà, calma e chiarezza.» | «Des meubles luisants, Polis par les ans, Décoreraient notre chambre; Les plus rares fleurs Mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l’ambre, Les riches plafonds, Les miroirs profonds, La splendeur orientale, Tout y parlerait A l’âme en secret Sa douce langue natale. Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l’humeur est vagabonde ; C’est pour assouvir Ton moindre désir Qu’ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants Revêtent les champs, Les canaux, la ville entière, D’hyacinthe et d’or ; Le monde s’endort Dans une chaude lumière. Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.» |
Facile sarebbe, anche qui, sindacare o sottilizzare sui numerosi “tradimenti” lessicali e fraseologici che Palatroni si concede per riprodurre con esattezza l’impianto metrico-strofico dell’Invitation. Facile ma assurdo. Chi abbia gusto estetico non può, infatti, disconoscere il pregio cui questa traduzione, più di molte altre, attinge: quello di restituire intere o addirittura intensificate nella nostra lingua la musica e, con essa, l’anima del testo baudelairiano. Nell’originale, infatti, l’abbandono totale al sogno e alla fantasia dell’altrove è indotto e cullato soprattutto (come il sonno infantile da una ninna nanna) dalla malìa sonora prima ancora che dal significato delle parole. Ricreare al meglio quell’incantesimo nella lingua di arrivo era e rimane per tutti, a mio parere, il presupposto ineludibile, nel caso dell’Invitation, per una traduzione degna di questo nome. Fedele a questo presupposto un traduttore appartato e “provinciale” (secondo alcuni, ancora troppo classicista) come Palatroni è riuscito qui egregiamente in una prova quasi proibitiva. Frutto di un evidente stato di grazia in cui si fondono miracolosamente insieme (con)genialità artistica, sensibilità musicale e labor limae (strenuo, quest’ultimo, e forse insonne, dato che di giorno Palatroni faceva il ragioniere…), la sua versione dell’Invitation aggiunge a mio giudizio più di quanto non sottragga alla qualità dell’originale e spicca perciò come un piccolo, tuttora esemplare gioiello di traduzione poetica.
Proporrei come ultimo campione dello stile traduttivo di Palatroni almeno una tra le famose poesie dello Spleen, FdM 78. Mi soffermo soltanto su di un paio di strofe: la prima
«Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;»
e la penultima
«Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.»
Palatroni le traduce rispettivamente così:
«Quando il cielo s’accascia come plumbeo coperchio
sull’anima che in preda al tedio si dispera
e gravando su tutto l’ampio orizzonte a cerchio,
ci versa un lume lugubre più cupo della sera;
[…]
Campane, all’improvviso, scattano furibonde
scagliando verso il cielo grida orrende e supreme,
come fantasmi erranti nell’ombra senza sponde,
che si mettano a gemere perdutamente insieme.»
Entrambe testimoniano ancora, credo, quanto l’adesione alla struttura metrico-ritmica dell’originale anche qui, come spesso altrove, giovi anziché ostare alla qualità della traduzione di Palatroni. Per esempio: «le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle», immagine già di per sé angosciosa e paradossale per il pesante materializzarsi dell’elemento più etereo della natura, diventa in Palatroni «il cielo s’accascia come plumbeo coperchio»; subisce, cioè, nel verbo «s’accascia» una personificazione drammatica assente in B. Inoltre, nella giuntura «plumbeo coperchio» la dislocazione sintattico-semantica dei termini dell’originale («pèse» ignorato da «s’accascia» viene recuperato nell’aggettivo «plumbeo») produce, per la percussione finale degli accenti combinata con il timbro scuro delle vocali e con le dure consonanze, un incremento della sensazione fisica, schiacciante, dell’oppressione del tedio. Ancora: «Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits» diventa in Palatroni «ci versa un lume lugubre più cupo della sera»; una resa che rinuncia sì all’ossimoro secco «jour noir» ma lo compensa ancora con una efficace modulazione di assonanze/consonanze («un lume lugubre più cupo») estranea all’originale, ma capace di evocare di sghembo inquietanti atmosfere cimiteriali.
Ancor più interessante mi sembra il modo con cui Palatroni rende l’incipit della quarta strofa: il punto chiave della struttura della poesia, quello in cui culmina il lento montare dell’angoscia («quand…quand…quand…») e di colpo trova voce in un assordante scampanio. Palatroni traduce questo passaggio topico con una energia espressiva pari alla semplicità della soluzione che adotta. Un vero e proprio “uovo di Colombo” traduttivo. «Des cloches tout à coup sautent avec furie»diventa «Campane all’improvviso scattano furibonde». Niente articolo davanti a «campane», loro irruzione secca, immediata – violenta – dentro una scena finora cupa e silenziosa, quasi ad anticipare di per sé la suggestione, subito dopo esplicitata («all’improvviso»), di fulminea, raccapricciante esplosione sonora; e poi, in clausola e in drammatica climax, un nesso formidabile «scàttano furibónde»: formidabile, direi, sia per la intrinseca, potente sonorità imitativa dei termini scelti e abbinati, sia per il distanziamento degli accenti tonici nel secondo settenario che riproducono, nella catena fonosintattica (trisillaba sdrucciola+quadrisillaba piana), lo scatenarsi rabbioso, forsennato e implacabile di quello scampanio.
Per questo verso in particolare il confronto con altri traduttori mi pare riesca ancora a chiaro vantaggio di Palatroni:
«a un tratto / furiosamente scattano campane» (De Nardis)
«campane all’improvviso saltano su con furia» (Frezza)
«campane tutt’a un tratto erompono furiose» (Caproni)
«d’improvviso campane esplodono furiose» (Prete)
Per entrambe le strofe proporrei altresì, come ulteriore e accreditata pietra di paragone, la versione di Giovanni Raboni (Mondadori 1973):
«Quando il cielo basso e oppressivo pesa come un coperchio / sull’anima che geme in preda a lunghi affanni,/ e versa, abbracciando l’intero giro dell’orizzonte, / una luce nera più triste di quella delle notti; […] a un tratto delle campane sbattono con furia / e lanciano verso il cielo un urlo orrendo, / simili a spiriti erranti e senza patria, / che si mettono a gemere ostinatamente.»
Concludendo: so bene che in poesia, oggi più che mai, de gustibus non disputandum; e che nelle traduzioni di Palatroni questa frequente accentuazione del pathos e del sublime, già spiccati nell’originale, a qualcuno potrebbe non garbare, sembrare forse datata, troppo letteraria, magari effettistica. Resto convinto del contrario, ma non mi addentro oltre nel terreno sempre scivoloso, per quanto ineludibile, del giudizio estetico. Credo comunque che, al di là di ogni legittima divergenza di gusto, gli esempi e i confronti che ho riportato bastino sia a comprovare il talento artistico non comune di un traduttore/interprete di poesia come Palatroni, sia a testimoniare quanto egli meriti, ancora oggi, una attenzione di gran lunga maggiore di quella che gli è stata finora prestata. Eppure Palatroni è rimasto a lungo (ed è tutt’ora) un nome ignoto ai nostri ambienti letterari, trascurato anche tra gli addetti ai lavori. Le sue traduzioni dai Fleurs comparvero per la prima volta postume in un volume edito a Milano nel 1959 dalla casa editrice Nuova Accademia ed intitolato semplicemente Baudelaire (traduzione di R. Palatroni; introduzione di E. Balmas; note di G. Regini). Nel 1961 esse vennero ristampate in un paio di edizioni arricchite dalla registrazione fonografica. Ma ben presto queste pubblicazioni sparirono dalla circolazione e la loro memoria si eclissò insieme a quella del loro autore. Allo zelo appassionato di Antonio Prenna, letterato e giornalista, dobbiamo ora la riedizione delle maggiori traduzioni antologiche di Palatroni, non solo di B. ma anche degli altri maudits: I fiori del male di Charles Baudelaire (Dakota Press, Camerano, 2015); Feste galanti e altre poesie di Paul Verlaine (ivi, 2018); Il corvo – Il battello ebbro di Edgar Allan Poe e Arthur Rimbaud (ivi, 2019). Nonostante questa lunga e immeritata damnatio memoriae, ci furono tuttavia, tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, alcuni giovani lettori che ebbero occasione di leggere Palatroni e di apprezzarlo da vicino: questo eccezionale privilegio toccò agli studenti di un liceo di provincia dove insegnava in quei decenni un grande maestro, già amico e sodale letterario di Palatroni: Marino Marini. Tra gli allievi di Marini e tra i pochi fortunati lettori di quelle traduzioni (che l’insegnante distribuiva loro in ciclostile) c’ero anch’io. Questo articolo assolve dunque, a suo modo, a un vecchio debito di gratitudine.
Immagine di copertina: Charles Baudelaire (Wikimedia)
