La vita accade, purtroppo o per fortuna.
E succede pure che dalla vita – gioco forza – ci si debba prendere una pausa, un temporaneo sciopero per evitare che questa precipiti e travolga in mo(n)di inaspettati. Succede che ci si rifugi altrove, che si svanisca per un tempo, recludendosi in luoghi lontani dall’apparire per fare il punto sull’accaduto e sul subìto prima che la sfilata ricominci e ci si rimetta a fare l’addizione delle ore e dei giorni (Jean-Paul Sartre, La nausea). Magari con dei gatti, perché no, nel numero bitrinitario di cinque più uno, magari con del verde intorno. Magari con uno di questi gatti che suona ad armonica rotta, ha gli organi manomessi dalla sorte e dalla ruota di una qualche macchina e che neppure operabile risulta, che lo si può solo amare e chiamare Giorgino sperando che la divinità dei gatti apprezzi e conceda più tempo possibile insieme. C’è poi chi questo gatto – e questi gatti – cura che nella prospettiva felina Papà Gattone diventa, divertito a fare la musica coi denti bianchi e coi denti neri, chiamato a fare i suoni e fonico prima e forse domani chissà. C’è un andare delle stagioni che scivola una settimana alla volta, ché quando ci si allontana dal tempo per capirlo meglio quello passa lo stesso e non resta mica ad aspettare tra un prrrì in gattese e un discorso netto con dio per spronarlo a fare di meglio.
Alessio Forgione in Anni felini (La nave di Teseo) di esistenze ne racconta tante, tra piccole, grandi e di dimensioni varie (al lettore l’ardua sentenza sulle misure di ciascuna): c’è Giorgino che vive nonostante, che scopre l’amore e la gelosia e la voglia, che diventa padrone della pagina e la possiede in una fiaba antica eppure nuova che alla fiera consegna la chiave e all’uomo l’interpretazione, che l’animale nobilita e non rende solo fedele amico, che rinnova le tradizioni belle o dolorose del Pallino di Bulgakov di Cuore di cane e del randagio speranzoso di Cassola de L’uomo e il cane. Sente tutto il malassemblato, si ritaglia il suo spazio tra gatti vecchi e nuovi, tra Totorro e Quello Nero, con nomi tutti altri rispetto al surrogato umano e con vite così intense perché perennemente a rischio della fine: ci si unisce, ci si divide, si sentono nel cuore le paure pure brutte – c’è il lupo da qualche parte, se morde sei finito.
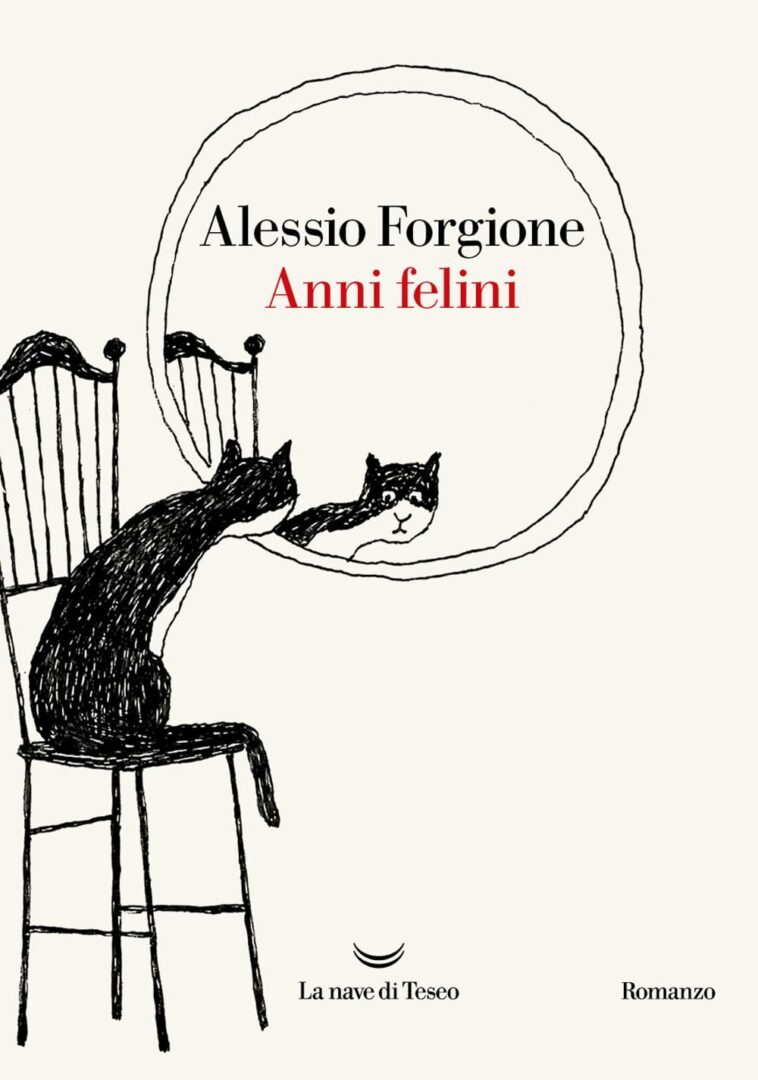
A questa vita così significativa se ne accosta o un’altra o forse almeno un paio, giacché chi ti è padre e suona i tasti nel tuo posto ha deciso di rifugiarsi – di rinchiudersi? – per scappare al proprio riflesso: è lui a perder tempo, e non tu felino, in un ribaltamento di vite e situazioni meravigliosamente riuscito. Ha deciso di farsi animale Daniele, di abdicare a se stesso: forse per sentire meno dolore, forse per scollinare e capire cosa essere – «davvero posso vivere così, senza far nulla, giocando e leggendo soltanto? È vita questa? Ma soprattutto: è una vita degna?» – in attesa di altri sommersi a lui simili e gemelli nell’incarto: uno scrittore, ad esempio, che viene dalla città delle chiese abbandonate avviluppato in un romanzo dal quale non riesce a fuggire.
Potremmo continuare per ore – e ne avremmo di prove e strumenti – ma sentiamo il bisogno di spogliarci, di dirci le cose per come stanno (o potrebbero essere). Forgione fa, ancora una volta, una cosa importante, ma questa volta nel modo più importante possibile: popola gatti e luoghi e spopola umani e illusioni per costringerci a riflettere sull’argomento che meno conosciamo, noi stessi. Quella proposta dall’autore campano è una panoramica della vita per come è e per come non vorremmo che fosse: questo libro parla a una generazione intera e a nome di un’intera generazione toccando questioni scivolose, sanguinanti, purtroppo irrisolvibili. Il contesto anzitutto, ad un passo dallo schianto – «ci sono rimaste solo le cose inutili, poiché il lavoro è scomparso, si è estinto, e pure l’ambizione» – e con esso il ruolo palliativo di qualsiasi forma consolatoria, sentimentale con la ragazza dalla pelle trasparente o d’ottundimento altro – «siamo definitivamente poveri e tutto è utile pur di non pensare che la vita è insulsa, che l’unica cosa che conta ormai è l’amore, come nel cazzo di Cinquecento». Non ci sono grandi speranze e manco piccole: sei un anello saltato e non puoi non sentirtene in colpa, ché se tuo nonno muore e sembra beato d’una vita compiuta tu dal treno sei costretto a scendere per celebrarne le esequie, ancora una volta bloccato, ancora impossibile nel dipanare quello che ti riguarda. Figurati, poi, a pensare a un oltre: cosa da gatti – «“Sarai un buon padre” gli dice e attende la risposta, ma Quello Nero guarda e ancora una volta sceglie di non dire nulla» – e mai da umani.
Forgione nello scrivere diventa specchio evidenziando le fratture di un’epoca strana, un rigurgito del Novecento che non si capisce bene dove voglia risolvere, con dio, patria e famiglia ormai così insensati eppure così attaccati addosso, con un grumo di irrisolti (chi di noi non lo è abbandoni la stanza per ammenda di bugie) che tutto avrebbero e nulla hanno – «Daniele ha tempo e spazio in abbondanza. È la cavia di un esperimento e dopo il suo martirio tutti quanti noi sapremo chi è il nemico, se il tempo o lo spazio». Con un patire, cifra comune, che in fondo, in fondo, non comprende bene i motivi del suo essere poiché così semplici da diventare indicibili (bisognerebbe scomodare l’infandum virgiliano forse per dirne).
Leggete i Forgione, le Mirabelli e le Giovagnoli, leggete di quelle e quelli che non sanno dove andare, che si sono persi. Stanno parlando di noi, mica di loro. Ci stanno raccontando di come precipitino le cose, tra un prrrì di gatto e un dio che ha perso il cielo.
