Nel 1894 Arthur Conan Doyle dà alle stampe il quarto libro con protagonista il suo più celebre personaggio, Le memorie di Sherlock Holmes. Fino a quel momento erano usciti due romanzi (Uno studio in rosso e Il segno dei quattro) e una raccolta di racconti (Le avventure di Sherlock Holmes). Anche il libro del ’94 è una raccolta di racconti.
Lo scozzese Arthur Conan Doyle era un autore poliedrico e un uomo straordinario, appassionato di spiritismo, giornalista sportivo, anima agnostica e leonardescamente inquieta, patriota fervente ma scomodo, fautore di battaglie civili a volte impopolari. È passato alla storia come un araldo della morale vittoriana, con la sua dignità e i suoi eufemismi, ma c’era molto altro in lui.
Il successo del suo personaggio lo aveva prima lusingato, poi stancato. Decise di liberarsene nel modo più pratico: uccidendolo. Salvo poi doverlo riportare in vita per l’ammutinamento del pubblico. Un destino simile era toccato a Carlo Collodi, che dieci anni prima aveva concluso Le avventure di Pinocchio, pubblicate a puntate sul Giornale dei bambini, con l’impiccagione del burattino per mano del Gatto e della Volpe; aveva però dovuto riesumarlo per le proteste dei giovani lettori inconsolabili, fra cui la figlia di Giosuè Carducci.
Ma torniamo alla morte presunta di Holmes.
Il racconto che chiude Le memorie di Sherlock Holmes introduce il personaggio del professor Moriarty, il genio del male, il Lucifero di Londra, che molti credono fosse un nemico seriale di Holmes mentre compare solo qui. Già il titolo del racconto, The Adventure Of The Final Problem, mette in allarme il lettore avveduto e manda in crisi il traduttore: il titolo infatti viene reso variamente come L’ultima avventura, Il problema finale e altri ancora.
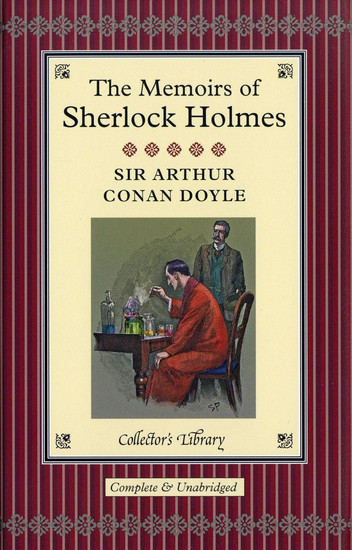
Holmes va a trovare Watson, gli descrive il lungo duello sostenuto con Moriarty e conclude: «Entro tre giorni, e precisamente lunedì prossimo, il professore con tutti i principali affiliati della sua banda cadranno nelle mani della polizia. Avremo così il più grande processo del secolo. Ma se ci muoviamo prematuramente ci possono scivolare di mano». Conan Doyle fa qui quello che nei manuali di sceneggiatura americani si chiama setting the clock: punta l’orologio, introduce un elemento temporale che aumenta la suspense della situazione. Ma lo fa in modo paradossale. Di solito, come abbiamo visto in tanti film a partire da Sabotaggio di Hitchcock (1936), l’orologio scandisce il tempo entro il quale il personaggio deve riuscire a compiere una determinata azione. Qui, al contrario, l’orologio definisce il tempo prima del quale non è possibile compierla. Bisogna far passare questo maledetto weekend! Bisogna rimanere vivi dal venerdì, giorno in cui Holmes va a trovare Watson e gli chiede aiuto, al lunedì, quando la ragnatela criminosa che Moriarty ha disteso su Londra potrà venire smantellata.
Parte una fuga avventurosa, prima in calesse, poi in treno (con Holmes travestito da vecchio prete italiano!), poi ancora in battello per attraversare la Manica, infine di nuovo in treno sul Continente, fino a Strasburgo. Il lunedì mattina arriva e con esso un telegramma da Scotland Yard: la trappola è scattata ma Moriarty è fuggito. Ora l’obiettivo del grande criminale potrà essere solo la vendetta.
I due amici decidono di defilarsi passando insieme una settimana in Svizzera, da semplici turisti, e in questa scelta si sente l’eco della passione che Conan Doyle aveva per il paese dei Grigioni. Il viaggio non è senza incidenti ma Holmes e Watson finiscono per arrivare al villaggio di Meiringen e di lì salgono ad ammirare la celebre cascata del torrente Reichenbach. Li raggiunge un ragazzo con un biglietto: giù all’albergo una signora inglese si sente male e rifiuta di farsi visitare da medici svizzeri (che tocco umoristico! Come diceva Shakespeare, la commedia si nasconde nel cuore stesso della tragedia). Watson, riluttante, abbandona l’amico e gli volge un ultimo sguardo vedendolo con le braccia conserte, intento a contemplare l’abisso, in una posa che non può non ricordare il quadro di Caspar David Friedrich Il viandante sul mare di nebbia. Ma all’hotel il padrone, sbalordito, spiega a Watson che non c’è nessuna signora inglese malata, bensì c’è stato «un signore inglese alto» che è però uscito dall’hotel dopo di loro. Stretto dall’angoscia Watson ripercorre i propri passi, zoppicando per la sua vecchia ferita di guerra. In cima all’orrido non c’è nessuno. Solo le tracce di un combattimento accanito sull’orlo dello strapiombo e una breve lettera di Holmes.
La lettera inizia con queste parole stupefacenti:
«Mio caro Watson, posso scriverle queste poche righe grazie alla cortesia del professor Moriarty, il quale aspetta che io abbia terminato per concludere la discussione dei problemi esistenti fra noi».
Poco importa il resto e d’altronde Conan Doyle liquida in una ventina di righe l’epilogo: la ricostruzione della lotta mortale dei due grandi avversari, la loro caduta, avvinghiati, nell’abisso; e poi il processo all’organizzazione di Moriarty, grazie alle prove raccolte da Holmes. Qui finisce il racconto. Finisce, ma solo in apparenza, la vita di Sherlock Holmes.
E inizia la mia ossessione per queste due pagine scarse, dall’arrivo del detective in Svizzera al commiato disperato di Watson al «migliore e più retto fra gli uomini». Un’ossessione che mi accompagna da quando lessi per la prima volta questo racconto in un libro trovato per caso, da ragazzo, nella casa dei miei genitori.
Ma perché?
Perché il professor Moriarty si batte con Holmes a mani nude?
Perché, dopo aver congegnato la sua ultima trappola, non sale l’erta che porta all’orrido con una pistola in tasca?
Com’è possibile concepire al tempo stesso la cortesia inappuntabile di quel breve colloquio che il narratore non può raccontarci perché non era presente («Lei permette, professore, che lasci qualche riga al dottor Watson?» «Con suo comodo, Holmes. L’avevo immaginato») e la bestialità, lo scatenamento di forze ferine, primitive, che segue immediatamente dopo? Le mani che cercano la gola e gli occhi dell’avversario, le braccia che avvinghiano il corpo, i pugni, i calci, i morsi, le testate, l’ansare pesante della lotta, il sudore che si mescola, la carne straziata dalle unghie, l’incontro più intimo che si possa avere con il corpo di un altro essere umano dopo il parto e il coito?
È incredibile!

La descrizione dell’aspetto di Moriarty, che si trova all’inizio del racconto, sembra addirittura rimuovere la corporeità: «Altissimo e magro, pallido, di aspetto ascetico, le spalle incurvate dal lungo studio». «Un genio, un filosofo, un pensatore astratto», lo definisce Holmes con amara ammirazione. Come poteva pensare, questo macilento professore di matematica, di affrontare e uccidere con le proprie mani un uomo prestante come Holmes, esperto di pugilato e addirittura di arti marziali (in anticipo sulle mode occidentali), più forte e più giovane di lui? Come poteva essere certo che Holmes non fosse armato, visto lo stato di allarme a cui lui stesso lo aveva costretto? Se fosse stato Holmes a poter estrarre una pistola, poche fredde e garbate parole avrebbero scritto la parola fine. Ma prima ancora del calcolo delle probabilità, prima di riflettere sulle possibilità di avere successo in questo scontro fisico, quale volontà spinge Moriarty a cercarlo, lo scontro? Quale impulso lo costringe a voler uccidere Holmes con le mani nude, contraddicendo tutta la propria vita, mettendo in scacco la razionalità che l’ha plasmata e dominata?
La cavalleria, si dirà. Il fair play britannico, l’ossequio alle regole d’onore del duello anche fra nemici mortali, raccontato così bene da Conrad nel suo romanzo breve I duellanti (The Duel: A Military Tale, 1907).
Ma scherziamo? Moriarty non fa che tirare colpi bassi dall’inizio alla fine, cerca di ammazzare Holmes in tutti i modi, lo fa aggredire per la strada, gli fa cadere addosso un masso, gli fa tendere agguati mortali, tanto è vero che quando, all’inizio del racconto, Holmes va a confidarsi con Watson chiude le imposte per paura della pallottola di un cecchino; e quando si vede capitare in casa Moriarty in persona, poco prima della fuga in Europa, appoggia sul tavolo una pistola puntata contro il suo nemico. Moriarty ha visto quella pistola. Come poteva essere sicuro che Holmes non l’avesse con sé in cima alla cascata del Reichenbach?
Una distrazione del narratore, si obietterà. La trama perfetta in fondo non esiste, qui c’è una falla come capita spesso di vederne nelle storie poliziesche.
Oh, sì, ma non in Conan Doyle! Nella sua narrativa tutti i fatti sono determinati da cause ed è più facile che un fatto sia sovradeterminato piuttosto che sciolto dalla feroce economia narrativa che domina il testo, e inserito come semplice divagazione. In altre parole: non c’è spazio per il caso. Tutto ha un perché. La causalità stravince sulla casualità, in questa eterna guerra fra anagrammi.
Non per nulla nelle storie di Sherlock Holmes trionfa l’espediente poi chiamato foreshadowing: spesso un elemento narrativo ha un significato provvisorio, ma la sua vera funzione verrà rivelata più avanti e darà una svolta decisiva per la soluzione del caso. Holmes fuma compulsivamente una sigaretta dopo l’altra e vaga in lungo e in largo in una stanza, davanti agli occhi stupiti di Watson? Lo fa perché nella cenere che sparge sul pavimento si aspetta di trovare, più tardi, le tracce di un’ospite misteriosa. Holmes è esausto psichicamente dopo lo sforzo di risolvere un caso complicatissimo? Vero, ma la debolezza e le amnesie che imbarazzano il suo fedele amico si riveleranno esagerate a bella posta, al fine di smascherare i colpevoli di un nuovo delitto.
No, nessuna svista. Conan Doyle non si è fatto sfuggire questi dettagli: li ha soppesati e alla fine li ha considerati secondari rispetto a quello che voleva dire, a questo potentissimo disvelamento del ribollire di energie animali che l’abito della civiltà riesce solo a dissimulare, non a rimuovere. Contemporaneo e collega del dottor Freud, il dottor Conan Doyle ci apre qui una finestra su abissi ben più vertiginosi di quelli di una cascata alpina. Questo conflitto fra l’esteriore, regno della mistificazione, e l’interiore, dominio di verità incontrollabili e inconfessabili, era già stato descritto da Stevenson nel 1886, con Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, dove il medico non è l’autore ma il personaggio. Gli anni sono gli stessi, l’intuizione è la medesima.
Dietro (sotto?) il borghese dedito all’educazione e alle sfumature ringhia il bruto. L’amore coniugale a luci spente è l’altra faccia dello stupro, nel ben curato giardino inglese sonnecchia la belva. La parola uccide come la spada e come la clava, di cui rappresenta nient’altro che il travestimento – o il prolungamento. Non c’è discontinuità fra queste due dimensioni necessarie dell’essere umano: l’atto di cortesia del dottor Moriarty precede di pochi istanti l’assalto fisico.
L’anima nera dell’uomo lo segue come un’ombra. E quest’ombra, a guardarla da vicino, non somiglia alla figura che la proietta: è infinitamente più sinistra, più inquietante, più rivelatrice.
Illustrazione di copertina: Valentina Merzi
