Alla fine, il più onesto e schietto fu Alessandro Baricco, che ci ha dato un taglio.
Ma tutto è iniziato nel 1886 con la pubblicazione del libro Cuore (l’unico romanzo che si porti appresso il titolo nobiliare di “libro”).
Lo spinoso problema dei nomi nella letteratura dell’Italia unita, ha origine, più o meno, lì.
Basta ridare una scorsa ai personaggi principali per rintracciare un modello che si trasformerà in una specie di maledizione (nonostante le capriole e gli esorcismi di Umberto Eco, che elogia i cattivi ma non cambia la sostanza).
Il narratore, Enrico Bottini, ha un nome e un cognome abbastanza piatti e anonimi, come lui. Altri personaggi vengono caratterizzati, a partire dal nome, in modo forse inconsapevole ma elementare: avere solo un cognome, senza nome di battesimo, aumenta la distanza emotiva (Nelli); nell’altro senso, quello dell’empatia, arrivano i diminutivi, come per Luigino Crossi (a volte “il povero”). Ma anche i cognomi si adattano, a volte si gonfiano, avvicinandosi: Garrone è grande e grosso, buono.
Sembra la quadratura del cerchio.
Dopo l’unità e fino al fascismo, la letteratura italiana si sveglia figlia di questo libro, compagno di abecedari, più che pronipote di Dante e nipote di Manzoni.
L’ipersensibile Giovanni Pascoli, altro maestro di onomatopee e diminutivi, è il suo cantore e i nomi, gira e rigira, devono tornare.
Basta andare avanti di una generazione e scorrere un lungo racconto fantastico di Massimo Bontempelli: L’acqua.
La protagonista, il personaggio con cui ci identifichiamo, ha solo il nome, con diminutivo incorporato: Madina. Gli altri, la schiera dei corteggiatori, vanno dal protocollare nome e cognome: Alberico Viètina; al solo cognome: Grisante; fino al cognome virato in titolo: il Conte.
Perché tanta incertezza?
Confessiamolo subito, i nomi dell’italiano corrente: Andrea, Marco, Giovanna e Francesca, da soli, non sembrano nati per grandi narrazioni, non portano quasi da nessuna parte (certo, ricordiamo Paolo e Francesca! Ma erano altri tempi).
Manca quel miscuglio etnico, su base biblica, che mette vicini Ishmael, Queequeg e Achab; manca la fluidità variopinta dei titoli nobiliari della Recherche (in Italia i titoli nobiliari saranno rispolverati con successo da Tomasi di Lampedusa ma sarà, appunto, una parentesi) come manca una semplice e conturbante Nanà; e dei fratelli Barletta o Rapone non potranno mai diventare dei Karamazov (infatti, più avanti, al cinema, Luchino Visconti opterà per una soluzione minimale: Rocco e i suoi fratelli).
A dire il vero questa anelasticità dei nomi italiani scompare subito se si scende di un gradino, verso il limo dei dialetti: I Malavoglia evocano tempeste e venti contrari e Padron ‘Ntoni o Mastro Don Gesualdo hanno la stratificazione necessaria per essere violentemente suggestivi.
Ma non c’erano santi né “mastri” che tenessero: l’unità italiana, con la sua koiné linguistica, avanzava e già si ammantava della cappa di piombo del fascismo. Non so chi colleghi sensazioni profonde al nome di Giovanni Episcopo. Tutto può essere, quando c’è di mezzo il vate.

Mentre Giovanni Papini metteva insieme una lunga sfilza di racconti (ripubblicati di recente) senza quasi mai fare un nome: solo un io, spesso malmostoso, e poi presenze, ombre, alter ego. Una vaghezza di ottima fattura.
Perfino il modernissimo Pirandello, che pure azzecca in pieno la spersonalizzazione del soggetto con il nome di Mattia Pascal, e un po’ meno i destini del cinema con quello di Serafino Gubbio (ma i celebri “quaderni”, su cosa diventerà il cinema, vedono davvero lungo), rischia una inquietante contiguità con gli studi notarili, quando nelle novelle evoca il Diotallevi oppure il Groa e lo Spina.
Solo qualche volpe, che ha fatto più di un giro a Parigi, tenta di sfilarsi in anticipo dalla trappola, rovesciando la realtà e portando in scena, tra i tanti, Nivasio Dolcemare, figlio del commendator Visanio e della signora Triglioni; ma si tratta di quello stesso Alberto Savinio (altro nome inventato!) che fa chiudere il settimanale Omnibus con un irriverente articolo in cui attribuisce la morte di Leopardi a un’indigestione di gelati.
Dopo la guerra lo scenario è cambiato molto. Si annusa l’aria e ci si adegua. Il primo partigiano è Johnny.
Del resto, sembrano tutti impegnati a tradurre romanzi e racconti pieni di esuberanti Tom Joad e avvincenti sir Francis Macomber. E sull’altro versante Kafka aveva da tempo scarnificato tutto fino alla K.
Si capisce al volo che a mettere in campo un ingegner Ferrazzuoli o i soliti Gabriele e Roberto si parte perdenti.
Per primo si era sguinzagliato proprio un ingegnere, un tal Carlo Emilio, che già nel 43 aveva tirato fuori, dal tascone del paltò, l’incontenibile Pirobutirro d’Eltino, al secolo Don Gonzalo. E molto dopo continuerà la sua sperimentazione onomastica infilando nel nome del suo commissario, Don Ciccio Ingravallo, tante note alte (è un don, dunque un dominus!) e basse (Ciccio!), per non parlare di quel mezzo cavallo che scalpita dentro Ingravallo, da farlo entrare, decenni dopo, al galoppo come personaggio nel libro di un altro grande scrittore: Il dottor Pasavento di Enrique Vila-Matas.

Ma dicevamo che nel dopoguerra tutti vanno in ordine sparso, tentando di smarcarsi: non ci casca Italo Calvino, che per il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, a tema resistenza, arruola un impalpabile e sfuggente Pin, poi frequenterà vari antenati, farà parlare futuribili Qfwfq, fino al romanzo in cui ci sono solo (come personaggi reali, gli altri sono irreali o viceversa) il lettore e la lettrice; e quando deve adottare un nome da storie per ragazzi, ne trova uno da spalmare lungo lungo, sulle pareti grige di una fabbrica, come fosse palta, M A R C O V A L D O!
Elsa Morante, Dino Buzzati e Cesare Pavese, ognuno a suo modo, caricano di forza nomi più o meno banali, trapuntandoli in tessuti mitici o fiabeschi. Elsa Morante, soprattutto, pratica anche su nomi comuni, di ragazzi e animali, veri sortilegi, incantandoli nella luce di stelle, poeti defunti e sogni; e con l’Amalfitano segna un punto di cui si ricorda, decenni dopo, Roberto Bolaño (alias, non per nulla, Arturo Belano) nel momento di stendere il capolavoro 2666.
E se Alberto Moravia accoglie i nomi più semplici in funzione di una riduzione esistenzialista del reale a quotidianità insostenibile, l’altro Alberto, Arbasino, invece ci sta molto attento: relativamente pochi i nomi nelle oltre mille pagine di Fratelli d’Italia, un paio stranieri, uno trasfigurato nel soprannome l’Elefante, va bene, ma proprio Desideria per indicare la donna oggetto delle passioni di tutti? Mio Dio, il maestro non avrà mica preso una stecca?
Bisogna infine segnalare una tendenza eretica, che sconfina dalla letteratura: quella che potremmo chiamare la linea Salgari-Fellini-Pratt-Conte (Paolo) che ci regala la trasfigurazione onirica di nomi e luoghi, tra Mompracem e Razzmataz, da Snaporaz a Corto Maltese. Ma, appunto, di sogno si tratta: la realtà resta grigetta.
E nonostante tutto questo, nel frattempo, la pratica del nome piatto, senza rilievo, continua a prosperare, i Mario, Elena e Gigi a circolare impunemente nella nostra letteratura, insieme ai nomi più ridondanti e improbabili.
Ecco con quanta sadica maestria Anna Maria Ortese, nel racconto Il mare non bagna Napoli, infilza (insieme, per altre ragioni, a molti altri: trattasi di spiedino) Michele Prisco: «i nomi dei suoi personaggi: Reginaldo, Delfino, Radiana, Bernardo, Iris, perfettamente letterari e senza alcun riscontro nelle nostre regioni, avvertivano del suo isolamento».
Anna Maria Ortese, poi, che sui nomi lavora come un’alchimista. Molti, nell’Iguana e nel Cardillo addolorato, mutano impercettibilmente attraverso il racconto, seguendo cauti le metamorfosi dei personaggi che designano. Così il principe Ingmar Neville può trovarsi ad essere, nelle strettoie della vita, il signor Immarino.
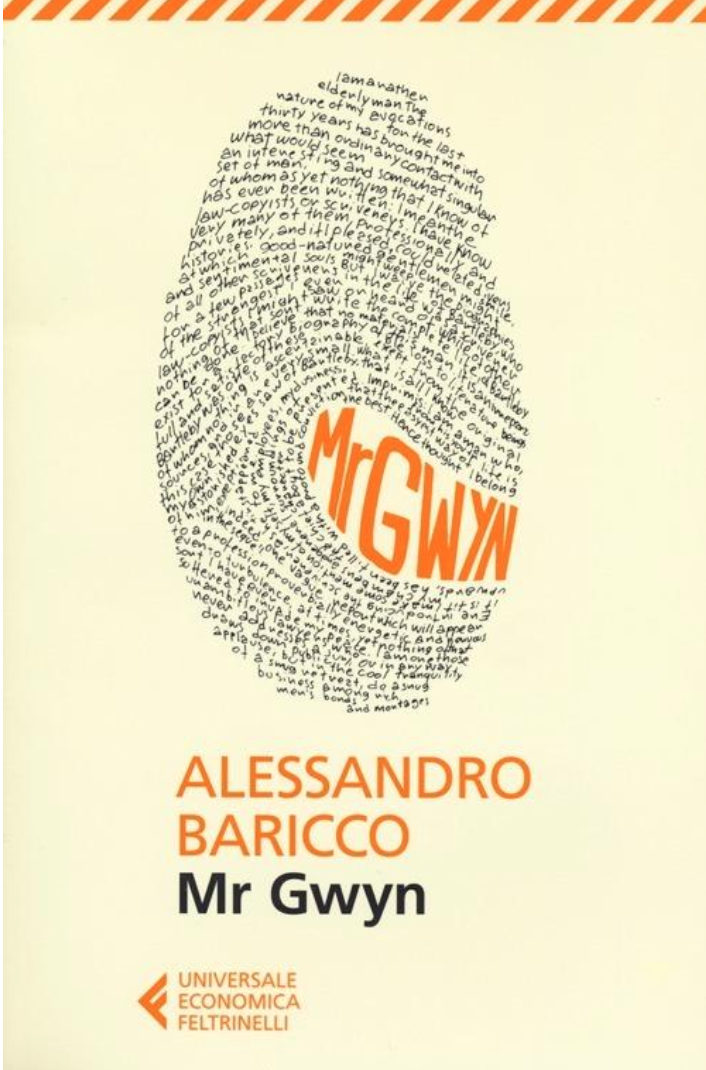
Infine, ancora nel 1982, Pier Vittorio Tondelli fallisce parzialmente il tentativo di sfornare un romanzo italiano di categoria internazionale, Rimini, infarcendolo, con perfetto ma un po’ fasullo equilibrio, di personaggi dal nome per metà italiano e per metà straniero (Marco Bauer, Bruno May, Susanna che diventa Susy).
Quindi forse, come dicevamo all’esordio, il più onesto, anche se con circa 40 anni di ritardo, è stato proprio Alessandro Baricco, con i suoi Dann e Jun Rail, i suoi Mister Gwyne Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, i suoi Mormy e Pekish.
E da qualche parte deve averlo anche dichiarato: io, con le Giulia e i Federico, una storia non riesco a scriverla. O qualcosa di simile.
Poi, dopo Baricco, il mondo è proprio un altro, esploso si potrebbe dire. Nulla più come prima.
I protagonisti delle opere mondo di Antonio Moresco e Massimiliano Parente, per esempio, sono il suonatore di prepuzio, il ginecologo spastico, Valva detta Vulva, le macinatrici. E così via.
I possibili nomi si sono accoppiati negli albi di fumetti e nei manga, moltiplicandosi a dismisura. Perfino in Italia. Qualcuno recupera anche la pratica di trasformare un’abitudine o uno stile di vita in un nome, come aveva fatto negli Stati Uniti, negli anni 70, Richard Brautigan, con il suo protagonista impersonale, che si chiama proprio: Pesca alla trota in America.
Su una linea simile, uno dei nomi più belli a un personaggio italiano, lo ha rifilato uno scrittore prolifico ma un po’ trascurato, Enrico Brizzi: riscrivendo una sua personale Odissea illustrata, l’ha intitolata a Lennon Guevara Bugatti, il protagonista.
Che non si sa dove sia scomparso, nonostante il nome strepitoso.
Illustrazione di copertina di Benedetta Onnis (@nuicollage)
