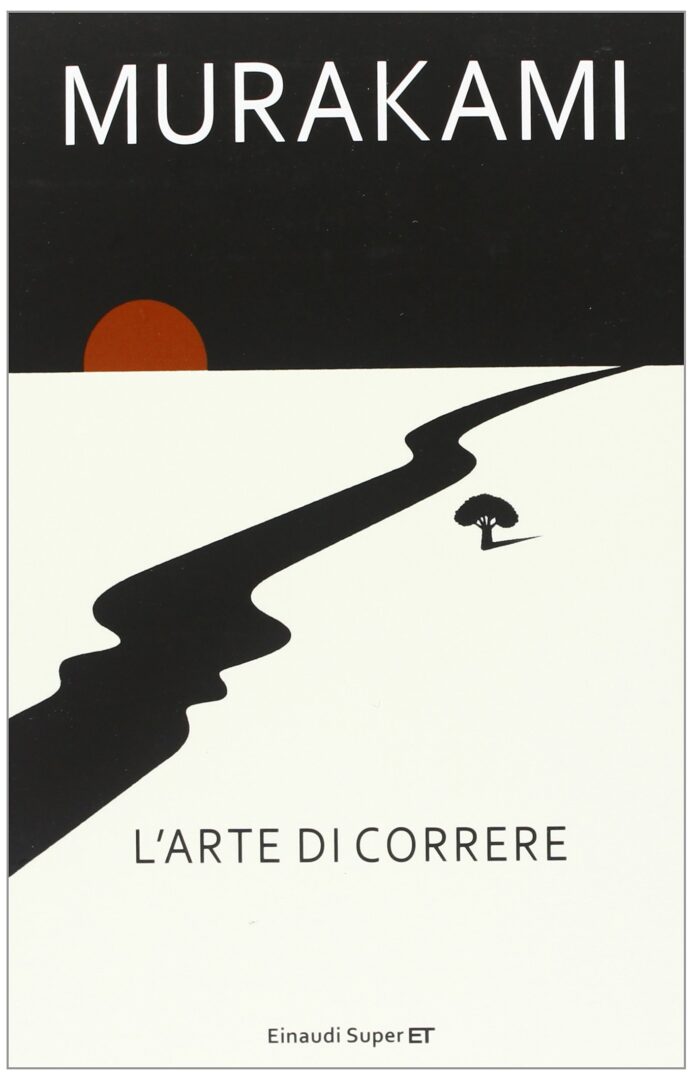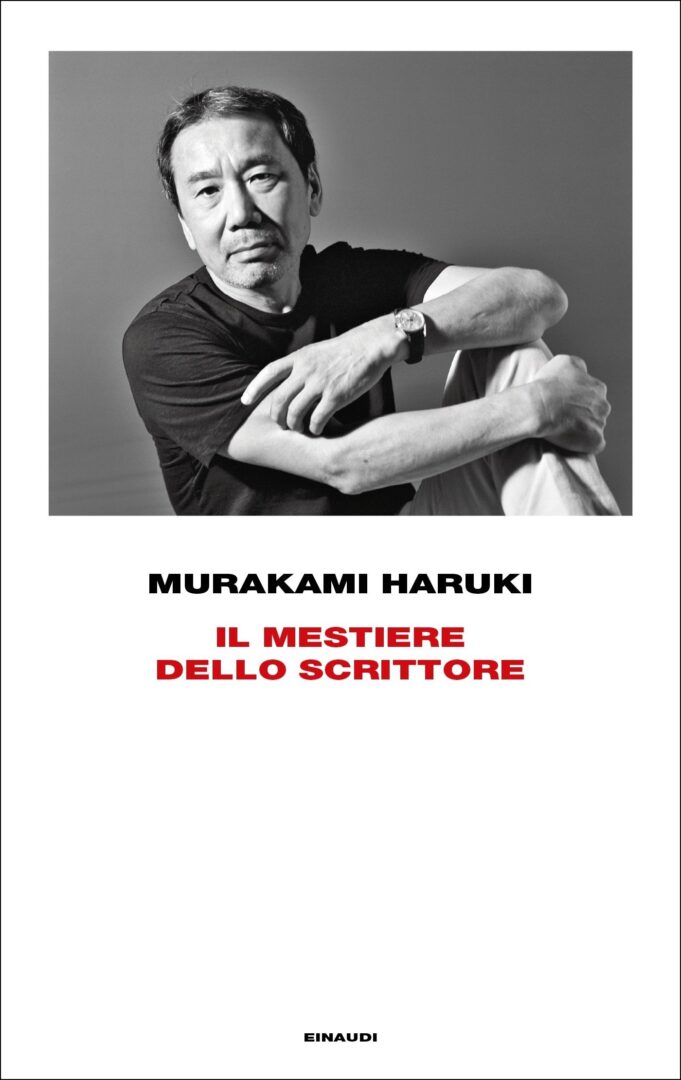Da più di trent’anni il successo internazionale ha imposto Murakami Haruki all’attenzione di tutti in quanto fenomeno, ovvero per la sua eccezionalità. Murakami è stato riconosciuto come l’alfiere di una letteratura cosmopolita capace di trascendere i confini dei singoli paesi grazie a un immaginario globale che mescola riferimenti alla cultura pop, alla musica e allo sport, ma al tempo stesso è stato visto come una pecora nera nell’alveo della grande tradizione giapponese. «Murakami scrive in giapponese, ma la sua scrittura non è davvero giapponese» ha osservato ad esempio il premio Nobel Ōe Kenzaburō, sottolineando come il suo stile non sia ascrivibile ad alcuna tradizione letteraria.
Le influenze di Murakami sono del resto inequivocabilmente occidentali, così come molti aspetti della sua biografia puntano all’Europa e agli Stati Uniti – dal jazz-bar che aprì a Tokyo poco più che ventenne con lo Stregatto carrolliano dipinto sull’insegna ai viaggi in Grecia e in Italia, fino agli anni di ricerca e insegnamento universitario a Princeton e a Santa Ana. Volendo riprendere l’immagine dello scrittore-maratoneta che emerge in uno dei suoi pochi volumi autobiografici, L’arte di correre (2007), è forte la tentazione di leggere la sua carriera come un continuo esercizio di allontanamento dal “cuore” della cultura giapponese, alla ricerca della propria identità in un contesto più ampio e contemporaneo.
Murakami assomiglia in questo senso a molti protagonisti giovani o adolescenti delle sue storie, nelle quali una situazione ricorrente consiste proprio nell’accesso a una dimensione parallela. In The Fantastic in Modern Japanese Literature (1996), Susan J. Napier nota infatti come i suoi personaggi diano l’impressione di essere sempre in fuga dalla propria storia e dalle proprie radici, sulla base di un’attitudine che sintetizza ricorrendo a una citazione dal romanzo Nel segno della pecora (1982): «E da quel momento in poi io non avevo più una città che fosse anche la mia casa, nessun tetto cui fare ritorno. Che sollievo! Nessuno a volermi, nessuno a pretendere qualcosa da me». Dal canto suo, durante una conversazione con lo psicoanalista junghiano Kawai Hayao, Murakami osservò che i protagonisti dei suoi romanzi sono perlopiù soli, non ci sono bambini e solo raramente appare qualche moglie. Per molti giovani personaggi murakamiani, in effetti, la ricerca della libertà individuale e l’esperienza dell’alienazione rappresentano due aspetti inscindibili.
In un’altra opera saggistica, Il mestiere dello scrittore (2015), Murakami ricorda che agli inizi della carriera qualcuno gli fece notare che nei suoi libri non c’erano mai persone cattive, e cercando di spiegarne il motivo traccia un’opposizione significativa tra quello che definisce un mondo armonioso e una realtà violenta. «A quelle parole mi sono reso conto che in effetti era così, e da allora in poi mi sono sforzato di introdurre nei miei romanzi dei personaggi negativi. Però non ci sono riuscito molto bene. A quel tempo ciò che mi interessava, che mi premeva, più che dare un ampio movimento alla storia, era costruire un mondo fatto alla mia maniera. Un mondo armonioso, sicuro e stabile, insomma un rifugio per resistere alla violenza della realtà.»
Ogni viaggio verso l’altrove, tuttavia, racchiude in sé anche la possibilità di un ritorno, e così Murakami, che nella stessa conversazione con Kawai disse di essere finalmente riuscito a descrivere una coppia sposata in L’uccello che girava le viti del mondo (1994-95), negli anni successivi tornò in Giappone per raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti all’attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995, in un’indagine sulla “realtà violenta” che gli fornì il materiale per la sua prima opera non-fiction, Underground (1997), e infine decise di stabilirsi con sua moglie a Ōiso, nella prefettura di Kanagawa. Al di là delle varie circostanze della vita e della scrittura di altre opere che hanno ampliato il suo immaginario, comunque, un tassello fondamentale di questo percorso di scoperta a ritroso non poteva che riguardare il confronto con la propria memoria famigliare, suggellato in un testo autobiografico nel quale per la prima volta Murakami fa i conti con la figura del padre e con le proprie origini.

Abbandonare un gatto, pubblicato da Einaudi nella traduzione di Antonietta Pastore e con le splendide illustrazioni di Emiliano Ponzi, è il frutto di un’esperienza privata dolorosa, sincera e commovente, prima che il risultato di una sapiente elaborazione letteraria. Murakami sostiene nella postfazione che da molto tempo aveva in mente di scriverlo, finché per caso non si è ricordato «che una volta, da bambino, ero andato con mio padre ad abbandonare un gatto su una spiaggia», ma in un passaggio cruciale del testo associa il medesimo ricordo all’occasione in cui ha potuto rivedere il padre ricoverato in ospedale poco prima della sua morte, e riallacciare così un legame dopo decenni di separazione.
Figlio del priore di un tempio buddhista di Kyōto e destinato a seguire le sue orme, il padre di Haruki era stato arruolato per un errore burocratico nel 1938, a vent’anni, durante la guerra contro la Cina, e una volta tornato in patria era diventato professore di letteratura giapponese all’università. La parentesi bellica scava il primo grande spartiacque tra il padre e il figlio, reticenti l’uno a raccontare e l’altro a porre domande, nel timore di far luce sugli aspetti più oscuri di quell’esperienza. Le differenze caratteriali, le aspettative dell’uno e le scelte di vita dell’altro, unite alla sensazione di Haruki «di aver tradito le sue speranze», approfondiscono ulteriormente il divario. «Quando all’età di trent’anni esordii come scrittore,» nota l’autore, «mio padre ne fu veramente felice, ma ormai la nostra relazione si era raffreddata e fra noi si era creata una certa distanza».
Il testo è il distillato di un lungo lavoro memoriale, scandito da brevi paragrafi che lasciano appena trapelare gli affetti, ma che nella riflessione e nell’interrogazione continua, spesso sotto forma di domande che rimangono prive di risposta, dischiudono orizzonti molto più vasti. Un importante dilemma per il figlio è rappresentato da due immagini del padre apparentemente inconciliabili: da un lato, l’uomo che partecipa alla decapitazione di un prigioniero, forse in veste di esecutore; dall’altro, il tranquillo studioso che si diletta a comporre haiku, e che nel 1941, richiamato in guerra, annotò questi versi: «Spezzo l’ascia / una seconda volta sullo scudo: / autunno nel paese». Cimentandosi nei panni del filologo, Haruki commenta che il padre «avrebbe volentieri condotto una pacifica vita di studio, ma il corso violento della storia non glielo aveva permesso», e intuisce forse in questo modo di essergli molto più simile di quanto non avesse mai creduto.
La distanza temporale ha reso possibile un incontro ravvicinato con la storia, che qui non è più un incubo da cui risvegliarsi cercando rifugio in un altro mondo, ma un deposito di eventi da indagare sciogliendo i nodi dell’ignoranza e della paura, prima che il tempo ne abbia fatto svanire l’ultima traccia, e con essa qualsiasi possibilità di comprensione umana. Inseguendo il ricordo di una gatta abbandonata da bambino in un giorno d’estate, come Alice insegue il Bianconiglio nella sua tana che porta al mondo sotterraneo, Murakami si domanda per quale ragione il padre avesse voluto sbarazzarsi dell’animale, e perché lui non si fosse opposto, mentre il ricordo rivela un mistero ancora più grande: tornati di corsa in bicicletta, infatti, dietro la porta di casa vedono riapparire la gatta che li aveva preceduti.
«Ancor oggi rivedo l’espressione attonita di mio padre in quel momento. Ma subito la sua sorpresa si mutò in ammirazione, e poi in sollievo. Insomma, decidemmo di tenere la gatta. Visto che aveva fatto tutta quella strada, se lo meritava, dovevamo ammetterlo.»
Il ricordo di un altro gatto scomparso in cima a un pino dopo una salita fulminea, già riproposto da Murakami in diversi romanzi e racconti – da I gatti antropofagi, nella raccolta I salici ciechi e la donna addormentata (1991), a La ragazza dello Sputnik (1999), passando per il terzo libro di L’uccello che girava le viti del mondo (1995) –, suggerisce infine che «nella vita, scendere è molto più difficile che salire», o in altre parole che il percorso più arduo si deve compiere a ritroso, in direzione delle proprie radici. Un insegnamento prezioso, per chi si mette in cammino, è allora la scoperta che «la storia non appartiene al passato. È qualcosa che fluisce nella coscienza umana, o forse nell’inconscio, è una corrente di sangue vivo e caldo che, volenti o nolenti, ci trasmettiamo da una generazione all’altra». Per questo, è davvero in virtù di una consapevolezza più profonda, e non per falsa modestia, se alla fine di un libro che restituisce ai lettori il dono di uno sguardo intimo sulle cose il “fenomeno” Murakami può affermare di essere «il figlio qualunque di un uomo qualunque», confermandosi al contempo un grande scrittore.
Illustrazione di copertina: Emiliano Ponzi