Come sempre di questi tempi connessi, potrebbe essere solo una questione di bolle, ma pare che sia ritornato il dibattito storico/critico riguardo a un film. È una situazione un po’ paradossale, visto che i cinema sono chiusi e sono apertissime solo le piattaforme on demand o streaming, ma se da un paio di anni è tornato sulla bocca dei cinefili il nome di Orson Welles – e con esso le ambiguità del suo cinema grandioso e problematico – lo si deve a Netflix. Dapprima con la proposta di uno dei film incompleti del regista, L’altra faccia del vento (The Other Side of the Wind) di cui la grande N ha finanziato la ricostruzione e il montaggio, poi con la diffusione di un documentario, Mi ameranno quando sarò morto (They’ll Love Me when I’m Dead) che racconta la figura dell’autore partendo proprio dalla lavorazione e infine con l’uscita a inizio dicembre di Mank, il nuovo attesissimo e controverso film di David Fincher.

Raccontando la lavorazione di Quarto Potere (Citizen Kane, 1941) il film riapre una vecchia querelle storiografica mettendo in dubbio l’apporto come sceneggiatore di Welles, che pure firmò la sceneggiatura e vinse un Oscar assieme a Herman Mankiewicz, il Mank del titolo. Il film di Fincher, scritto dal padre Jack molti anni fa, racconta il periodo in cui Mank è al letto per una gamba rotta dopo un incidente e deve finire la stesura di Quarto Potere entro due settimane prima di consegnarla a Welles, senza firmarla. Il dibattito è tornato fuori perché il film accrediterebbe la ricostruzione storica della critica Pauline Kael sul New Yorker, secondo cui Welles non scrisse una sola riga del film1, già smentita anni fa dal lavoro documentale di Peter Bogdanovich e soprattutto di Robert Carringer sul Critical Inquiry. A riattizzare la questione anche le dichiarazioni dello stesso Fincher, che avrebbe ridimensionato il ruolo di Welles come genio unico del film per sottolineare l’importanza del direttore della fotografia Gregg Toland nelle invenzioni del film, come l’utilizzo di lenti all’avanguardia per garantire una straordinaria profondità di campo, come mai prima di allora.
Guardando Mank però ci sono due cose che si possono affermare concretamente: che non è assolutamente un film contro Welles (che resta un’ombra incombente, un convitato di pietra fino al finale), ma racconta tutto dal punto di vista dello sceneggiatore, quasi come fosse la fantasia di un uomo che sta cercando di riconquistare il proprio posto in un mondo che lo ha sbattuto fuori, facendo i conti con la propria auto-distruttività; e che tutto ruota attorno a Quarto potere, che quel film è la pietra miliare su cui Fincher ha costruito il suo film: nella struttura narrativa a flashback, nella definizione sottilmente ironica del personaggio di Mank rispetto a Kane – e quindi nel suo ambiguo rapporto con la persona di William Hearst, l’editore a cui il personaggio di Kane è ispirato, che odia ma a cui si sovrappone –, in alcune scelte stilistiche e visive, come la bottiglietta di alcool che cade dalla mano di Mank allo stesso modo in cui la sfera di neve cade da quella di Kane.
A interessare però sono soprattutto le differenze, una in particolare: Quarto potere, a dispetto di ciò che disse Sartre2, ha una linea direttrice che dal passato passa per il presente e guarda al futuro, tanto della società-spettacolo quanto del cinema, inaugurando di fatto il cinema moderno a Hollywood; Mank parte invece dal presente e punta al passato, alla sua ridefinizione attraverso i mezzi tecnologici del futuro, in quella versione del postmoderno che qualcuno chiama post-classico.
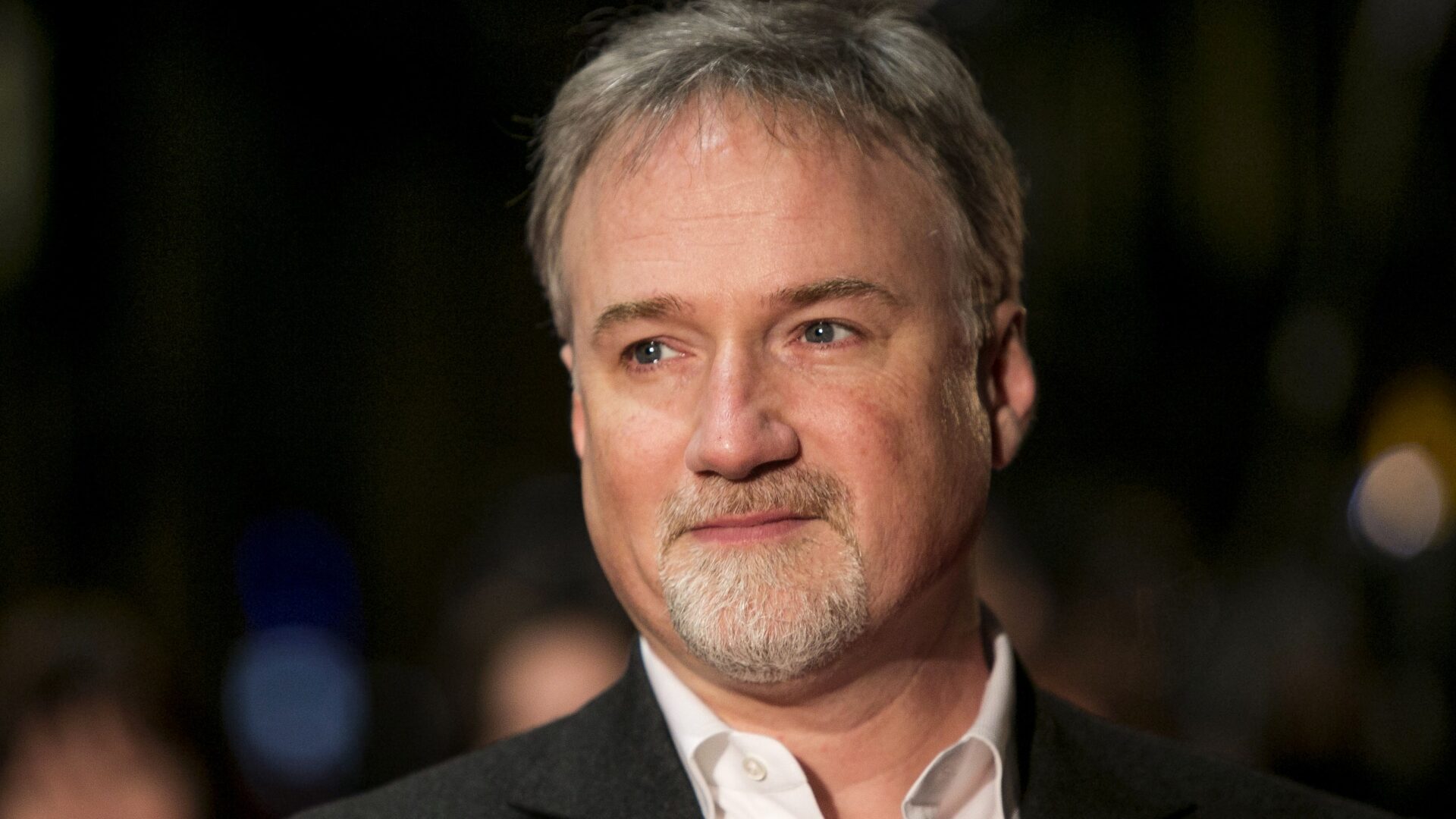
Welles metteva in scena il cupio dissolvi di un uomo che ha creato un mondo che gli è sopravvissuto, Fincher invece realizza un omaggio, un atto d’amore al padre morto nel 2003 che scrisse la sceneggiatura negli anni Novanta e alla figura dello sceneggiatore che, proprio dopo le celebrazioni di Quarto potere, venne messa in ombra dall’idolatria verso l’Autore. Soprattutto, come ha spesso fatto nei suoi film, ha attuato una riflessione sul senso dell’immagine, sul suo ruolo, sulla sua consapevole fallacia dentro il contesto in cui è creata, pur se il cinema americano continui a cercare in tutti i modi di accreditarla come unico veicolo di verità: il direttore della fotografia Erik Messerschmidt, all’esordio nel cinema, usa il digitale e l’altissima definizione per ritrovare l’immagine mitica della Hollywood anni Quaranta, il senso dei neri che si spengono quando l’immagine dissolve, aggiungendo le cosiddette “bruciature di sigaretta”, ossia i bollini con cui il proiezionista sincronizzava le immagini e cambiava bobina ogni venti minuti. Potrebbe sembrare un vezzo, e magari lo è, ma lo stesso Welles nel cinegiornale che apre Quarto potere, dopo il prologo con Kane morente, ricrea l’immagine cinematografica degli anni Dieci attraverso lo splendore del suo 35mm: camuffa la verità mentre i personaggi continuano invano a cercarla.
Fincher, la cui meticolosità pare essere solo un gradino sotto a quella leggendaria di Kubrick, va oltre la nostalgia e l’amore per immagini e immaginari del passato, come accade negli Usa da Tarantino a Stranger Things, cerca dentro quelle immagini qualcosa che il ricordo non può dare, ossia la presenza umana, più che lo spirito del tempo (come fanno un grande numero di prodotti contemporanei, da It di Muschietti a Ready Player One di Spielberg) si cerca il Tempo nello spirito di un uomo. È qualcosa che il cinema americano recente ha fatto molto poco: non solo perché poche volte si è cercato di affrontare direttamente la Hollywood classica, l’età dell’oro dei Trenta e Quaranta (viene in mente il buonismo inclusivo e scintillante di Hollywood di Ryan Murphy), ma perché Fincher lo ha fatto mediando lo spirito aspro di Il giorno della locusta di Schlesinger e Gli ultimi fuochi di Kazan – due opere degli anni Settanta che smontavano e al tempo stesso rinverdivano la mitologia della Hollywood dello studio System – con il ritratto umano, cosa non frequente nell’opera fincheriana, dove l’umanesimo ha preso le forme della tecnologia.

Fincher non ha la minima intenzione di sminuire il gigantismo di Welles, anzi, quando lo mette in scena lo riprende dal basso, proprio come Welles si riprendeva per interpretare Kane, solo lo mette in una prospettiva in cui non ha più quel ruolo che la critica (soprattutto europea o moderna) gli ha dato dell’Autore Assoluto. È un’idea che permea la cultura americana contemporanea, con tutti i limiti che possiamo riconoscere a certi approcci, ossia demitizzare, rendere umani e quindi complessi esseri e tempi che hanno assunto dimensioni epiche o intoccabili, un’idea che si contrappone proprio alla retro-mania con cui invece sono affrontati gli ultimi trenta o quarant’anni e che diventa interessante, perché filtrata attraverso la lente di un film e di un Autore che diedero il via al cinema moderno, che del cinema classico hanno distrutto parecchie convenzioni.
Nel ritrarre Mank e la sua lotta sardonica attraverso l’importanza degli altri personaggi (tutte donne: l’infermiera, l’assistente, la moglie, l’attrice) e non contro di essi, come fece Quarto potere, Fincher innesta un circuito apparentemente paradossale che ruota intorno alla figura di Welles senza raccontarla davvero, ne fa un polo d’attrazione, un centro di gravità da cui allontanarsi ma che non si può evitare, che occupa ogni inquadratura (come Kane nel film del ’41) ma in assenza. D’altronde, Welles è stato il grande assente del cinema americano, l’emarginato ingombrante a cui i film venivano rimontati e boicottati, l’esiliato costretto ad andare in Europa a cercare soldi e briciole di grandezza che ha saputo comunque rendere gigantesche, proprio come Mank alla fine degli anni Trenta, dopo le sue intemerate contro il magnate Hearst che gli costarono il posto a Hollywood. L’ombra di Welles che aleggia su Mank sta anche a significare, quindi, l’impossibilità di raccontare quel titano in maniera organica, sistematica, che ne possa rendere la problematicità e grandezza infinite.

Non ci ha mai provato nessuno a ritrarre Welles, se non come frammento (Tim Burton in Ed Wood) o dentro il meccanismo (Rko 281-La vera storia di Quarto potere) industriale, non lo ha mai fatto nemmeno lo stesso Welles nonostante l’ego spropositato, anzi ha rinfocolato quell’ego negandosi, truccandosi, mascherandosi, mostrandosi al mondo come guitto e illusionista, prestigiatore e bugiardo (il contrasto abissale tra It’s all True, film incompleto degli esordi, e F per falso, il suo ultimo film), come genio decaduto a commediante per bisogno narcisistico.
Fincher ha portato alla scoperta e riscoperta dello spettatore due figure agli antipodi e per questo stranamente tangenziali: lo sceneggiatore Mankiewicz, scrittore di grandi film come Crepuscolo di gloria di Sternberg o Pranzo alle otto di Cukor (uno che le magagne di Hollywood le aveva svelate a suo tempo in A che prezzo Hollywood? ed È nata una stella), e il regista Welles. Nonostante quel finale che costeggia la pura invenzione drammaturgica in cui i due, a distanza, si ringraziano per l’Oscar vinto insultandosi, Mank è il pretesto per far apprezzare il cinema di Welles oggi agli spettatori più giovani, se è arrivato il momento di rilanciare film forse dimenticati come Falstaff, il citato F come falso e soprattutto il magnifico Storia immortale, bello quasi come Quarto potere, il merito è di Fincher – e si fa fatica a pensarlo come un effetto collaterale – e soprattutto di Mank, della prospettiva da cui si è deciso di guardare un mondo, di riposizionare eventi, persone e immagini. La sua versione dei fatti è discutibile, storicamente non valida, ma per questo, come insegna John Ford, diventa la leggenda da stampare e quindi l’unica verità possibile a Hollywood.
Quarto potere raccontava una sola persona attraverso lo sguardo di decine di altre, Mank fa l’opposto, racconta decine di persone attraverso lo sguardo di una sola, e attraverso quello sguardo, attraverso quell’unica soggettiva, quel punto di vista che filtra tutto e a tutto dà forma riporta l’attenzione su ciò che di Hollywood si dimentica sempre: i dropout e gli irregolari, chi della polvere di stelle si è nutrito magari solo per un attimo prima di andarsene via. Come Orson Welles, per esempio.
1 Per una rapida e puntuale ricostruzione del dibattito vi rimando a Mank, a dispetto di David Fincher: chi ha scritto davvero Quarto potere, articolo di Gabriele Niola per BadTaste.
2 Sartre accusò Welles di aver fatto un film in cui il Tempo era declinato al passato, mentre quello del cinema era il presente (tesi che poi Deleuze, in L’immagine-tempo, confuterà).
