Le pizze sono state trovate nel 2005, durante lavori di ristrutturazione in un deposito del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
Si gridò al miracolo: un piccolo gioiello perduto.
In realtà solo un’esercitazione di alcuni studenti di un corso della fine degli anni Cinquanta. Ma gli autori degli spezzoni montati erano nientemeno che Marco Bellocchio, Silvano Agosti, allora giovanissimi, e la francese Agnès Varda, che a quell’epoca aveva già realizzato un lungometraggio e un documentario, e teneva un breve seminario nel Centro.
Ai tre era stato affidato un soggetto di poche righe, mai nemmeno trasformato in sceneggiatura, di Cesare Zavattini.
Prevedeva che tre registi, come nelle barzellette un francese, un inglese e un americano, realizzassero tre documentari su Roma, partendo ciascuno da un pregiudizio: per uno la città della miseria, per l’altro quella del divertimento, per il terzo la città che va in pezzi. Alla fine, secondo quanto scritto dallo sceneggiatore di Ladri di biciclette, i tre documentari sarebbero stati montati insieme in modo casuale, per un errore, ma da quel caos, invece delle tre tesi preconfezionate, sarebbe emersa, incoercibile, l’autentica umanità dei romani.
È probabile che Zavattini pensasse a un vero film, con i ruoli dei registi affidati a tre attori. Ma l’idea di provare a girare i tre documentari era al passo con l’evoluzione del linguaggio cinematografico…
Naturalmente un simile film non è mai esistito (né Agnès Varda ha mai tenuto un seminario a Roma) ma il soggetto di Zavattini sì: 15 righe che potrebbero ancora stuzzicare un produttore intenzionato a tentare, per l’ennesima volta, la sorte con la Città eterna.
Lo si trova proprio al centro di un libro pubblicato da poco da Marsilio: Soggetti cinematografici mai realizzati, di Cesare Zavattini. Quasi contemporaneamente Sellerio ha mandato in libreria Miracolo a Hollywood, il copione, dimenticato per decenni, di una commedia per il teatro di Orson Welles, che sarebbe stato pronto a farne, come di ogni altro spunto, un film; se avesse trovato i mezzi o l’occasione o forse solo l’infinita determinazione necessaria.

Insieme, i due libri fanno quasi 600 pagine di cinema mai realizzato e sembrano riaprire le porte a una carovana di sogni rimossi del Novecento: i progetti cinematografici incompiuti e quelli rimasti solo un’idea, forse scarabocchiata da qualche parte.
Se già il cinema, di per sé, con le sue babilonie e le sue medine, con le sue sale, salette e arene, con le sue cerimonie e le sue rivoluzioni, con il suo nitrato d’argento e i suoi teli bianchi, sempre a rischio di incendiare il pubblico e di incendiarsi, è stato uno spettro che ha percorso con passo etilico il Secolo breve, il cinema mai venuto alla luce è lo spettro di uno spettro: un fantasma al quadrato, capace di ingoiare esistenze.
I soggetti di Zavattini sono bellissimi.
Nel 1942 immagina un alieno scendere sulla terra a Santo Domingo, nel bel mezzo di una faida elettorale tra due famiglie, e diventare il segretario particolare del pianista Arturo Benedetti Michelangeli, in tournée da quelle parti; pur avendo intuito la possibilità dell’amore per una ragazza, dopo aver tentato di gestire la competizione, quasi una guerra civile, tra le due famiglie, l’extraterrestre decide di abbandonare il pianeta, regalando però a tutti, con l’aiuto della colonna sonora del pianista, un istante di grazia mentre la sua astronave lascia la terra. Il film statunitense Ultimatum alla terra, in cui un alieno tenta di portare la pace sul nostro pianeta è del 1951, nove anni più tardi. E solo nel 1954 sbarca Un marziano a Roma, la celebre satira scritta, sullo stesso tema, da Ennio Flaiano.
Zavattini corre, è sempre un passo avanti agli altri. Nel 1953, mentre il mondo si popola dei marziani che lui inventava durante la Seconda guerra mondiale, scrive Prima io. Nel soggetto la sfida tra due automobilisti, un napoletano e un milanese, che si sono incrociati casualmente sulla direttrice sud-nord delle autostrade italiane: mentre le auto si sorpassano, si rincorrono, si perdono e si ritrovano, le vite dei due autisti, inferociti dalla competizione, vengono passate ai raggi di una lunga, spietata, radiografia. Potrebbe preludere alla tragedia, che però non arriva: invece dello schianto eccoli impantanati in un gigantesco ingorgo.
Il sorpasso di Dino Risi sarà nelle sale nel 1962, di nuovo, nove anni più tardi; Duel di Steven Spielberg nel 1971.
E poi i soggetti in collaborazione con produzioni di paesi ispanofoni: Spagna, Cuba e soprattutto il Messico; forse gravati da qualche sovrastruttura ideologica, ma capaci di impennate e momenti di grazia.
Come El pequeño dicatator, la storia di un terribile dittatore caraibico – si intravede Fulgencio Batista – dall’estro chapliniano, alle prese con la rivoluzione: quando si tratta di fare le prove generali per la fuga, il dittatore si fa trasportare verso l’aeroporto dentro una bara ma il carro funebre, lungo la strada, si scontra con un altro carro funebre; i feretri, nella confusione, vengono scambiati e lui si ritrova al cimitero. All’aeroporto, pronta per la fuga, arriva una salma.
Il bel volume di Marsilio, curato da Nicola Dusi e Mauro Salvador, alla fine, sembra indicare una strada e, come dicevamo, affacciarsi su tutto un secolo di storie che nella lanterna magica non sono riuscite, per un motivo o per l’altro, ad entrare.
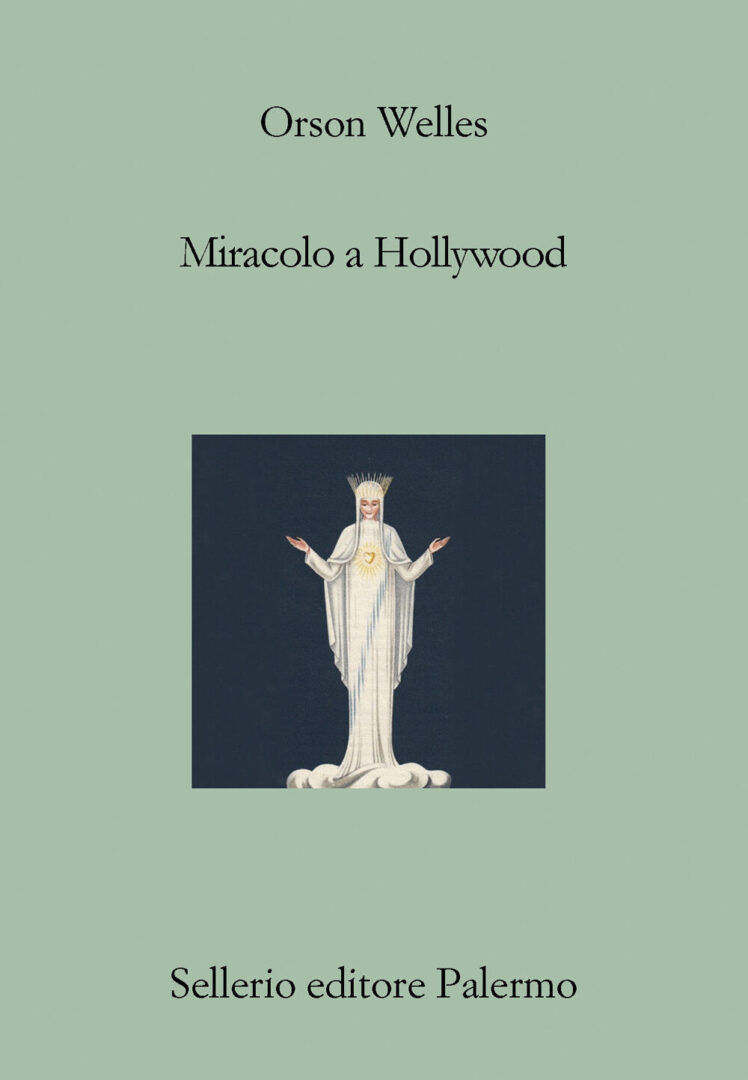
Un labirinto dell’informe, forse un immenso museo, anzi il museo per eccellenza, luogo sacro alle muse e alla poesia: più adatto ad articolare ciò che non esiste che a ingabbiare l’esistente.
La prima sala del museo, per introdurre i temi della nostalgia e dell’inesauribile, potrebbe essere dedicata alla Ricerca del tempo perduto di Luchino Visconti, di cui si esporrebbe la sceneggiatura firmata insieme a Suso Cecchi D’amico, qualche bozzetto per i protagonisti e, forse, qualche filmato dei sopralluoghi svolti in Francia.
Oppure si potrebbe iniziare da una stanza tematica, dedicata ai progetti napoleonici: il Napoleone di Charlie Chaplin, covato per oltre un decennio, tra il 1920 e il 1935 o quello di Stanley Kubrik, definito, per la sterminata documentazione raccolta, il più grande film “mai” realizzato.
Eppure no, la prima sala spetterebbe di diritto a Chaplin, per un altro film, “non fatto” quasi 50 anni dopo quello su Napoleone: The freak.
Verrebbero esposte le grandi ali preparate con meticolosità per la figlia Victoria, in lana di vetro, coperte di piume di Cigno.
Chaplin, ormai ottantenne, è ridotto su una sedia a rotelle: sogna una donna uccello, bellissima, nata da una coppia di missionari in Patagonia, cresciuta tra gli indios Fuegini, già tra di loro oggetto di venerazione e pellegrinaggi, fuggita e caduta sul tetto della casa di uno scrittore e accademico inglese, dove è accolta; ma, rapita e portata a Londra, viene messa in piazza come un fenomeno, per alcuni un angelo, per altri un mostro, un freak. Fuggirà di nuovo, tentando di attraversare l’oceano con la sola forza delle sue ali.
Un personaggio dolce, stralunato e inafferrabile quanto Charlot, pensa Chaplin nell’affidare il ruolo alla settima figlia, la sua erede, che fa le prove di volo sul prato davanti casa.
Il museo avrebbe le sue regole, meglio imparare la prima: ogni film non realizzato, in qualche modo lascia una traccia, finisce per prendere forma da qualche altra parte, in un altro momento.
È così per l’opera seminale mai portata a termine di Federico Fellini: il viaggio di G. Mastorna, le cui visioni il maestro adoperò per altri film e che poi diventerà un graphic novel di Milo Manara, come il suo secondo film mancato, Viaggio a Thulum, in cui si racconta l’incontro tra Fellini e l’antropologo messicano, iniziato ai segreti degli sciamani, Carlos Castaneda.
È così per Porno-Teo-Kolossal, il film strappato ai cinema dall’assassinio del suo regista, Pier Paolo Pasolini. Il progetto più difficile da immaginare sullo schermo, il più fantastico e perturbante: Eduardo De Filippo e Ninetto Davoli, al seguito di una nuova stella cometa, portando in dono un presepe napoletano, girovagano in un mondo sconquassato, in cerca di un nuovo redentore, attraversando sterminate metropoli-metafora (la città dove sono proibiti i rapporti omosessuali, quella in cui sono proibiti – tranne durante un rituale giorno di festa per la riproduzione – i rapporti eterosessuali, la città degli intellettuali liberali, assediata da un esercito di fascisti).
L’amico di sempre del regista e poeta, Sergio Citti, rifacendosi a quel soggetto, ha portato nelle sale un lungometraggio molto bello e pasoliniano: I magi randagi. Anche Abel Ferrara, nel suo film Pasolini, ha inserito, ricreandole, alcune scene di Porno-Teo-Kolossal.
Quindi ci si può domandare quando, dove e come torni Sarapha, il freak (o la freak) di Chaplin.
L’angelo di Il cielo sopra Berlino, di Wim Wenders, salvo per un istante all’inizio, non ha ali, che sono il grande rimosso del film. Le ha invece, in alcune celebri sequenze, la protagonista, l’acrobata, che lavora in un circo, a tratti chapliniano.
Chissà se Victoria Chaplin, che ha passato il resto della vita accanto a un clown, creando con lui un fantastico circo per due soli artisti, ha visto quel film e ha notato quelle ali. Chissà cosa ne ha pensato. E chissà se Wenders sapeva qualcosa dell’ultimo lavoro incompiuto di Chaplin. Ci sarebbe da scommettere di sì.
La sala centrale del museo dovrebbe essere dedicata, senza alcun dubbio, al Don Chisciotte di Orson Welles.
Quando sarò pronto a distribuirlo – scherzava Welles – lo intitolerò “Quando finisci il Don Chisciotte?”
Al centro esatto del museo dovrebbe scorrere su uno schermo la sequenza in cui Don Chisciotte, seduto in un cinema, prima segue lo spettacolo, poi, mentre una ragazzina fa provare un lecca-lecca a Sancho Panza, si alza e, sguainata la spada, attacca le ombre proiettate sul telo.
Del resto Orson Welles è il re dei film incompiuti.
E così torniamo all’altro volume pubblicato di recente, da Sellerio: Miracolo a Hollywood. Il titolo originale della commedia, rappresentata da Orson Welles a Londra per quattro settimane nel 1950, era The unthinking lobster (l’aragosta avventata). Il titolo Miracolo a Hollywood (molto più azzeccato) le viene dato nel 1952, in occasione della traduzione in francese, per assonanza con Miracolo a Milano, di De Sica e Zavattini, uscito l’anno prima. Il testo francese è l’unico che ci sia arrivato.
Se, come dice la postfazione, il regista aveva pensato di farne un film «realizzato senza grandi mezzi», deve essere stata appena una fantasia. Il progetto non è mai partito, a differenza di molti altri suoi. Eppure, anche qualcosa di questa commedia doveva tornare.
È una satira di Hollywood e della mania per i film a sfondo religioso: una grande produzione sulla vita di una santa viene messa sottosopra da un regista italiano, che prima pretende di portare in scena un esercito di veri disabili, per ottenere una situazione più realistica, poi licenzia la diva che interpreta la santa e la sostituisce con la segretaria di produzione, dall’aspetto più spirituale. Ma il climax arriva quando la santa comincia a fare veri miracoli, i disabili si rialzano e guariscono per davvero, Hollywood diventa meta di pellegrinaggi, si vendono spezzoni di pellicola come reliquie.
Sempre secondo la postfazione, nel regista italiano, che si chiama Sporcacione, si mescolano la passione di Orson Welles per De Sica e Zavattini, che ammirava, con l’insofferenza per Rossellini, che detestava. Ma da questa crasi nasce un altro regista, che assomiglia molto a Pier Paolo Pasolini (naturalmente il soprannome Sporcacione va inteso per assonanza con il suo immaginario e non come insulto).
Pasolini che nel 1950, da un punto di vista cinematografico, non esisteva ancora. Il suo primo film, Accattone, è del 61.
Qualche anno dopo, in un celebre cortometraggio, La ricotta, centrato, come altri, sull’ossessione per il sacro, il regista friulano farà recitare proprio Orson Welles.
Che quindi si è trovato, in qualche modo, a diventare il personaggio di un suo personaggio.
Nel breve film interpreta il ruolo di un regista (la mise en abyme prodotta dal gioco di spechi sprofonda quasi all’infinito), dichiaratamente marxista, che sta allestendo in quel momento la crocifissione di Cristo, con attori presi dalla strada (tra cui Stracci, che ci lascerà la pelle per un’indigestione di ricotta, divorata prima di salire sulla croce).
E qui, di fronte al caustico, istrionico e malmostoso regista marxista interpretato da Welles, è bene fermarsi. Qui dove si incrociano i due fantasmi che più hanno percorso il 900: il cinema e il marxismo (uno, per la verità, si era messo in marcia a metà Ottocento ma, in sostanza, si possono ritenere quasi coetanei), con tutto il carico di sogni mai realizzati che ciascuno si portava dietro.
Resta ancora un soggetto di Zavattini: l’ultimo, pensato per la televisione, alla fine degli anni Ottanta.
Il protagonista è lui, Zavattini in persona, un vecchio di 83 anni, che si aggira per una Roma degradata, come un barbone. In un cassonetto trova una bomba. Dopo un’incertezza, la prende. Cosa ne farà? La userà per vendicarsi di qualcosa, per riscattare qualcuno? Per difendere le ragioni dei deboli o le sue?
Prova a parlarne con altri emarginati come lui ma si sente sempre più solo. Alla fine, capisce: con una bomba o senza, il mondo da cui è circondato è comunque più feroce di lui.
Un soggetto che si potrebbe realizzare domani, ad avere il coraggio di essere Zavattini.
Photo credits
La ricotta di Pier Paolo Pasolini
