«We’re gonna need a bigger boat».
«Ci serve una barca più grande» è l’iconica battuta pronunciata da Roy Schneider in Lo squalo, quando per la prima volta il suo personaggio, il capo della polizia dell’isola di Amity Martin Brody, riesce a vedere il mastodontico protagonista del film e insieme a lui il pubblico, a cui fino a quel momento Spielberg ne aveva mostrato solo frammenti o il punto di vista in soggettiva. A questo momento cinematico cult fa riferimento il titolo dell’ultima opera critica di Emanuele Rauco, Bigger Boat. Il senso della meraviglia dei film di Steven Spielberg. Terza monografia che Emanuele, firma cara a Limina, pubblica con Bakemono, dopo quelle dedicate a Guillermo Del Toro e Jim Jarmush, questo libro è il suo lavoro critico finora più ambizioso, dedicato al suo regista del cuore e infatti come a Brody sarebbe servita una barca più grande a Emanuele è servito un libro più grande per contenere il suo discorso su Steven Spielberg, e a Bigger Boat si accompagna il secondo volume: Blinded By The Light. Filo conduttore, è proprio il senso della meraviglia, la cifra stilistica spielberghiana per eccellenza secondo Emanuele, che conferma in questa nuova, appassionata monografia, le sue doti di divulgatore, accompagnando chi legge di film in film con la piacevolezza, la leggibilità e il calore che contraddistinguono il suo fare critica, che avvicina e accompagna anche quando affronta gli aspetti più tecnici.
Per dare un assaggio di tutto questo abbiamo pensato di proporre un estratto in cui Emanuele racconta uno dei più iconici e ludici prodotti spielberghiani: Jurassic Park.
Il miliardario John Hammond (Richard Attenborough) ha realizzato un parco di divertimenti abitato da veri dinosauri, creati grazie alla clonazione. Per testare la validità del parco, chiama alcuni esperti tra cui i paleontologi Grant (Sam Neill) e Sattler (Laura Dern) e il matematico Malcolm (Jeff Goldblum), ma non si possono rinchiudere in un recinto gli istinti millenari dei dinosauri.
Se la saga di Indiana Jones era un inno alle macchine celibi, ai meccanismi complicati il cui funzionamento è molto più importante del loro scopo, la serie di Jurassic Park mostra invece quelle macchine nell’esercizio delle loro funzioni, non più celibi, ma atte a un preciso proposito, come a dire, lì ci sono le attrazioni, qui c’è il parco in quanto tale, svelando il meccanismo alla base del cinema più redditizio di Spielberg. Questa trasparenza teorica diventa gesto cinematografico perché Jurassic Park è una metafora sotto forma di paradossale documentario fantastico, anzi, fantascientifico, visto che la scienza in questo film ha un peso fondamentale, arrivando a riflettere sulle conseguenze di una scoperta.
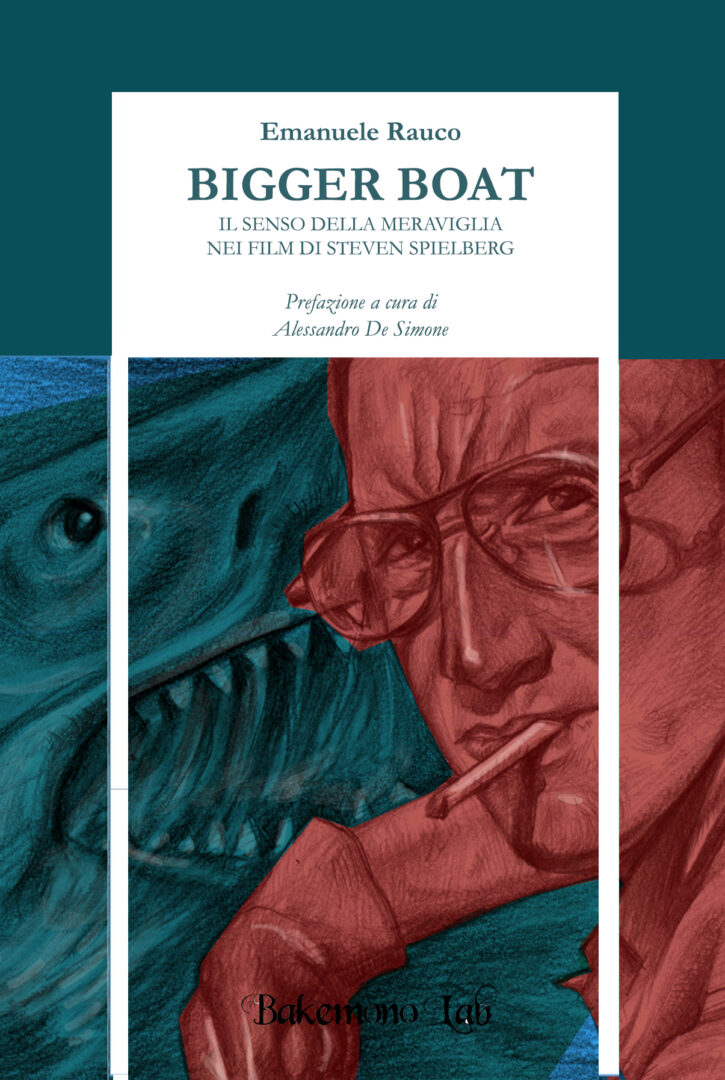
L’apertura è parecchio spielberghiana e pone il film sotto il segno del brivido, rimandando a Lo squalo : un gruppo di tecnici sta trasportando una grossa gabbia dentro il parco, tutti vorrebbero vedere il contenuto rumoroso e minaccioso della gabbia, ma Spielberg si diverte a farcelo immaginare agitando le piante, facendoci sentire il ringhio, guardando la gabbia tremare sotto i suoi colpi. Finché, da dentro la gabbia, il dinosauro mangia uno dei tecnici, senza che lo spettatore riesca a vederlo.
Il gioco a rimpiattino con la curiosità dello spettatore/voyeur è la spina dorsale di Jurassic Park anche più che in Lo squalo, soprattutto per quanto riguarda l’apparizione maestosa del tirannosauro. Spielberg lascia di continuo intenderne la presenza, gioca con gli effetti del suo passaggio o la delusione dell’attesa a vuoto, fa un lavoro di suspense direi etimologico, fa aspettare lo spettatore e anche i personaggi, perché mai come in questo film la sovrapposizione tra i due ruoli è totale. Se Indy era un veicolo per portare lo spettatore dentro il gioco, Grant, Sattler e Malcolm sono giocatori come noi, per metà film sono praticamente nella nostra stessa condizione di spettatori, sono – come noi – guidati all’interno del parco, si spiega loro tutto ciò che devono sapere come lo spiegherebbero a noi, viaggiano in giro per l’attrazione come faremmo noi se fossimo nei loro panni e, come noi, aspettano di vedere i dinosauri, o meglio, l’attrazione regina, il T-Rex.
Per questo mi viene da dire che, in un certo senso, Jurassic Park è una specie di documentario: per circa un’ora su due mostra, tanto allo spettatore quanto ai personaggi, storia, costruzione, evoluzione, pensiero e funzionamento dell’intero parco, ci riflette attraverso i dialoghi sulla moralità o l’immoralità di un atto del genere. Al tempo stesso, svela in modo trasparente l’intero processo di produzione del film stesso, dalla sua creazione alla messinscena fino a meditare sui meccanismi economici e fruitivi, sul suo target (così Hammond chiama i nipotini quando entrano in scena), sul marketing (le inquadrature dei magazzini pieni di merchandising griffato con lo stesso logo del film) e le sue strategie, che sono le stesse sia del film che del parco. È interessante che in questa costante pratica di sovrapposizione, Spielberg scelga di specchiarsi in Hammond, ovvero nell’imprenditore, nel capitalista, illuminato quanto si vuole ma sempre votato al profitto, capace di meravigliarsi, amante della scienza e della scoperta, ma cinico abbastanza da mandare i nipoti – i più antipatici bambini nel cinema del regista – a rischiare la vita per mostrare a tutti il suo potere. Spielberg qui sembra quasi voler dare ragione ai suoi detrattori. Tra l’altro la figura del suo interprete, Attenborough, è significativa sia perché l’attore è anche regista di grandi film spettacolari, come quel Gandhi che nel 1982 tolse l’Oscar a E.T., sia perché legato al documentario naturalistico assieme al fratello David.[1]
Dall’arrivo degli scienziati fino all’inizio della “giostra”, Jurassic Park sembra un film fanta–naturalistico, per racconto e scelte di regia: il pubblico deve vedere, il pubblico deve capire.
Il romanzo è stato ampiamente sfrondato e semplificato (Crichton scrisse la prima stesura poi rivista da David Koepp), nondimeno mantiene intatta la fascinazione per le potenzialità della scienza, per il lavoro dei ricercatori, per la scoperta, la tecnica e le questioni moralistico/apocalittiche del romanzo, solo che a tutto questo aggiunge una poderosa iniezione di spaventi e brividi, come se avesse portato Lo squalo alla dimensione di kolossal, senza il relativo lavoro sulla forma cinematografica : Jurassic Park è diviso nettamente in due parti, che però non cercano un punto di contatto o elementi filmici che le amalgamino, anzi l’obiettivo è proprio questa divisione, da una parte la meraviglia delle possibilità – si vedono i dinosauri “buoni”, si temono e attendono quelli “cattivi” –, dall’altra il terrore della loro realizzazione, lo spettatore deve vivere quella divisione come una distruzione delle illusioni.
Proprio a livello di immagini emerge la natura trasparente, “semi-documentaria” del film : il senso di meraviglia di Jurassic Park è insito nella sua sostanza, nell’immagine di per sé più che nel modo di comporla e realizzarla (Dean Cundey è il direttore della fotografia), il senso di meraviglia è il tema e il problema dell’intero film che, come i suoi personaggi, si stupisce di continuo di ciò che è davanti ai suoi occhi. Spielberg sembrerebbe farsi da parte e lasciare ai dinosauri creati da Stan Winston, Phil Tippett, Dennis Muren e Michael Lantieri (supervisori degli effetti speciali, ovviamente premiati con l’Oscar) il compito di soggiogare lo spettatore, attraendolo e terrorizzandolo, egli stesso è spettatore di questa meraviglia in divenire, lo si capisce alla prima apparizione dei dinosauri. I protagonisti sono in jeep, in una prateria dell’isola diretti verso il parco, quando all’improvviso Grant si alza e si sporge dal tettuccio, guarda con enorme stupore nella più classica delle facce da Spielberg e la macchina da presa, ovviamente, si avvicina a quel volto. Il controcampo però non arriva, non subito almeno, Spielberg ha voglia di raccogliere le reazioni dei suoi personaggi prima di quelle del pubblico e mette insieme le reazioni di Sattler e Malcolm, vuole fare il pieno di meraviglia, chiede anche alla musica di John Williams di aiutare a far spalancare la mascella allo spettatore; solo dopo varie inquadrature vediamo la scena “arcadica” di una valle di dinosauri che mangiano e vivono in libertà, scena opposta alle sequenze con il tirannosauro e i velociraptor che vedremo poi. È come se Spielberg stesse anticipando il più possibile la risposta del pubblico, stesse in qualche modo dicendo loro come reagire, perché non è lui il responsabile in prima persona del senso di meraviglia della scena o del film e non può fidarsi solo dei suoi attrezzi da regista.
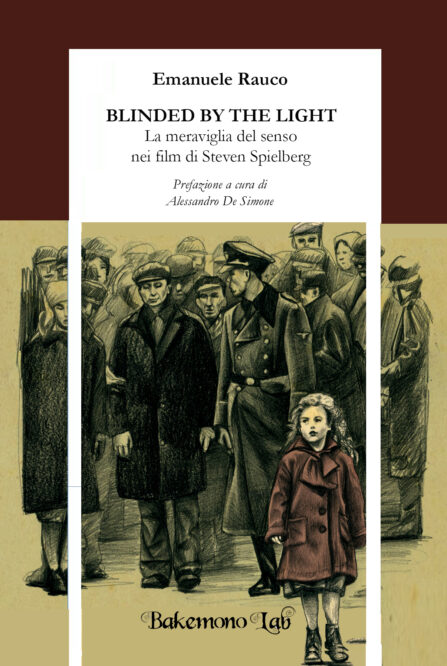
Questa è, per definizione, una scena manipolatoria che esemplifica bene il didascalismo, comunque necessario al processo narrativo, di tutta la prima parte, il cui fascino sta proprio nel raccontare al pubblico come l’incredibile presupposto del film sia stato realizzato, il suo significato, le sue possibili conseguenze. Fin quando Jurassic Park è un film su un luna park è tutt’altro che ludico, è un’opera divulgativa e saggistica in cui il gioco ha perso innocenza ed è diventato una questione di avvocati e industriali, di profitti e strategie («We’re back in business» dice Sattler quando riesce a riavviare il generatore elettrico del parco), uno specchio della Hollywood che tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta stava diventando industrialmente una cosa molto diversa dalla Mecca del cinema classico. Il film diventa l’enorme giocattolone bramato da spettatore e personaggi solo quando il luna park come luogo diegetico smette di funzionare, quando i dinosauri escono dai loro recinti, i personaggi non sono più spettatori e noi possiamo tornare al nostro privilegiato status di pubblico di un film.
Ecco quindi che Spielberg torna a essere Spielberg, a divertirsi con le catastrofi da cartoon, a rielaborare il grande cinema di mostri, a lavorare in modo sempre più gigantesco sui set come giostra, a far fare ai personaggi cose stupide come in ogni horror che si rispetti e al tempo stesso a dimenticarsi la coerenza narrativa in nome dell’effetto, come già in Indiana Jones. Cosa ha causato il malore del triceratopo che così tanto sembra preoccupare gli scienziati non si saprà mai, così come le leggerezze di scrittura si accumulano perché il loro scopo è quello di far progredire l’emozione, non il racconto. Sono MacGuffin belli e buoni, secondo la definizione di Hitchcock delle trovate di racconto che non hanno una vera funzione se non quella di convogliare l’attenzione dei personaggi e dello spettatore, creando quindi tensione.
E di Sir Alfred, il film, come spesso accade in Spielberg, è imbevuto proprio in quella seconda parte in cui l’azione e il brivido prendono il sopravvento. La suspense visiva degli attacchi dei mostri, le corse contro il tempo, le fughe e le rincorse paiono rispondere alla domanda “Come avrebbe girato Hitchcock un film di mostri?”. Il montaggio alternato – opera come sempre di Michael Kahn – tra la scalata del recinto senza elettricità e il tentativo di riavviare il generatore, oppure la caccia dei velociraptor ai bimbi in cucina sono tra le sequenze più memorabili dello Spielberg ludico, così come l’uso della metonimia per annunciare l’arrivo dei dinosauri – le ondine nel bicchiere d’acqua, il budino che trema – è diventato proverbiale.
Che qualcosa sia cambiato, per sempre e apparentemente in peggio, nel mondo di Spielberg è però evidente dal tono del film, che si inscrive così nel decennio di transizione del suo cinema, in quel passaggio dalla giovinezza alla maturità cominciato dopo Hook: il film è disilluso, popolato di personaggi cinici che hanno smesso di credere alla magia perché ormai quella magia è realizzabile, quantificabile, vendibile. Lo sguardo finale di Hammond, perso tra rimpianto e consapevolezza del mondo che ha perduto, sembra quello di Spielberg verso la presunta innocenza sparita dal cinema USA. Non a caso, quando farà ritorno nel mondo narrativo di Crichton, Spielberg lo farà proprio raccontando di un mondo perduto.
[1] Ancora più significativo è che Spielberg chiese all’attore/regista di sovrintendere temporaneamente a Schindler’s List, mentre era impegnato negli ultimi ritocchi della postproduzione di Jurassic Park (dalla biografia di John Baxter del 1996).
Photo credits
Copertina – Yohann LIBOT tramite Unsplash
Illustrazione della copertina di A bigger boat – Livio Squeo
