Valentina Maini è nata a Bologna nel 1987. Nel 2016 ha pubblicato la raccolta di poesie Casa rotta (Arcipelago itaca), vincitore del Premio Letterario Anna Osti, e nel 2020 ha fatto il suo esordio nella narrativa con La mischia (Bollati Boringhieri), attualmente candidato finalista per il Premio Opera Prima e per il Premio Severino Cesari.
La mischia racconta la storia di Gorane e Jokin, due gemelli baschi che s’inseguono tra Bilbao e Parigi alla ricerca di una lettura del mondo. È difficile restituire la trama, ma anche soltanto raccontare un libro così splendidamente indisciplinato, che stropiccia e tira per il bavero l’etichetta di romanzo, aprendo il respiro a sperimentazioni e cambi di registro vertiginosi. Il tutto nel segno di una paradossale e pure limpida concretezza narrativa.
Della Mischia, questo romanzo enorme, polifonico, questo labirinto di specchi e di voci, mi interessava raccontare qualcosa della genesi. Così ho pensato di fare due chiacchiere con Valentina: abbiamo parlato moltissimo del suo libro ma anche dei suoi padri letterari e di scrittura.
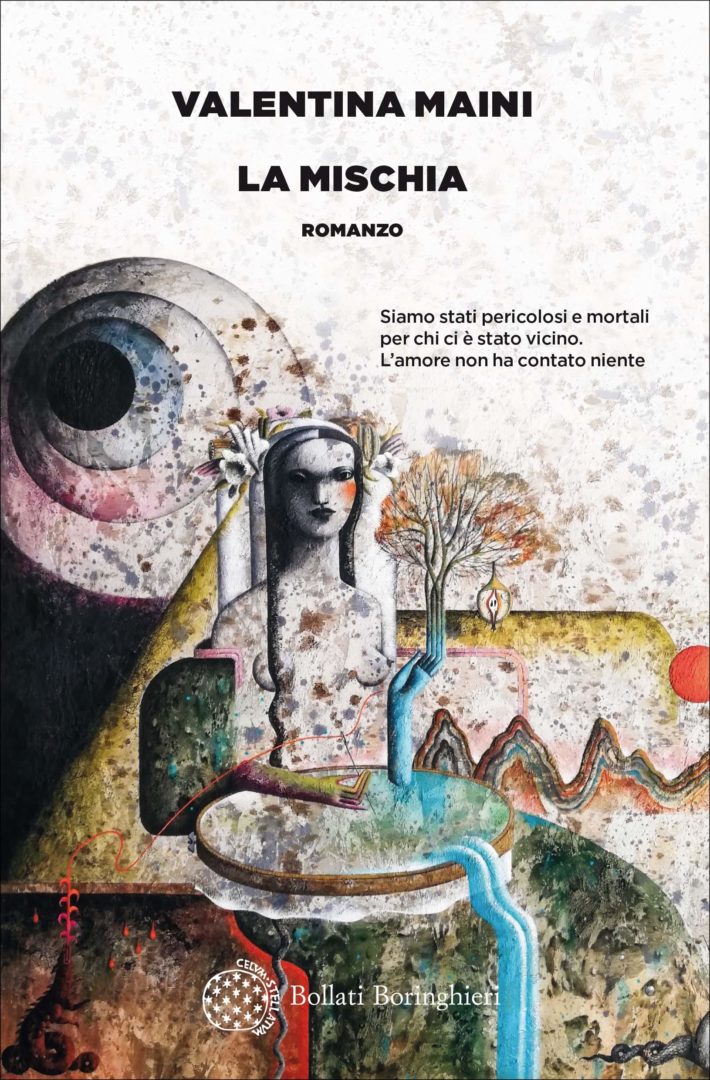
La mischia è la storia di due gemelli, Gorane e Jokin, che si inseguono tra Bilbao e Parigi. Uso il verbo inseguire perché ti ho sentita usarlo già in qualche altra intervista: parlavi di come hai di fatto inseguito questi due personaggi, un’idea di base più piccola, approdando solo dopo al risultato finale. Mi racconti com’è nato questo romanzo?
Prima della Mischia c’è stato un romanzo distopico, un testo che non ho nemmeno provato a pubblicare. Aveva qualcosa di simile: una struttura che alternava il racconto di un uomo e di una donna diametralmente opposti, simile alla seconda parte della Mischia, e disseminato di echi, frasi che tornavano tra le pagine, microspecchi. Molto rigido, anche un po’ astratto come libro. Un giorno, ho buttato giù a fiume tre o quattro pagine di Jokin, che sono effettivamente le prime tre pagine che ci sono adesso, ma non sono stata a forzare le cose… L’ho lasciato lì, pensando: «chissà se un giorno lo scriverò». Dopo un po’ di tempo, ho pubblicato su Verde Rivista un racconto su questa ragazza basca, che parlava di sé stessa in terza persona, il suo dettato ricordava la grande bocca di Not I di Beckett. Un po’ quella bocca ritorna nella Mischia, l’inaffidabilità del racconto, lo sdoppiamento. Sono partita da un dolore personale, una questione privata, e a furia di scavare lì dentro ho incontrato la famiglia Moraza. Incontrarli mi ha permesso di ingrandire questo dolore, di distanziarmene e di trasformarlo, o incontrarlo, nel dolore di qualcun altro. Anche di attaccarlo da più lati, accerchiarlo: un assedio. Ho buttato giù una scaletta estremamente approssimativa in mezz’ora, non so esattamente come, forse riproducendo in parte la specularità dell’altro romanzetto. La scaletta era sostanzialmente l’equivalente grafico di una struttura, e non un elenco di eventi e colpi di scena. Da lì ho iniziato a scrivere, di notte, di nascosto mentre ero al lavoro, trascurando la tesi di dottorato e sostanzialmente mandando all’aria tutto il resto della mia vita, e per un anno e mezzo non ho più smesso. È nato così, da quella prova generale che avevo fatto con il romanzo distopico. È una questione di echi strutturali, non di storia. Poi, con la mia passione per i Paesi Baschi, i miei studi, la mia vita a Parigi… la polarità del libro è quella che avevo mentre scrivevo.
A me è parso molto interessante il rapporto che viene a crearsi tra i membri della famiglia Moraza. Gorane e Jokin vivono un rapporto simbiotico e complementare, è come se un filo li tenesse sempre legati. Ma c’è anche un filo di ferro che lega entrambi ai genitori e al modo in cui li hanno educati. Ne danno un’idea gli stessi genitori, quando dicono: «Non abbiamo dato altro che terre franate e sottrazioni ai nostri figli e terre franate e sottrazioni hanno continuato a cercare per tutta la loro vita lontano da noi». Insomma questo filo Gorane e Jokin lo tirano, cercano di spezzarlo. E sono costretti a farci i conti. Puoi parlarmi di questo?
Gorane sembra inizialmente immobile, è la resistente, quella che si chiude in casa, vede i genitori, rifiuta il mondo esterno. Jokin invece vive fuori, è più estroverso, per quanto silenzioso e oscuro. Nonostante la sua apparente immobilità, è lei che a fatica, con tutti i ritorni del caso, tende maggiormente il filo di cui parli. Il filo non si spezza, ma si indebolisce parecchio. Jokin invece mi fa l’effetto di chi si muove tanto fuori perché dentro è rimasto completamente ancorato. Con quel filo ci gioca, ma senza l’intenzione e il coraggio di spezzarlo. Anzi lo riannoda. È il movimento nevrotico di chi dentro è immobile. C’è un punto del libro in cui si parla dei genitori come di una fonte a cui Jokin si è abbeverato troppo tanto da morirne annegato, mentre Gorane ha rifiutato di bere ed è morta di sete. Sono due parti mie, talmente complementari da essere quasi macchiette, penso a volte. Solo insieme possono trovare un equilibrio. La stessa cosa accade ai genitori, questo è un romanzo di coppie simbiotiche. Il riferimento è all’entanglement, presente anche nel romanzo di Luque, un fenomeno della fisica quantistica per cui due particelle, entrate in contatto anche una sola volta, continueranno a influenzarsi tra loro, anche a distanze incalcolabili. Se agirai su di una, agirai anche sull’altra. Mi sembra un’immagine perfetta del loro rapporto familiare: tre loro c’è un movimento quasi telepatico.
Gorane a un certo punto ragiona sul tema della mischia in questo modo: «Io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta, nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l’infanzia dall’adolescenza dall’età adulta e dalla vecchiaia. […] A me hanno insegnato solo qual era il bene e qual era il male, ma non mi hanno spiegato perché, mi hanno consegnato la loro verità come la fiamma olimpionica a una staffetta». Sembra quasi voler lottare contro la mischia, voler ordinare un mondo condannato al caos. Quanto è importante questo scontro, questo attrito tra il manicheismo ideologico dei genitori e la frammentaria e plurale forma del mondo nell’economia del libro? Come reagiscono, e reagiscono in modo molto diverso, Gorane e Jokin a questa dinamica?
La reazione di Gorane è più rivoluzionaria, anche se sembra la figlia più rigida. La sua rigidità è la sua rivoluzione: quando vieni cresciuto in un modo così anarchico, costruirti delle regole è un discostarti dal dettato familiare. Jokin invece si fa annegare: si fa prendere dalla mischia, non cerca di costruire la sua identità. L’unica chance che avrebbe, la musica, è continuamente disattesa. Appena cerca di chiudersi in un’identità, risponde con l’eroina, distrugge ogni cosa. Piazza bombe nel suo percorso di crescita, con l’illusione che questa mancata definizione di sé lo liberi. Il sintomo igienista di Gorane ha a che fare con la pelle, il separarsi dagli altri. Cerca di ripulire i suoi confini, anche lei prova a chiudersi in un’identità, in un corpo. Il tema della pelle e del limite è un concetto chiave per lei, anzi forse lo è per tutti loro. La pelle di Jokin è bucata in ogni senso: ci passa tutto, fa uscire tutto, non si capisce dove finisce lui e dove iniziano gli altri. Non lo so, sai? È vero che l’imposizione manichea e ideologica dei genitori è dannosa per loro, però è una regola chiara. E quando l’imposizione la vedi, un po’ come con la violenza fisica, forse puoi difenderti, per lo meno capire che ti fa male. Gorane non soffre per l’ideologia, anche se a volte si diverte a farcelo credere. È la questione emotiva, invece, che la fa soffrire. Dove non viene dato loro un perimetro, dove tutto è confuso, sono persi: nelle relazioni d’amore, nella vita pratica. Jokin si incancrenisce su quel modo di vivere. Non ha la forza di carattere di mettersi lì, come un operaio, a costruire un perimetro di movimento. Preferisce che siano gli altri a dirgli chi è.
Vorrei chiederti qualcosa sull’ironia. Io mi sono ritrovato a ridere, in certi passaggi, e mi pare che ci sia stato spazio, insomma, per aprire il registro anche all’ironia: penso alla storia tra Sef – il ragazzo che condivide una stanza a Parigi con Jokin – e la sua ragazza, piena di ipocrisie e coronata dall’interrogatorio di lei, ma anche alla figura di Dominique Luque, che a me è parso tragicamente ironico. Pensi insomma che ci sia, in alcune sezioni, una componente ironica?
La componente ironica mi è uscita… La parte degli interrogatori, che probabilmente era anche pallosa da scrivere, l’ho scritta per pareggiare la spinta dell’io di Gorane. Piano piano, proprio perché volevo divertirmi, ho aperto il registro. Anche questa è stata una sorpresa non premeditata. Una variazione che prima non mi ero mai concessa. Mi piaceva che l’oggettività di un verbale venisse piano piano smantellata, che anche lì la realtà si incrinasse… una cosa che accade dovunque nel mio testo. Una messa alla prova continua del mondo reale. Quest’alternanza è salutare a livello ritmico, sentivo la pesantezza di Gorane, della sua voce così personale, la narrazione rischiava di chiudersi troppo nel suo monologo. È anche un’ironia che demolisce alcune pratiche poliziesche, e ho inserito in particolare riferimenti a due episodi tragici di cronaca italiana che non svelo, anche se facendo caso a certi nomi propri che ho scelto per qualcuno è facile capire di cosa parlo…
Mi è sembrato molto importante il ruolo ricoperto da alcune figure e immagini ricorrenti, che ripetendosi ritmano lo sviluppo del romanzo. Vorrei che ne parlassi, e ti porto gli esempi delle due immagini a mio avviso dominanti: quella dell’uovo e quella dell’acqua che invade lo spazio abitato dall’uomo (qui ti faccio anche qualche citazione: «Jokin, sono entrata in un acquario»; «Mi sembrava che un velo di foschia rimanesse sospeso tra il cielo e il marciapiedi come una barriera corallina o una foresta quasi invisibile di alghe»). Hanno anche una funzione strutturale?
L’uovo è una spia strutturale. La scaletta “grafica” di cui ti parlavo prima somigliava a un’ellisse. Quando Gorane ha iniziato a disegnare uova, mi sono resa conto che l’immagine che avevo del romanzo era anche un movimento: di andata e ritorno. È un uovo, in effetti, questo romanzo. Lo è la casa, lo è Arrautza. Una specie di uovo cosmico, un tutto prenatale che precede la creazione, è la mischia. Poi… L’acqua mi interessa. Io sono un po’ ossessionata dall’acqua, da sempre. Può essere, non ti so dire perché, non so nemmeno se sia strutturale… Può essere, però. Un’altra cosa che mi viene in mente: Gorane si descrive come un anfibio, dice che non riesce a essere né in acqua né in terra. È un essere che appartiene a mondi diversi, li attraversa, e ho usato una metafora che ha a che fare con l’acqua… anche l’immagine dell’annegamento che ti dicevo prima… Quindi, sì… ora che me lo fai notare me ne vengono in mente un sacco!
«La bella scrittura genera questi mostri. La bella scrittura è il sonno della ragione. Uno che scrive bene si sente in diritto di non dire un cazzo. Canta. Pensa che il suo eloquio possa trascinare tutto. Dice di fare scrittura di ricerca». Qui a parlare è l’editore di Dominique Luque, una sorta di scrittore-cagnolino che viene deriso in diversi modi. Ma per rimanere sulla Mischia: anche tu fai ricerca, la forma del tuo romanzo è sperimentale, la lingua è personale e ricca di riferimenti. Però nella Mischia c’è una storia che fa da impalcatura alle evoluzioni della lingua, e credo che questa componente per te sia stata importante, e forse una novità. Qui c’è una differenza. Com’è che si articola il rapporto, te lo dico coi termini che userebbe un ragazzo della scuola media, tra importanza della trama e dello stile?
Io mi sono anche autoattaccata: volevo ridicolizzare anzitutto me. Sembra una cosa diretta all’esterno, ma gran parte delle cose che metto in bocca all’editore me le hanno dette, me le sono dette da sola. Non mi offendo se qualcuno me le tira addosso, non sono neanche d’accordo con tutto ciò che dice lui. Di base c’è un intento autoironico. Non penso che tutti i libri debbano avere una trama per forza, ma in questo caso accogliere una trama mi ha aiutato. Io prima cantavo, proprio… a volte ci si maschera, dietro la bella scrittura, non ci si mette alla prova davvero, non si sperimenta la fatica. Io volevo fare fatica, per me il senso della scrittura è nella sperimentazione, ma sperimentare non vuol dire solo scrivere “strambo”, fare ricerca a livello linguistico, ma sentirsi davvero scomodi. Andare un po’ contro natura forse. Poi io avevo anche la reazione dell’adolescente ideologico, fare il contrario di ciò che vende. Di base, credo di aver visto il libro per come era. Mi sono resa conto che non potevo decidere io. Mi sono fatta da parte e me ne sono fregata. Di chi avrebbe letto, dei poeti. Mi sono sporcata le mani, ho scavato in modo diverso. L’altro giorno leggevo un libro della Duras, L’amante. A un certo punto lei scrive: «guardare significava abbassarsi», tipo. Proprio così. Non mi sono messa al di sopra. Uno può avere l’ansia di controllare tutto, ma questa volta io ho fatto il processo inverso. Ho cercato non di far vedere agli altri ciò che vedo io, la realtà filtrata dai miei occhi, ma ho cercato di vedere io di più. Arricchire il mio sguardo invece che selezionare il mondo in base alla mia visione. Un lavoro opposto: complicare il mondo, non riassumerlo, né allegorizzarlo, schematizzarlo, renderlo simile a me. Mi sono messa più sotto che potevo, o comunque ero in mezzo alle cose. Nella mischia io per prima. Non dico che sarà il metodo che userò sempre, ma lo stile è venuto fuori così composito proprio perché mi sono abbassata tantissimo. Tutto questo percorso poi mi è servito a tornare a quel dolore personale iniziale, e a manipolarlo, è stato un viaggio lungo. Altrimenti il libro sarebbe stato omogeneo, ordinato, pulito, affilato.
Nel risvolto di copertina del tuo libro, in chiusura, si chiamano in causa due nomi molto importanti: Roberto Bolaño e Mathias Enard. Cosa pensi di questo accostamento? In particolare, tra gli articoli usciti su blog e riviste ritorna spesso il paragone con 2666. Mentre scrivevi ti è capitato di pensare che La mischia possa avere dei “padri”, insomma che ci siano degli scrittori a cui hai pensato molto mentre scrivevi? Faccio fatica dirti a cosa penso mentre scrivo, è talmente strano e intenso… anche se ogni tanto pensavo: «c’è troppo Bolaño, c’è troppo Bolaño…». Quando ho letto Amuleto, che per me è stato il primo, mi sono sentita liberata. Anche lui è uno che si mette sotto le cose. Non gliene frega niente quando usa certe metafore, che siano banali. Usa quelle giuste. Non va verso il ricercato a tutti i costi. E poi c’è una tenerezza nei suoi personaggi che rischia quasi di essere ridicola, risibile, e lui la sceglie. È raro nel contemporaneo trovare autori così. In molti lo vedono come un autore irraggiungibile, invece a me ha dato il permesso di fare certe cose. Ho sentito proprio un’affinità immediata. Ci sono gli scrittori che, forse perché li senti vicini, sembrano dirti che puoi percorrere certe strade. Temendo poi… Di Un romanzetto lumpen ho citato anche un paio di cose pari pari, ma non te le svelo. E poi questa casella vuota, il paragone tra Jokin e Benno Von Arcimboldi… Spesso dico che sono più affezionata al Bolaño minore un po’ per provocazione, perché si parla sempre delle grandi epopee, trascurando altri suoi capolavori brevi.Lo difendo tutto, con le unghie e con i denti. Quando ho finito di scrivere ho pensato in maniera più razionale alla questione dei modelli letterari e ci ho ritrovato la Kristόf, soprattutto nella parte di Arrautza. I giochi crudeli che i genitori impongono ai figli mi hanno ricordato i giochi dei gemelli, anche perché quella è la parte che più mi ha devastato della Trilogia. Potrebbe essere, insomma. Poi ho ritrovato Beckett, un autore con cui mi sono scontrata molto. Molloy è molto presente nella Mischia e forse ne ha dettato la struttura. C’è questo inseguimento fallimentare, il desiderio infinito di non trovarsi e di non trovarsi apposta. Se il desiderio cessa, se hai capito come è fatto il mondo, non hai più ragione di vivere, né di scrivere, lo diceva anche la Rosselli, altro mio ipotetico riferimento. Nella Mischia il desiderio è talmente forte che arriva a plasmare le persone sulla base del loro oggetto d’amore: queste sovrapposizioni ci sono anche in Beckett e potrei averle rubate da lui. E poi secondo me ci sono il Don Chisciotte, Wajdi Mouawad, Ingeborg Bachmann e chissà quanti libri che credevo di aver dimenticato. Mi auguro di aver dimenticato tantissimi libri meravigliosi e che questo sia il mio modo di ricordarli e tenerli in vita.
