«Sacro è una parola indoeuropea che significa separato (…). Dal sacro l’uomo tende a tenersi lontano, come sempre accade di fronte a ciò che si teme, e al tempo stesso ne è attratto come lo può essere nei confronti dell’origine da cui un giorno ci si è emancipati» scrive Umberto Galimberti, nella sua introduzione di Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto.
E in effetti, tutte le cose si possono dire in fondo sacre, perché persiste in loro una strategia di fuga, un congegno di sgancio dal mondo. Si possono conoscere, manipolare perfino, crederle in funzione di, ma esiste una forma di resistenza intrinseca, che salva loro dalla schiavitù e noi dall’orrore della conoscenza completa. Persino gli uomini sono sacri, intesi in questa luce.
E se sacra è la mite esplosione, questo dispositivo di salvataggio innato, Fleur Jaeggy si dedica, con la sua scrittura, a una rabdomanzia del sacro. Lo richiama dalle pieghe, dall’inconsulto degli eventi, come un’agitazione mortale, una vertigine nella predisposizione del mondo come lo vediamo. Distante, sì, ma di una distanza che lo pone al centro di un campo gravitazionale.
Ma forse, ancor più che un fatto di divinazione, ogni opera della scrittrice – I beati anni del castigo, tanto cara a Iosif Brodskij, ma anche Le statue d’acqua, Vite congetturali, Proleterka fino all’ultimo Sono il fratello di XX – sembra essere un circospetto e assoluto sacrificio. E questo, nel senso etimologico del termine. Săcer e făcĕre, fare, rendere sacro.
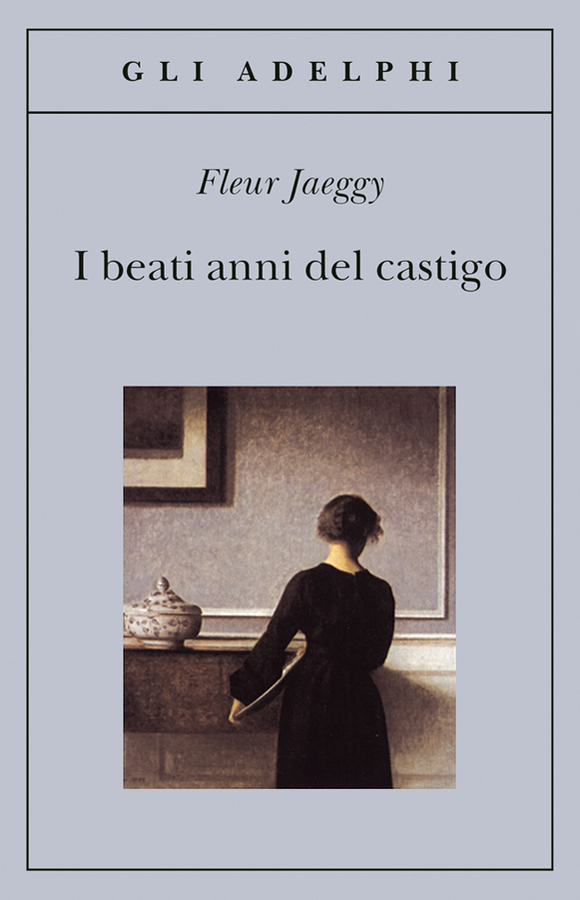
Il sacro si fa con la stessa benigna crudeltà con la quale si scrive, con la quale Fleur Jaeggy scrive. L’oggetto di questi sacrifici, tanto umile quanto inaccessibile, altro non è che la vita. Nonostante ne Le statue d’acqua rimanga impresso come un enunciato della meccanica dell’esistenza jaeggyiana che «la vera vita è fuori dalla parola».
Corrosiva, feroce eppure gentile, la parola nella scrittura di Fleur Jaeggy stipula patti di non aggressione con la vita e gli eventi, ne osserva lo svolgersi senza interferenze, dove la ricerca è quella «di rendere tutto più distante, il modo di scrivere anche le parole, devono gelare, tento di scarnificare le frasi. È un modo per tenere le cose lontane» e la scrittura una «storia di consunzione», tra «opere di resistenza e di abbandono».
Al lettore che si incammina nelle sue opere, Fleur Jaeggy indica il diritto al minimo come la forma più alta di sussistenza. La sottrazione, la dissoluzione come ragione d’essere. O meglio non essere. Dopotutto, tutto quanto e persino il corpo – con lo spazio che occupa – e l’anima – se anche qualche spazio possa contenerla – sono in prestito da qualcosa. Al quale bisogna ritornare.
Viene in mente il «Fumo di fumi/ dice Qohélet/ Fumo di fumi/ Tutto non è che fumo» nella versione del 2001 di Guido Ceronetti del quarto dei libri sapienziali dell’Antico Testamento. Ancor più adempiente, in realtà, nella sua prima versione (1970): «Un infinito vuoto/ dice Qohélet/ Un infinito niente/ Tutto è vuoto niente».
Ma comparato al vuoto di Qohélet, orrido, tormentoso, il vuoto che Fleur Jaeggy racconta è un vuoto ospitale. Orrore e grazia sono agli estremi, ma il suo vuoto è circolare e gli estremi sono nello stesso luogo, conviventi. «Il vuoto è silenzio. È solitudine. È assenza di relazioni» e contemporaneamente «è una pianta che va costantemente annaffiata. Il desiderio di non esistere è un esercizio che si rinnova di volta in volta. Anche la creazione è una forma di distruzione. Anche chi non esiste muore a poco a poco», racconta in un’intervista.

Qualsiasi forma assuma la scrittura di Fleur Jaeggy – che siano le elettrocuzioni dei suoi racconti o la corrente perpetua dei suoi romanzi – ciò che residua del processo di spoliazione, dall’alto fuoco al quale si e ci sottopone, è l’inevitabile.
La vita priva dalle scorie del quotidiano è una vita inabitabile, certamente. Tuttavia, quanto di intollerabile, di ineluttabile rimane, appare essere in Jaeggy il destino della scrittura.
«Quando ha raggiunto il bersaglio, all’improvviso il gatto si distrae. Gli etologi chiamano questo movimento Übersprung. Avviene poco prima del corpo mortale. (…). Forse la farfalla e la foglia hanno anche loro lo stesso momento di Übersprung. Come il gatto. Si distraggono dall’agonia, si distolgono dalla loro morte. Dall’idea di morte. Così fa il gatto. Distoglie anche se stesso dall’agonia. Che ha inferto. Non sappiamo perché accada che il gatto volga il suo sguardo altrove. Lui lo sa. Chissà, forse è delectatio morosa questo Übersprung. Il malinconico disfarsi di un legame con la vittima. (…) Übersprung: parola che riguarda anche noi. È il volgersi altrove, passare ad altro, manifestare il gesto del distacco, come un addio. La divagazione dal tema, l’evasione da una parola, e insieme la caccia alle parole, il disfarsene: sono altrettanti modi mentali dello scrivere. C’è chi scrive grazie alla delectatio morosa. Thomas de Quincey, per esempio, una volta accennò alla “dark frenzy of horror”, all’oscura frenesia dell’orrore» scrive nel racconto Gatto, da Sono il fratello di XX.
E davvero è in questo presagio di massacro che si consuma la sua poesia. Quello che Immanuel Kant avrebbe chiamato sublime, considerandolo di gran lunga superiore, nel suo effetto sull’umano, al bello.
Sublime ossia «il senso di sgomento che l’uomo prova di fronte alla grandezza della natura sia nell’aspetto pacifico, sia ancor più, nel momento della sua terribile rappresentazione, quando ognuno di noi sente la sua piccolezza, la sua estrema fragilità, la sua finitezza, ma, al tempo stesso, proprio perché cosciente di questo, intuisce l’infinito e si rende conto che l’anima possiede una facoltà superiore alla misura dei sensi.» (I. Kant)
E al sublime non si può domandare di essere clemente. La tenerezza diventa spietata, l’innocenza guasta. Tutto si costruisce sull’orrore che affascina, quello che Fleur Jaeggy e l’amica amata, Ingeborg Bachmann, si dicono ne La stanza asettica («La vecchiaia, disse, è orribile. Ma tutto è orribile, le dicevo. Con una specie di allegria») e che riecheggia in Proleterka dove Johannes e la figlia percepiscono «i millimetri che separano l’equilibrio dalla disperazione» e dove ogni cosa si è mossa a causa di una «quieta rovina».

Tutto vive sulle spoglie del suo contrario, dove l’opaco è una trasparenza in disfacimento, «spesso, quando gli va, il male è la migliore forma che il bene più alto possa assumere» e la bellezza è atroce nel suo compiersi. Fino alla fine, gioventù e vecchiaia si mostrano ugualmente micidiali e l’amore è un fantasma insostenibile.
L’universo jaeggyiano esiste ma nella traiettoria di un’eterna implosione, senza macerie e senza danni collaterali, un’esecuzione pulita. I paesaggi somigliano a ossari. L’aria è talmente pura da essere irrespirabile.
Eppure i vivi e i morti, equi-esistenti e grati di ciò, abitano con levità il mondo orchestrato da Fleur Jaeggy. La leggerezza piombata di ciò che esiste per forza di cose.
C’è una certa dolcezza, in questo. Nell’accoglienza equipartita ai vivi e ai morti, ai realmente vissuti e alle vite congetturali concesse dalla scrittura. Si accetta la solitudine, la disperazione come corporatura dell’anima, ben sapendo però che «le persone sole spesso hanno timore di rendere la loro solitudine visibile. Alcune si vergognano. Le famiglie sono così forti. Hanno la pubblicità tutta dalla loro parte. Ma una persona sola non è che un relitto. Prima lo spingono alla deriva, poi lo lasciano naufragare.» (Sono il fratello di XX, L’erede).
Ma non è solamente il diritto d’asilo che viene esercitato indipendentemente dallo stato d’esistenza. L’ubiquità del dolore, che non si ferma davanti alla permeabilità del confine vita-morte, fa sì che Fleur Jaeggy scriva e scrivendo vivifichi i morti e mortifichi i vivi.
Tutti i volti della galleria jaeggyiana hanno la cecità e la veggenza come caratteristiche costituzionali, Tiresia sia in vita che in morte. È così che i vivi sono costellati di piccole, minuscole morti, apocalissi personali. E nei morti si agitano vite molecolari, che fanno loro compiere «esattamente le stesse cose di quando erano vivi».
Anche se i morti e i vivi si contendono l’oggetto oscuro del loro desiderio, che è la nuda vita, gli uni rimpiangendola, gli altri tentando di condurla a termine.
A dispetto di Beeklam che ha «il terrore di tutto ciò che è ereditario, poiché ciò che viene a noi per eredità naturale è proprietà dei morti» (Le statue d’acqua) e la voce del racconto Sono il fratello di XX (che dà il titolo alla raccolta) la quale enuncia, con disperata quiete, che «si muore sempre a causa di qualcun altro. Non so se è giusto dire a causa. Ma si muore per gli altri. A favore degli altri, forse è più giusto» e che si sente «più adatto a scomparire», la morte nella scrittura della Jaeggy appare essere sì una transumanza, ma verso lo stesso mondo, un guizzo, dove quasi si muore per poter meglio vivere.

Nitidamente legata alla morte e alla vita è anche la famiglia. Dove le stirpi sembrano il meccanismo con la quale la morte si assicura di aver sempre ospiti.
In Fleur Jaeggy la famiglia è una persecuzione. A volte inquietantemente amorevole, altre nata per le disgrazie. Esercita il potere sui suoi appartenenti con tutto quanto è tramandabile. Persino il destino diventa un gene.
E tuttavia i personaggi di Jaeggy non sono solo inseriti nell’orizzonte del familiare, ma anche del consanguineo. I legami familiari, infatti, non sono una condizione necessaria alla consanguineità. La condivisione del sangue si verifica anche in altre circostanze. Come nella vita a discapito di. O nella morte in favore di, come ci viene ricordato.
Il dolore, la malafelicità o il malamore rendono consanguinei. E Fleur Jaeggy fa del sangue, o meglio della sua ombra, una trappola, meccanica di precisione che tutti colpisce, indistintamente. Personaggi e lettori.
Fino a farli, farci arrivare sul bordo di quello che ne I beati anni del castigo lascia dire al suo alter ego: «I miei pensieri erano sospesi a metà, avevo l’impressione di un pericolo, del pericolo di vivere ciò che non esiste» e lasciarli, lasciarci diventare parte del pericolo, dell’abisso.
Fleur Jaeggy scrive, quindi, rilevando le radiazioni, le vibrazioni atomiche che emettono le cose, i luoghi, gli uomini. Quell’allarme di esistere che la vita crea. Dove nulla si può muovere, se non muovendosi internamente.
Nel Mahābhārata, il più antico poema della storia umana, nel Śāntī Parva si trova scritto che «Il fuoco esiste solo distruggendo il combustibile che lo fa vivere, consumando l’oblazione. Tutto l’universo, cosciente o inconscio, non è che fuoco e oblazione».
E anche l’universo di Fleur Jaeggy va a fuoco. «Le anime sono infuocate. Spesso pericolose» scrive. E tuttavia, allo stesso tempo, in ricordo di Iosif Brodskij in quel Negde – che è ogni luogo e nessuno, proprio come è l’universo – si chiede: «È forse il gelo che crea il poeta?»
Ecco, dunque, il sacro in Fleur Jaeggy. La guerriglia fiera e mansueta al fuoco con le glaciazioni scritte. Per conservare, preservare il combustibile dell’universo, che siamo noi.
