L’eccezione non c’è più
«Questo libro è composto da cinque storie di estinzione», avverte all’inizio di In volo (nottetempo) Thom van Dooren, scrittore e “filosofo sul campo” dell’Università di Sidney. Ogni capitolo ha un protagonista speciale: l’albatros che si concede voli di lunghezza inusitata sul Pacifico. L’avvoltoio indiano specializzato in saprofagia. Minuscoli pinguini che si aggirano in una cittadina australiana. Gru d’allevamento che disapprendono la cura dei simili. E corvi che piangono i compagni scomparsi, in barba a Heidegger e a chi pensa che solo l’umano conosca la morte. Qui la biologia si mescola a considerazioni antropologiche, l’etologia all’etica più alta. È un libro ricchissimo e godibile, ma anche tenacemente artificiale, in un senso che occorre chiarire.
In volo definisce i rapporti di natura come entanglements, intrecci, interazioni, ma anche trappole: sono queste le relazioni a cui le specie animali arrivano (o in cui cadono) perché incontrano gli umani. Per esempio, gli avvoltoi indiani – utilissimi per millenni a “ripulire” l’ambiente dalle salme e ora a serio rischio di estinzione per avvelenamento da Diclofenac – sono un’esibizione tra le più palesi di quel groviglio tra biologico e sociale, tra materiale e etico, e ovviamente tra vivi e morti, organici e decomposti (sempre di avvoltoi si tratta), che tutto il libro esalta come dimensione del vitale tout court.
L’approccio di van Dooren è antieccezionalista. In parole assai povere: se molti viventi (così Uexküll) sono capaci di attribuire significati, se i corvi sanno esprimere il lutto e i pinguini “narrativizzano” – mettono in sequenze contestuali – come “case” i luoghi dove riprodursi, allora gli umani non sono affatto un’eccezione in natura, non sono un qualcosa di straordinario nel mondo (di solito, per tradizione, pensiamo a linguaggio e ragione come i caratteri che servono a “distinguerci”). Invece per van Dooren gli umani sono impastati di ogni cosa di cui sono impastati gli altri viventi. Si addestrano e adattano nelle stesse reti in cui sono presi gli altri. E quindi la vita e la morte dei viventi, di ogni vivente, non avvengono in una condizione di isolamento, ma per tutte le creature mortali, fatte di carne, sono questioni relazionali, di sensibilità diverse, e “intelletti multipli”. Anche di classe o casta, come mostra ancora il capitolo “indiano”, dove il declino dell’impero degli avvoltoi va a impattare sull’enorme fascia povera della popolazione, destinandola alla morte per rabbia o carestia, perché incapace di procacciarsi sul mercato beni sostitutivi di beni “estinti”.
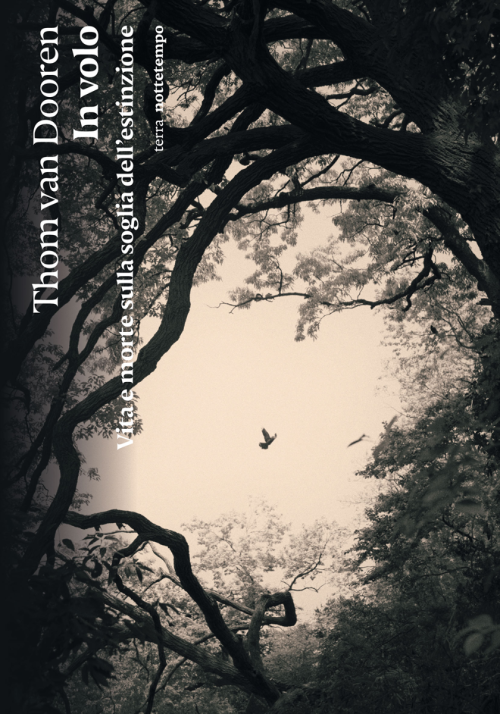
Se la «specie umana è involontaria architetta dell’attuale periodo delle estinzioni di massa», il proposito di van Dooren è quello di far viaggiare le “storie” veloci come il ciclo delle plastiche che soffocano e uccidono le specie non umane.
Per questo segue i voli degli albatros sul Pacifico, espone le loro tattiche per non fallire nel sorvolo inesauribile, le loro tecniche di riproduzione sempre più raffinate. I canti quando arriva il momento di partire. Tutto è frutto di «cooperazione e duro lavoro». E se è singolare sentire termini che antropizzano una specie volatile, è proprio questo l’intento di van Dooren: segnalare l’«ininterrotto processo intergenerazionale di divenire – di adattamento e trasformazione» che configura ogni membro come tassello di una metamorfosi, “nodo”, o connettore di un unico piano immanente.
Dove i tempi si mescolano: «Milioni di anni di evoluzione degli albatros – interconnessi dalle vite e dai compiti riproduttivi di un numero infinito di singoli uccelli – entrano così in contatto con meno di cento anni di “ingenuità” umana in forma di plastiche e composti». Prodotti che hanno una storia recente, ma un futuro di quasi immortalità – perché “naturalmente” indistruttibili – recano la morte a specie che paiono qui da sempre.
Ho visto anche corvi infelici
«Direi che ho visto uccelli in lutto», dice il biologo John Marzluff, intervistato dall’autore. Uccelli chini l’uno sull’altro, piumati che ripetono suoni strazianti, testimoniano l’esperienza della morte e sono la traccia di una cura del dolore che si esprime a lungo in società, è un periodo e un rito. Sono storie di lutto quelle che vengono raccontate da specie “altre”, divenute empatiche e sociali anche attraverso la condivisione del lutto.
La problematicità dell’approccio di van Dooren – ciò che merita discussione – sta nel richiamarsi al concetto di “buona storia” quando si parla di estinzione. L’analogia, esplicitata, è – nientemeno – con la Shoah. La questione è serissima: è quella del racconto e della testimonianza di una realtà di estinzione provocata e indotta – anche se si riferisce al vivente non-umano. La narrazione viene vista come l’approccio eticamente corretto per evitare una riduzione alla statistica, ai meri numeri, di ciò che è (stato) vivo: bisogna, con la narrazione, insistere su «una verità più viva, più carnale, che potrebbe condurci verso un maggior senso di responsabilità». Non è arduo vedere il rischio di questo approccio. Se ogni individuo è virtualmente necessario alla metamorfosi della specie, se ogni generazione collabora, il pericolo è che l’insostituibilità di ciascuno diventi insostenibile. Che si pianga il lutto per uno e di lì si arrivi ai tutti senza mediazione, semplicemente perché «queste morti, di individui e di specie, contano». E dunque tutti hanno un diritto a essere narrati.
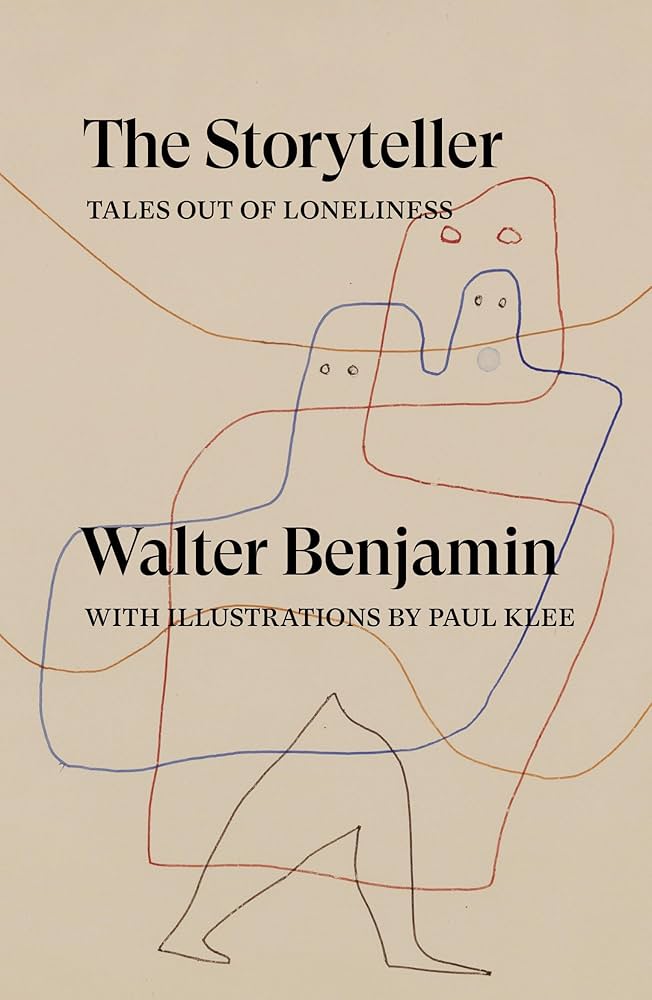
Nel celebre saggio Il narratore (1936), Walter Benjamin legava ciò che oggi chiamiamo “storytelling” alla possibilità di scambiarsi esperienze (che reputava al tramonto). Il narratore dispensa consigli, ha un interesse pratico – è preferibilmente del ceto artigianale, quindi è un pragmatico. Ma, soprattutto, il narratore ha una sua relazione intima con la morte. Il quinto capitolo di In volo è dedicato proprio a questa relazione tra morte e storie: «Il lutto ci permette di accedere a uno spazio alternativo, quello del riconoscimento e del rispetto dei morti». Ma che succede quando non solo i morti non sono umani, ma anche le storie luttuose non lo sono? Oggi – proprio sulla scorta di quanto dice van Dooren sugli intrecci tra le specie – la narrazione ha una nuova chance.
Benjamin aggiunge un ulteriore elemento: «C’è qualcosa che nel morente assume una forma tramandabile. E non è né la sapienza né la saggezza dell’uomo, ma è soprattutto la sua vita vissuta – ed è questa la materia da cui sorgono le storie». Chi sta morendo ha un’autorità, dice Benjamin, davanti a chi resta.
Se il libro di van Dooren – molto ben tradotto da Lorenzo Vetta – ha una sua legittimità nel raccontare “storie di estinzione”, è proprio perché l’autore insiste che finché un volo è in corso (una specie è ancora viva) raccontare una storia è non solo possibile, ma doveroso. Non perché l’oggetto del libro sono i volatili. Ma perché ogni esistenza di specie, nella gigantesca sineddoche dell’autore, è una “traiettoria di volo” – che può cessare (e di lì non parlare più). Dato che queste cessazioni sono sempre più frequenti, però, la possibilità di queste storie va scemando. Anzi: l’estinzione non va di moda, afferma con scorno van Dooren ancora in sede introduttiva. Anche perché siamo noi i responsabili della scomparsa di numeri impressionanti di specie. «La nostra è un’estinzione di massa antropogenica».
Lenta violenza
È una lenta violenza a uccidere rapidamente le specie: «l’uso e l’abuso prolungato di sostanze che sappiamo che si accumuleranno lentamente uccidendo altri esseri passa talmente sotto traccia che spesso non viene nemmeno identificata come forma di violenza». In questa congiura del silenzio, van Dooren va a contestarne i presupposti teorici. Su tutti, la linearità “storicistica” del discorso sull’evoluzione: «si tratta di una prospettiva che nasconde le numerose altre possibilità, relazioni e responsabilità che convivono in qualunque momento, possibilità che diventano visibili solo quando poniamo attenzione anche ad altre cornici temporali». Questo porta a formulare un’etica che chiameremmo, rubando la formula a Mynona, dell’indifferenza creatrice: «il genuino rispetto per gli sforzi dei singoli individui deve necessariamente accompagnarsi a quello per la specie in senso più ampio. Un rispetto che è alla base di un’etica che non tenta di tracciare una linea di demarcazione tra gli esseri degni di considerazione morale e quelli che invece non lo sono». Ognuno – individuo o specie – ha diritto al rispetto.
E proprio perché siamo nell’epoca delle estinzioni van Dooren raccomanda di comprendere come la “cura” e l’affettività siano pre-umani. Lo guardiamo e lo sappiamo: replicando gli esperimenti di Konrad Lorenz con le oche su miliardi di schermi, i social fanno di tutto per rilanciare video incredibili: cani che si curano di leoni, tigri che ci abbracciano, amicizie interspecie insomma, affetti cristallini tra diversi. Ma van Dooren va più a fondo. Non solo l’etica, insomma, è preumana, ma la storicità della specie umana è data e confermata proprio dall’intreccio inevitabile e interminabile con altre specie storiche. Ogni specie si “soggettivizza” proprio nel senso di Foucault, ma non si tratta appunto di pratiche neutre, anzi molte – come nel caso delle gru d’allevamento del quarto capitolo – sono pratiche di costrizione, di assoggettamento, e spesso siamo noi – i Lorenz di turno – gli assoggettatori. Quello interspecie è quindi un intreccio costitutivamente aperto, ma di cui noi umani sentiamo l’onere, dice l’autore, richiamandosi a Donna Haraway: siamo «gravati dal peso di un’esigenza etica di lavorare per “mondi più vivibili”».
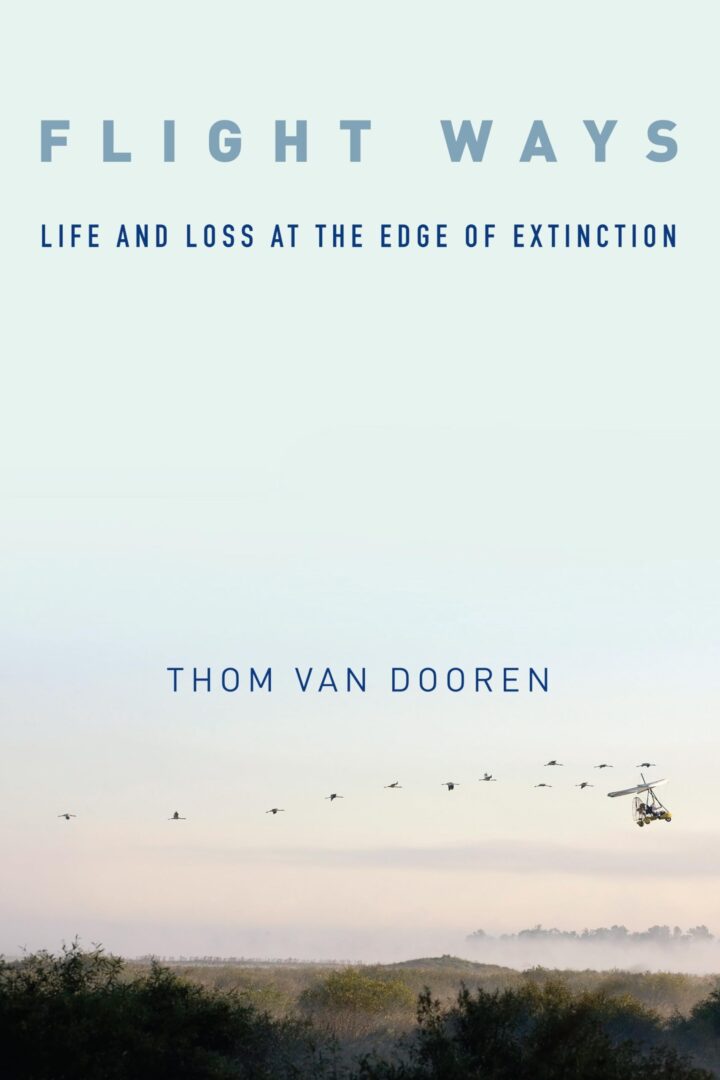
Ora, oltre al dubbio per cui proprio questo peso etico sia radicalmente solo “nostro”, e quindi specificamente umana sia non tanto l’etica (anzi), ma il concetto stesso di peso o dovere, oltre a questo si affaccia un altro tema. Ovvero, se noi che lo pensiamo, che ne facciamo un concetto e una stella polare, siamo in grado di sopravvivere al dovere. La raffinatezza epistemologica di cogliere l’interazione di individui e specie e le temporalità multipolari cui entrambi appartengono va davvero di pari passo, s’intreccia davvero coi diversi tempi dell’etica quotidiana? L’etica del dovere interspecie – banalizziamo, per sintesi – che si interfaccia con l’economia, la politica e le loro normatività interne, può restare in una dimensione gerarchicamente superiore a queste sfere? Cosa garantisce, insomma, che una storia di estinzione – o di genocidio, per usare un termine urticante da sempre, e oggi ancora di più – sia ascoltata?
Sembra che solo dal punto di vista, tanto enorme (e irenico, astorico?) da risultare inafferrabile, della “vita nel suo complesso” si colga il destino umano come intrecciato alle altre specie, e quindi vi sia una chance di ascolto. Ma non mette in guardia lo stesso autore dall’olismo ecologico per cui “tutto è collegato a tutto” (e quindi a niente, perché privo di determinazione)? Ci si chiede allora perché, in un libro in cui la critica al modello di sviluppo è onnipresente, ma quella del capitalismo è assente, in cui lo stile di vita più sostenibile è l’obiettivo, ma il modo politico per ottenerlo è lasciato all’immaginazione di chi legge, in cui si sostiene la necessità della relazione individuo-individuo con l’animale allevato, ma non si menzionano gli allevamenti massivi, si affermi ancora che «di fatto, durante le nostre brevi esistenze, mentre contribuiamo a proteggere o a distruggere l’intricata diversità delle forme di vita, siamo forse chiamati a rispondere dell’intera vita – niente di meno – presente sul pianeta».
Se non è quindi antropocentrismo, se è “cenocentrismo” (nel senso della rivendicazione interspecie delle “conquiste” del cenozoico) ciò che deve mobilitare gli strumenti di comprensione del biologico, che senso ha ricondurre, in fondo, l’etica ancora all’individuo, alle sue “brevi esistenze”, senza ripensare le infinite forme di mediazione che stanno sotto la specie, compresa quella umana, e che non sono per nulla individuali? Se – com’è argomentato benissimo – il lutto è per molte specie un processo di socializzazione, addirittura un “imparare a essere toccati”, ovvero il ribaltamento della paura del contagio e un costituirsi come massa che gestisce senza conciliazione altre masse (di morti, di fantasmi), pensare le ricadute di quest’etica ancora dal lato dell’individuo e del “dovere” è forse ciò che conduce alla paralisi. Ciò che può frenare ogni volo prima ancora di partire. Ma soprattutto rimette un tentativo così alto di pensare i viventi “in volo” alla sfera dell’artificialità, al costrutto artificialissimo dell’individuo, creatura moderna e interna al problema che il libro segnala in ogni modo, con ogni intelligenza.
Perché l’etica ecologica non sia oggi ancora politica (né accenni a farlo) è questa la domanda ancora senza risposta, che nessuna storia di estinzione sta modificando, persino in questi tempi così interessanti, in cui l’estinzione è praticata non solo dall’inaccortezza del modello di sviluppo che continuamente scegliamo, ma dai buoni, vecchi eserciti di una volta, nel plauso assordante, nella sordità dedicata agli estinti.
