Tremo, come una sveglia.
Del resto, credo si possa fare poco altro di fronte alla consapevolezza che abbiamo fallito. Come individui, come generazione, come esseri umani. Il rischio, qui, è quello di continuare a tremare, ma senza svegliarsi. Di nascondersi dietro la più semplice idea che sia un gioco, che siamo noi a deciderne le regole, che, sempre noi, saremo in grado di fermarci e di tornare alla realtà. Il rischio è esattamente quello di non farcela. Ed è pure alto.
Non mi ha stupita incontrare nell’esergo di Addio arrivederci ciao, novella di Francesco Spiedo (Zona 42, 2024) i versi di Edmond Haraucourt tratti da Rondel de l’adieu: «Et l’on part, et c’est un jeu, / Et jusqu’à l’adieu suprême / C’est son âme que l’on sème, / Que l’on sème à chaque adieu (Si parte come per gioco / prima del viaggio estremo / e in ogni addio seminiamo / un po’ della nostra anima)».
Non mi ha stupito perché la pubblicazione della novella di Spiedo avviene contemporaneamente a Tecniche di nascondimento per adulti (C. Gallo,Italo Svevo, 2024) che si apre proprio con questa avvertenza: «Nascondersi non è un gioco da bambini. Bisogna stare molto attenti a dove ci si nasconde, ma soprattutto a come ci si nasconde. Ci sono molti modi e ognuno trova il suo, oltre alle sue ragioni, che qui non hanno alcuna importanza».
Il gioco, dunque. Nello specifico: il gioco di nascondersi, se si è bambini. Il sogno di comparire, se si è adulti. E quale miglior modo se non viaggiare, andarsene, decidere di partire per non tornare più? S., il protagonista di Addio arrivederci ciao, trascorre il tempo così. Questo gioco gli sembra un buon modo per smettere di tremare, ma senza svegliarsi. Perché è più semplice per chiunque cambiare casa, lavoro, relazione, amante, città, persino nazione alle volte, per raccontarsi di avercela fatta, di essere rimasti interi, di aver capito che i problemi erano altri e circostanziali che, insomma, non ci toccavano e, nel momento in cui noi avremmo scelto di abbandonarli, questi non sarebbero più tornati a riguardarci. Chi vuole se ne va: questo è il gioco di S., peccato che non funzioni esattamente così.
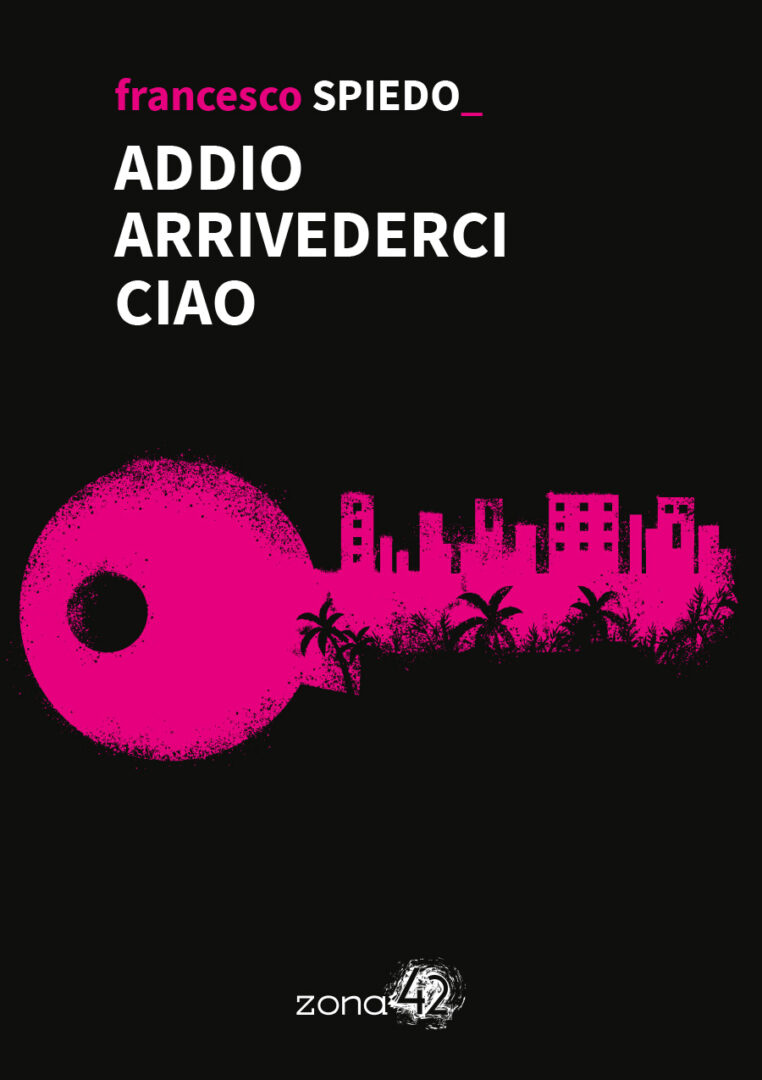
A fornire ulteriore contesto, qualora servisse riguardo il mondo di S. – che poi è pure quello dei Millennial italiani e oltreconfine – è l’ennesimo successo discografico di Marracash, È finita la pace (2024). «La bolla del presente non vissuto» (Crash) della copertina e leitmotiv dell’intero album sembra l’esatta colonna sonora della novella di Spiedo che può, forse, trovare la propria più esatta, sintetica, distillata sinossi proprio nelle barre di Marracash: «Chi dice in giro che sta bene, ma / Soltanto non lo fa vedere / Chi si ubriaca di lavoro / Chi torna e prende un altro volo / Chi è prigioniero del suo ruolo / Vuole essere nuovo di nuovo» (Gli sbandati hanno perso).
S., infatti, è stanco della città, delle sue regole, delle solite compagnie, della routine. Vuole cambiare vita, quindi programma una partenza, l’ennesima, eppure diversa: dell’odore del definitivo è impossibile non restarne inebriati. Si apre quasi così Addio arrivederci ciao, paradossale già dal titolo, un saluto «che pigola sempre più piano»: quasi perché, infatti, il principio non è la decisione della partenza, ma con la sua comunicazione agli altri, agli amici, a G. – soprattutto a G – perché nella nuova crisi dell’identità individuale che stiamo attraversando – in un tempo davvero troppo piccolo rispetto alla precedente e, nonostante tutto, così diversa – rappresentata da Spiedo senza che le lettere di un solo nome vengano versate, sia di persone sia di città – perché non è tanto il «dove vai?» ad avere rilevanza, ma il «quando parti?» domandato proprio e non casualmente da G. – in cui le nostre esistenze quotidiane sono vissute basandoci su una concezione almeno lievemente errata di noi stessi, solo attraverso gli altri siamo in grado di riconoscerci e – augurabilmente – di comprenderci.
Nel momento in cui S. si trova solo, pronto a concretizzare il proprio obiettivo, ovvero la partenza, tanto semplice quanto inutile, la realtà, rappresentata dai contorni asfittici e arrugginiti della città, si distorce nel paradosso che si rivela, però, essere esattamente quel che il protagonista ha (creduto di aver) scorto negli occhi dei suoi amici – specialmente di G.
Sintomatico che questa visione folle, assurda e maestosa Spiedo abbia deciso di rappresentarla attraverso un riappropriarsi che è un invadere da parte della natura degli spazi urbani, sullo sfondo di una tecnologia incapace di fornire qualsiasi appiglio o soluzione: un mondo al contrario rispetto a dove già siamo arrivati con lo spettro dell’AI, pronta a sbilanciarci oltre un baratro a cui non sappiamo disegnare un confine.
Ecco, allora, che S. trova nella propria rincorsa verso una partenza insensata quanto impossibile
sprovvista di logiche smartphonizzate di fronte ad animali e alberi e foreste che invertono l’ordine
convertendolo da stabilito a naturale, ma in modo pacifico, adeguato, giusto, quasi. Il simbolismo
rappresentato in Addio arrivederci ciao, allora, lo possiamo interpretare come la nuova tesserina –
che non avremmo davvero mai voluto – di un quadro più ampio che poggia sull’immobilismo sociale e politico denunciato da Dino Buzzati, sulla crisi economica e l’industrializzazione crescente degli anni Settanta di Italo Calvino, sullo smarrimento esistenziale dovuto alle trasformazioni della società di Luigi Pirandello.
Attraverso una maestrale, in quanto semplice ed essenziale, rappresentazione dell’universalità delle emozioni umane – alienazione, speranza, attesa – della disumanizzazione dell’individuo e della volontà di riflettere sulla condizione umana in modo universale e non specifico, Francesco Spiedo tratteggia un’opera capace di svelarci nuove riflessioni a ogni rilettura. E ci fa disperare, non come gli animali: come gli esseri umani ché, adesso, ne siamo consapevoli, un po’ di più.
In copertina: Addio arrivederci ciao di Francesco Spiedo
