Non tutti gli uomini ma sempre un uomo. È sempre un uomo la persona che mi fissa con insistenza sul sedile frontale del treno, che per strada mi chiama urla commenta le mie gambe o la mia faccia o il mio seno, è sempre un uomo che con il buio mi fa preferire l’auto al mezzo pubblico, la bicicletta alla passeggiata, è sempre un uomo la ragione per cui a volte cambio marciapiede e vagone, per cui tengo le chiavi nella mano mentre sto rincasando, è sempre un uomo quello che mi spiega, che sa di più, che dice meglio. È quasi sempre un uomo, infine, a uccidere una donna.
Io ho trentasei anni e sono cresciuta così. Questa è stata ed è la mia normalità, ci sono immersa al punto che a volte dimentico di farci caso ma poi, in fondo, so che è meccanismo di difesa: per non fermarmi a pensare, una volta in più, a quanti condizionamenti subisco nei miei movimenti, negli spazi che occupo, nelle mie interazioni con gli altri. Perché pensarci fa piangere di rabbia. Di fatto la mia libertà non è la stessa di un uomo, perché sono condannata ad avere paura e dovermi proteggere. Io sono una donna e per tutte le donne, in Italia, questa è la vita.

Questo, in poche e spicce parole, e nella sua realizzazione più pratica, significa cultura patriarcale. Non tutti gli uomini la praticano, ma è sempre un uomo a farlo. A volte anche una donna. Ma chi mi molesterà, chi mi farà del male, chi mi costringerà a cambiare marciapiede sarà sempre un uomo. Virginia Woolf, una delle scrittrici che amo di più, a un certo punto, nel suo Una stanza solo per sé (Bompiani 2022, traduzione di Mario Fortunato), scrive questo: «La storia dell’opposizione degli uomini all’emancipazione delle donne è forse più interessante della storia stessa di quella emancipazione». Mentre lo scrive è il 1929. A me questa frase ha sempre infuso molto coraggio. Mi succede spesso, che siano le scrittrici che mi hanno preceduta a darmi determinazione e speranza. Sono le loro parole e loro storie, è il tempo raccolto, preciso e intenso della letteratura: mi sembra di vedere la superficie di questo nostro mondo che vorrebbe – nei termini dei rapporti di potere tra i generi – perpetuarsi sempre uguale a sé stesso, finalmente incresparsi, tradire un’incertezza. C’è un continuum, tra me e loro, attraverso le epoche e lingue e culture diverse, al netto dei privilegi di cui io innegabilmente posso godere grazie alle lotte passate delle mie madri e delle mie nonne e che loro, invece, potevano soltanto sognare. Una comunanza nella condizione: siamo donne che vivono in una società patriarcale, dove persistono norme, pratiche e atteggiamenti volti a normalizzare, minimizzare e ridicolizzare la violenza sulle donne, di qualsiasi tipologia si tratti, con lo scopo di consolidare il potere delle posizioni maschili.
Mi dà altrettanto coraggio – ed è anche una coltellata – leggere queste righe di Woolf, sempre da Una stanza solo per sé: «Comunque, quando si legge di una strega che è stata affogata, di una donna posseduta dal diavolo, di una fattucchiera che vende erbe medicinali, o perfino della madre di qualche uomo non comune, credo che allora siamo sulle tracce di un romanziere mancato, di un poeta soffocato, di una Jane Austen muta e senza gloria, di una Emily Brontë uscita di senno nella brughiera o che mite mieteva lungo le strade principali, resa folle dalla tortura a cui il suo stesso talento la condannava». Quante donne, prima di subire le forme più manifeste di violenza di genere, hanno dovuto subire il ridimensionamento, l’esclusione, la marginalizzazione? Il tema, è chiaro, non è alieno nemmeno al canone letterario: anche in Italia tuttora è in corso un importante percorso di studio e recupero delle tante autrici finite presto dimenticate per ragioni che spesso avevano più a che fare con l’essere donne in un mondo culturale di uomini che con il valore del loro lavoro. Di alcune di loro, grazie a questo impegno, finalmente oggi si possono tornare a leggere i romanzi, i racconti, le poesie, ma è soltanto la punta dell’iceberg.

Tra le autrici che sono tornata a leggere e a scoprire negli ultimi anni c’è, per esempio, Ada Negri. Mia concittadina (siamo entrambe nate e cresciute a Lodi), vissuta tra il 1870 e il 1945, Ada Negri ebbe in vita un buon successo: consacrata al grande pubblico con la raccolta di versi Fatalità (Milano, F.lli Treves, 1892), godette addirittura della stima del regime fascista, che nel 1931 la insignì del Premio Mussolini per la carriera. Raggiunse anche un traguardo di rilievo: fu la prima donna a venire ammessa all’Accademia d’Italia. La sua fama è stata senza dubbio soprattutto legata alla produzione poetica, puntualmente infilata nei programmi scolastici, mentre della narrativa si è parlato poco e nulla. Ed è un gran peccato. Perché Ada Negri, da donna del suo tempo, ha scritto delle cose assolutamente senza tempo, sulle donne e – lo azzardo io oggi con un secolo di vantaggio – per le donne.
Come la serie di racconti, raggruppati nel volume Sorelle, che fu pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 1929 e che oggi possiamo leggere ripubblicato da Elliot nel 2016. Si tratta di ventuno piccole storie incastonate nella bassa Lombardia di inizio Novecento, ambientate soprattutto in campagna e con qualche incursione milanese, scene e ritratti di donne di quegli anni caratterizzati una notevole complessità e contemporaneità: c’è Plautilla, vedova e piccola di statura e nella sua cucina si ride, «perché non si dovrebbe ridere?», c’è la zia Regina che preparava la polenta, buona e austera e dedita alla casa e alla famiglia, ci sono la donna inginocchiata dentro il Duomo di Milano, che prega a capo chino, e la madre del piccolo Fosco a cui hanno sparato per sbaglio, ma c’è anche la Cacciatora, che tutti chiamano così per via del suo abbigliamento maschile e che utilizza il soprannome (maschile) di Eddie, c’è Marzia che è stata quasi ammazzata dal marito geloso e porta una cicatrice sulla faccia, e sua figlia che guardandola arriva a chiedersi per quale ragione mai dovrebbe sposarsi, «per avere l’inferno in casa, e far nascere dei figli a soffrire, e un bel giorno buscarmi quel regalino sulla guancia?».
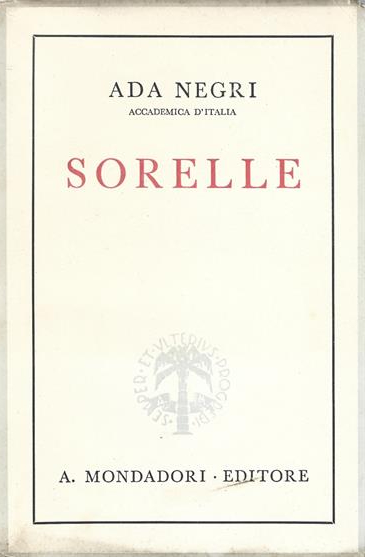
Lo sguardo di Ada Negri si posa, privo di giudizio alcuno, su vite di donne molto diverse, dove scelte e consapevolezze pesano con risultati alterni: su tutte, però, incombe l’ombra di un maschile ingombrante, dominatore, che può picchiare dentro le mura domestiche, rispondere a richieste d’amore con silenzio e freddezza, deridere le peculiarità di un corpo non conforme alle aspettative delle società perché, con grande probabilità, ne è terrorizzato. Si salvano i figli, gli innamorati, gli anziani: ma rimangono apparizioni laterali, innestate dentro un racconto che mantiene al centro l’identità femminile. Un’identità femminile che appunto – e questo è per me il gesto da grande scrittrice – si preserva nella sua frammentazione e nelle sue contraddizioni, nonostante una cultura patriarcale che la vorrebbe unica e fedele a sé stessa, costretta nella casella che le è stata assegnata: le donne dovrebbe servire, non essere. Noi, oggi, possediamo il linguaggio per chiamare molte cose con il proprio nome: e così riconosciamo in queste storie tutte le strategie che in Italia la cultura patriarcale continua a usare per continuare a esistere, come l’utilizzo di un linguaggio misogino, l’oggettivazione costante del corpo femminile, il cosiddetto slut shaming, cioè la stigmatizzazione dei comportamenti e dei desideri sessuali femminili che si discostano dalle aspettative di genere tradizionali, e la colpevolizzazione della vittima quando subisce una violenza, cioè lo spostamento su di lei della responsabilità o di parte della responsabilità di quel che è accaduto. Oggi sappiamo anche che la cultura patriarcale tratta tutti questi comportamenti come casi rari, isolati, quando invece appartengono a un fenomeno di carattere sistemico.
E noi possiamo guardare ai racconti di Ada Negri come una sfida a questo schema: ventuno storie legate da una messa in discussione del paradigma maschilista ma soprattutto legate da un elemento ancora più potente, legate dalla sorellanza. Il racconto “Signora con bambina” si chiude con queste righe: «Francesca Alamanni, vuoi che parliamo un poco insieme? Da te a me, da donna a donna? Di noi donne nessuno ha mai capito nulla. (…) Ma se tu ti confidi al mio cuore, vedrai forse il tuo in uno specchio».
Così anche le Sorelle di Ada Negri mi danno coraggio. Per continuare a vivere e a combattere dentro a un processo cosciente di intimidazione attraverso il quale gli uomini mantengono le donne in uno stato di paura (definizione, purtroppo calzante, della giornalista Susan Brownmiller). Per non rinunciare alla mia unicità, alla mia libertà. Per contribuire a legittimare una discussione che non esaurisca la sua spinta dopo la commozione per l’ennesimo femminicidio e lavori davvero per un cambiamento radicale nella società.
Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. #unite #rompiamoilsilenzio
In copertina: Ada Negri
