Il romanzo operaprima di Simone Salomoni, edito da AlterEgo sotto la direzione editoriale di Roberto Venturini, è la lunga confessione di un pittore dell’Appennino Bolognese che “forse” – e la volante che lo ha raggiunto fino al paese di Monghidoro è lì per questo – ha contribuito alla realizzazione di un atto terribile. Ma sarebbe riduttivo far coincidere questo romanzo con la sua, pur piena di tensione, trama: perché operaprima è innanzitutto un inno all’arte, alla centralità del coraggio e dell’autenticità della creazione artistica. Per questo ne ho parlato con Simone Salomoni.
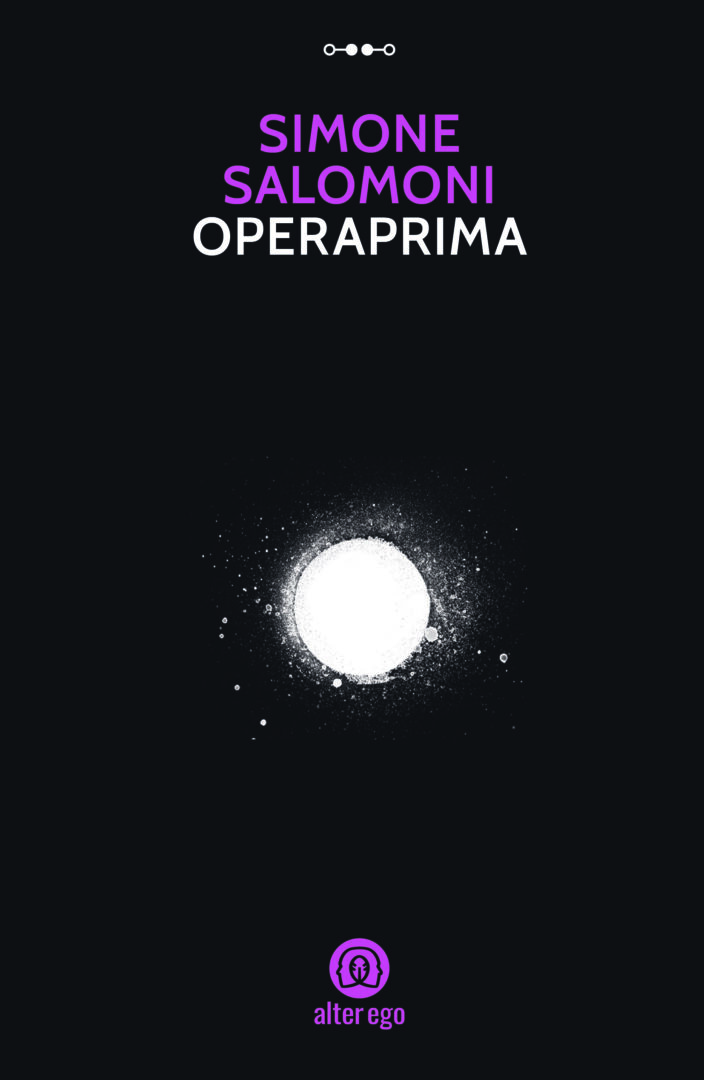
Se è vero che operaprima si presenta come una confessione, è pur sempre la confessione di un artista: di chi sa perfettamente quanto lo sguardo, l’interpretazione e il montaggio possano modificare i fatti “realmente” avvenuti. Del resto il pittore protagonista gioca a carte scoperte: “non prendete per buono niente – avverte – soprattutto il mio racconto; dubitate sempre delle mie parole, prendetele per quello che sono: parole; sfiduciate ciò che dico, non dirò nulla di falso, ogni mia parola sarà vera, ma anche se vera potrebbe non essere reale”. È solo rinunciando all’adesione alla realtà che si può raccontare qualcosa di vero?
C’è tutto un cinema, ma anche una letteratura, che porta con sé un’avvertenza che ho sempre trovato curiosa – “tratto da una storia vera” – e che timidamente propongo di modificare in “tratto da una storia reale”, anche se è impossibile raccontare qualcosa di reale, possiamo al massimo raccontare qualcosa di verosimile o ancora meglio di credibile, ma nel momento in cui raccontiamo o fotografiamo o filmiamo o dipingiamo o mettiamo qualunque diaframma fra un fatto e la rievocazione del fatto la realtà è già andata a Caronte. La realtà è come l’eternità: puoi viverla ma non afferrarla. Quello che puoi afferrare è la verità, o con più precisione: la tua verità, attorno a un fatto. Verità che è sempre parziale e relativa, ma che può comunque essere condivisa da altre persone che useranno le tue verità per indagare le proprie. Il narratore di operaprima è consapevole di questo procedimento e chiede espressamente al lettore della sua confessione di chiedersi se vuole leggerlo per conoscere “la verità” o soltanto per avere confermata “la propria verità”. Ovviamente è un atto manipolatorio: l’io narrante di operaprima sa bene che la sua verità non può coincidere la Verità con V maiuscola, perché questa non esiste.
Alcuni recensori hanno parlato di narratore inaffidabile, e certo, il narratore di operaprima è inaffidabile nella misura in cui ogni narratore in prima persona è inaffidabile, nella misura in cui ogni racconto in prima persona è inaffidabile – che è poi il motivo per il quale le narrazioni in prima persona consentono al lettore che sono di sospendere più facilmente l’incredulità rispetto alle narrazioni in terza persona: se so di non potere credere paradossalmente credo più facilmente – ma il narratore di operaprima, secondo me o almeno nelle mie intenzioni, più che un narratore inaffidabile, è un ladro di fuoco, è Arsenio Lupin, è un narratore inafferrabile.
Andando avanti con la lettura scopriamo che la confessione del narratore si alterna con alcuni racconti: le storie scritte da Simone Salomoni, l’adolescente che nel protagonista di questa storia vede un possibile maestro. Questi racconti si configurano, in un certo senso come una seconda confessione: Simone si racconta al pittore attraverso storie che, proprio come la sua, scavano sempre più a fondo alla ricerca della verità. Vedi in questa ricerca comune uno dei punti principali della scelta, da parte di un allievo, del proprio maestro?
Quando Simone incontra il pittore non ha nessuna consapevolezza artistica, non conduce nessun tipo di ricerca e quindi non può trovare niente. L’artista, però, opera un riconoscimento, comprende che Simone – uso adesso una bella frase confezionata – è disponibile a immolarsi sull’altare dell’arte, un’attitudine fra le tante a disposizione dell’artista. Simone non sta cercando un maestro, anche perché non so se è possibile – so per certo che è insano – cercare un maestro. Sarebbe come cercare l’amore: come fai a cercare l’amore? L’amore, un maestro o un allievo, l’opera d’arte, sono collegate fra loro perché – credo io: poi posso sbagliare – puoi solamente trovarle. Se io, ma forse tutti, mi mettessi a scrivere dicendo: voglio scrivere il romanzo, figuriamoci l’opera d’arte, il capolavoro, andrei incontro a frustrazioni terribili. Certo: la mia attitudine è quella di trovare opere che mi sembrano potenzialmente importanti e di provare a comporle al massimo delle mie possibilità, con il rispetto e il timore che si deve all’atto creativo – atto raro, quando avviene ha a che fare con il Divino; penso al coito: tutti abbiamo numerosi coiti, ma quasi nessuno di questi è fecondo, creativo; allo stesso modo possiamo scrivere cento romanzi senza essere fecondi e creativi – ma senza farne un’ossessione: per questo parlo di attitudine. Maestro e allievo non si scelgono per il tipo di ricerca, si scelgono per il tipo di attitudine. Io non ho avuto la fortuna di riconoscere un Maestro, quando ho incontrato Giulio ero forse sufficientemente strutturato o forse avevamo una diversa attitudine, non so dirti. Però ho avuto la fortuna – grazie a Giulio che mi ha dato la possibilità di lavorare in Bottega, dopo avermi dato un modello posturale – di potermi misurare con persone che volevano scrivere e con le quali c’è stato un reciproco riconoscimento, persone che io ho riconosciuto come miei Allievi, che mi hanno riconosciuto come loro Maestro. Le rarissime volte in cui è avvenuto, penso di poter dire, si è trattato del riconoscimento di un’attitudine, non di una comune ricerca.
Il pittore, Simone Salomoni e Marie Bertrand, madre di Simone: tutto il romanzo, come una tavola perfettamente in equilibrio, si tiene su questi tre punti; si gioca sulle relazioni tra questi tre personaggi. A volte, leggendo la tua storia, ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte a un’opera teatrale, con poco più, sulla scena, che questi tre corpi – e dico “corpi” non a caso, dato che un altro punto importante è il lavoro sulla fisicità. Puoi parlarcene?
Scrivo pochissimo e nei periodi in cui scrivo scrivo ogni giorno, nessuno escluso, fra le 5:55 e le 8:00, al buio e nel silenzio. Suona la sveglia, scendo dal letto, mi metto a scrivere. Non passo dal bagno, non prendo il caffè. Ora. A me piace dormire, e ho bisogno di dormire almeno setto otto ore e mai mi sveglierei prima delle 6:00, il mio quotidiano mi consente di alzarmi fra le 7:30 e le 8:00. La scrittura, insomma, agisce direttamente sui miei ritmi vitali, scrivere è per me prostrante non solo da un punto di vista mentale e emotivo – anche: molto – ma ancora di più da un punto di vista fisico.
La scrittura è stata per me dissipazione, dissipazione di occasioni e di affetti, ha avuto delle conseguenze pratiche nella mia vita, la mia routine di scrittura, il rigore al quale mi costringo, ha avuto e avrà in futuro – credo – delle conseguenze che si riflettono anche sul mio corpo. Non vivo la scrittura come un atto intellettuale, la scrittura per me è un atto carnale, è performance, ed è una performance faticosa, è come correre ogni giorno la maratona, non allenarsi alla maratona, ma correrla in due ore e cinque minuti e allora mi sembra naturale che la scrittura che produco risenta del processo produttivo, non so se è un bene, ma è un dato di fatto, la dissipazione del mio corpo si traduce e si riflette nella dissipazione del corpo dei miei personaggi. Il pittore ha un corpo (e una mente) mal funzionante, è impotente e questa impotenza è impotenza in primo luogo creativa: non può esserci creazione in assenza di erezione; Marie ha un corpo che si dissipa lentamente, giorno dopo giorno, come ogni corpo umano, attraversa l’esercizio della propria personalità, attraverso la seduzione si illude di rallentare un decadimento inevitabile; il corpo di Simone, infine, è un corpo che viene (auto) usurato consumato mutilato attraverso la lama del cutter, il bisogno di conferme, la riscossione degli orgasmi altrui.
A proposito di fisicità, un lavoro speciale lo hai dedicato al personaggio di Simone Salomoni. Fin dalla prima descrizione (“un corpo giovane disteso su una sdraio, a suo agio dentro un libro. I piedi nudi, le gambe lunghe, toniche, la scanalatura del quadricipite in evidenza e solo un paio di braghette cortissime a coprirle. Una canotta, la pelle chiara eppure leggermente abbronzata, una totale noncuranza nel volto e nel fresco del mattino”) ci troviamo di fronte a un personaggio androgino, ma è andando avanti nella lettura che notiamo con stupore che Simone Salomoni, di madre francese – potremmo dunque pronunciare il suo nome “Simòn” – non ha mai una esplicita caratterizzazione (proprio dal punto di vista dell’uso degli aggettivi e dei verbi) al femminile o al maschile. Puoi raccontarci il lavoro che, a questo proposito, hai fatto sulla lingua?
Dopo avere ricevuto la prima immagine, tuttora presente nel romanzo, dopo avere trovato la forma e pensato alle relazioni fra i personaggi e ai loro conflitti, dopo avere – in ultima battuta secondo il procedimento tipico della mia immaginazione – abbozzato una trama poteva essere arrivato il momento di scrivere. Però non l’ho fatto, era come se mancasse qualcosa, l’elemento che potesse trasformare una serie di idee in un romanzo che qualcuno, in questo caso io, avrebbe proprio dovuto scrivere. Quando ho capito che il mio nome poteva essere letto anche come un nome femminile mi sono eccitato, avevo l’occasione di provare a fare qualcosa di coerente con il mio percorso, con la mia idea di letteratura e – allo stesso tempo – contenente un certo grado non arrivo a dire di innovazione, ma almeno di modernità. Mi sono chiesto: ma è possibile, descrivere un corpo senza definirne il genere? è possibile scrivere un testo non al presente e non in prima persona nel quale l’identità di genere di un personaggio non può essere stabilita con nettezza? Il primo sì, è stato deciso: posso farlo. Restava il secondo aspetto, un nodo linguistico. Scrivere in italiano usando il genere neutro è complesso, basta pensare ai recenti dibattiti e alle introduzioni di ə, ù, * nelle opere di fiction e non fiction: la riuscita del romanzo passava per forza da lì, dalla lingua. Ho sempre trovato capziosi i dibatti nordisti contro sudisti fra sostenitori della superiorità della lingua e sostenitori della superiorità della trama – credo che i due aspetti siano interconnessi: sarà che non sono né un costruttore di trame né un virtuoso della lingua – ma riconosco che un testo scritto è prima di tutto la lingua in cui è scritto, altrimenti affidarsi alla scrittura per raccontare una storia sarebbe un gesto anacronistico, forse insensato.
Così ho cominciato a scrivere. All’inizio è stato faticoso, ho dovuto resettare il pensiero, ridiscutere il mio sapere espressivo, rimodulare la composizione della pagina, parola dopo parola, pensiero dopo pensiero, non potevo scrivere come sempre e rivedere tutto alla fine, non potevo perché il testo avrebbe peccato in sincerità, sarebbe stato un artificio che il lettore avrebbe presto o tardi sgamato. A un certo punto, senza rendermene conto, ho fatto click: il cervello ha cominciato a pensare neutro e le dita hanno cominciato a muoversi di conseguenza. Chi scrive in endecasillabi dice di pensare in endecasillabi, non so se sia vero perché non scrivo endecasillabi. Però, ecco, ammesso che sia vero: scrivendo operaprima mi è capitato qualcosa di simile.
C’è un’altra scelta, a proposito di Simone Salomoni, che mi ha colpita: questo personaggio, che porta il nome dell’autore, non coincide in operaprima con l’io narrante. Una scelta inusuale che mi ha ricordato il racconto Caro vecchio neon di David Foster Wallace, dove appunto la narrazione in prima persona non è affidata “David Wallace” personaggio, che compare molto più avanti nel racconto. Puoi raccontarci i motivi di questa operazione?
Simone e operaprima dovevano condividere lo stesso destino. Non volevo costringere Simone all’interno di un genere definito con nettezza, non volevo costringerci operaprima. Simone doveva prima di tutto essere un essere umano, operaprima doveva prima di tutto essere letteratura: e se avessi dato il mio nome cognome al narratore, oltre a saltare le peculiarità di cui abbiamo parlato, sarebbe saltata anche questa necessità; operaprima sarebbe entrata automaticamente nel perimetro della cosiddetta autofiction e volevo evitarlo. Non perché contrario al genere, ammesso che l’autofiction sia un genere, anzi, quando è motivata, quando non è una ripiegamento alla moda, quando non la si confonde con l’autobiografia e non è la replica infinita di modelli triti e ritriti, l’autofiction è del tutto adatta a immaginare e forse praticare quel tipo di sfasamenti indispensabili per un’evoluzione della letteratura. Poi. Se il lettore legge operaprima come una autofiction a me sta bene, come mi sta bene se legge Simone. Allo stesso modo se il lettore legge operaprima come un romanzo a me sta bene, come mi sta bene se legge Simòn.
Per quanto mi riguarda operaprima non è romanzo e non è autofiction o meglio: non è un romanzo ben fatto e non è autofiction ben fatta, è qualcosa di un po’ diverso, bislacco se vogliamo. Se devo dargli un nome gli do il nome che ho trovato durante una conversazione avuta qualche mese fa con un’altra scrittrice: autofriction.
Un’ultima domanda. Quando inizi operaprima sei “costretto” a terminarlo in poche ore: la trama è incalzante (cosa è successo a Simone?), le relazioni tra i tre personaggi avviluppano il lettore, la narrazione si figura centripeta al punto da stringere via via le maglie intorno all’atto terribile che – anticipazione dopo anticipazione – appare sempre più vicino. Ma non si tratta solo di questo: una parte importante, dal punto di vista della tensione e del magnetismo, la gioca il ritmo. Tutta la confessione è un vero e proprio “muro” di testo: non si va mai a capo, le virgole scandiscono frasi incalzanti e le immagini sono spesso offerte per accumulo (“non c’è prato, non c’è albero, non c’è mare, non esiste uomo che ci possa irradiare se non siamo noi stessi fanale, carica elettrica, dinamo, accendino, fiamma nella notte”). Ci racconti come hai lavorato da questo punto di vista?
Quando scrivi ti capita mai di pensare: “vorrei che il lettore leggesse così”? Intendo proprio come pratica di lettura: vorrei che leggesse completamente nudo o a testa in giù, al bagno o prima di coricarsi? Io ho immaginato un lettore che prende in mano il libro, tipo una domenica dopo pranzo, o una sera in cui non ha voglia di accendere la televisione, e comincia a leggere e arriva in fondo, quasi senza rendersene conto, un lettore che prende il treno e va dritto alla stazione di discesa. Volevo un lettore disposto a sperimentare su di sé il senso di soffocamento o vertigine che prova Simone personaggio, e che provo anche io quando scrivo. Volevo, in qualche modo, dire: io ti lascio libertà assoluta, il mantra del romanzo è: “sentiti libero”, lo ripeto spesso alle presentazioni, io ti lascio libertà assoluta su tutto, ma su un aspetto no, su un aspetto devi fare come voglio io, la pratica di lettura la decido io. Che se ci pensi è paradossale, è l’esatto contrario di quello che solitamente avviene, di solito l’autore tenta di orientare il pensiero, suggerisce interpretazioni, definisce chiaramente i temi del romanzo, dà risposte e fa morali – sono i romanzi peggiori – e il solo grado di libertà che lascia al lettore è legato alla pratica di lettura. Ecco, trovato il paradosso ho tentato di onorarlo adottando soluzioni stilistiche funzionali allo scopo: muri di testo, dialoghi che si fondono in essi, punteggiatura – prima di tutto la punteggiatura – vorrebbero essere funzionali al mio scopo.
