Abbiamo tutti ben presente il volto pietrificato del presidente degli Stati Uniti George Bush l’11 settembre 2001. Si trovava nella classe 301 della Emma E. Booker elementary school a Sarasota, in Florida, quando il capo dello staff presidenziale gli si avvicina e gli sussurra qualcosa all’orecchio: due aerei di linea hanno colpito le Twin Towers nel centro di Manhattan, a New York. Il mondo libero pugnalato al cuore, all’improvviso, da un qualcosa di sconosciuto, che poche ore dopo avrà un volto e un nome: Al-Qaida, Osama bin Laden, terrorismo islamico. Ma concentriamoci sul volto di Bush negli istanti successivi alla notizia: ha perso contatto con ciò che lo circonda, è impreparato, lo sguardo è perso nel vuoto, sfoglia un libro, il contesto naturalmente gli impedisce una qualsiasi altra reazione, gli impedisce di dire qualunque cosa. Eppure quel volto, quel silenzio, segnano la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, la fine di un decennio di incontrastato dominio geopolitico e culturale degli Stati Uniti sul mondo e l’inizio di nuovi conflitti, l’emergere di nuove potenze sulla scena mondiale, la riacutizzazione degli scontri in Medio Oriente. Ecco, quel silenzio, quegli occhi fissi nel vuoto e quel volto non sono che l’effetto dell’Evento, l’effetto paralizzante dato dall’incapacità di reagire e agire di fronte a ciò che sta accadendo.

Ma è possibile dire ciò che accade? Le nostre parole sono adeguate a ciò che accade? Ma soprattutto: che cos’è ciò che accade? Gli eventi – passati, presenti e futuri – sono quello che ci succede e ci riguarda. E fin qui, nulla di complesso. Il punto problematico è però dato dalla possibilità di tradurre quanto accade in un testo, poiché talvolta il materiale che il linguaggio ci propone non ci sembra sufficiente.
Le filosofie di Ludwig Wittgenstein e di Theodor W. Adorno ci propongono nel merito una sorta di duello filosofico a distanza circa la possibilità di dire ciò che accade. Il Tractatus Logico-philosophicus (1922) di Wittgenstein si chiude con la celeberrima proposizione «su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere», ma di cosa si può parlare allora? Di ciò che il filosofo austriaco chiama “stati di cose”. Per lui le componenti della realtà stanno insieme congiunte da una distanza spaziale: vi sono degli elementi che riescono a trovare delle corrispondenze fra gli stati di cose, e queste corrispondenze non sono che delle soglie che delimitano e uniscono allo stesso tempo tali elementi. Tuttavia ciò che adesso sta accadendo non può essere detto, di ciò che ora è in-essere non si può parlare: questi sono i confini del mondo e del linguaggio dell’essere parlante. Quando superiamo i limiti delle cose da dire – per Wittgenstein – abbiamo a che fare con qualcosa che esce da questo schema, e dunque bisogna misticamente tacerne.
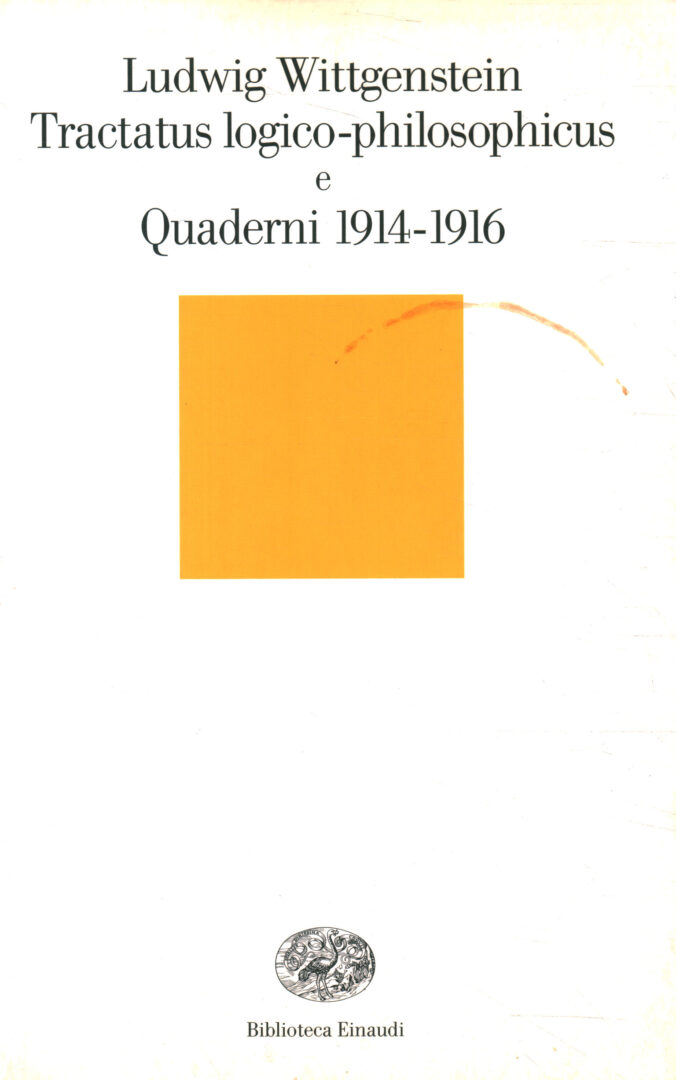
Adorno invece, hegeliano eretico, ha una fiducia incondizionata nella potenza espressiva del linguaggio, e in risposta al suo interlocutore afferma che la filosofia è, in sostanza, lo sforzo di guarire la ferita che il concetto stesso produce. Per Adorno quindi la conclusione a cui arriva Wittgenstein non è intellettualmente ammissibile: la filosofia si nutre della porosità problematica che vi è fra il reale e il mistico, fra il cerchio e la sua cornice, e la conclusione necessaria è che la filosofia ha il compito di dire l’indicibile, di stare sui limiti del linguaggio o superarli.
Il concetto, unico strumento di cui la filosofia dispone, è uno sforzo comunicativo su ciò che sembra non avere alcuna presa, e che si propone di raccontare quello che a prima vista sembra non poter essere raccontato. In Dialettica negativa (1966) Adorno ci dice che la filosofia deve «rimettersi alle cose», rimettersi a ciò che accade, all’evento dell’accadere delle cose, e la missione sacra della speculazione filosofica è quella di riuscire a dire e presentare il non identico: ecco il concetto! Bisogna cogliere il differire delle cose e unificarlo in un fascio, in un unicum che esprime come identità quanto di fatto è differente.
Come possiamo, a questo punto, avere fiducia nella dicibilità di ciò che è indicibile? Come possiamo usare il concetto, che riunisce il fascio evenemenziale? I primi a porre la questione della dicibilità del reale furono i teologi negativi. Nel V secolo Dionigi l’Aeropagita avrebbe detto che l’evento – da intendersi come il manifestarsi di Dio – ci sfuggirà sempre se intendiamo spiegarlo, se pensiamo di racchiuderlo usando il linguaggio: quanto accade non si può dire, è indicibile e non irrigimentabile nel muro delle parole o delle immagini. Ed ecco che si può arrivare all’evento per toglimento, senza aggiungervi nulla, nessun linguaggio, nessuna parola, nessuna immagine, nessun simbolico; è solo togliendo che si arriva a fare esperienza dell’evento, in una piena passività dell’uomo. Se di “discorso” si può parlare, in teologia, non è il discorso dell’uomo su Dio, ma è il discorso di Dio a noi (Esodo, 33, 18-23), che assomiglia a un passaggio e coincide con l’enunciazione del nome del Signore.
Disse Mosè: «Mostrami la tua gloria». Rispose: «Io ti mostrerò ogni bene, e pronunzierò innanzi a te il nome del Signore […]». Poi disse: «Non potrai vedere il mio volto; perché nessun uomo mi vedrà e poi rimarrà vivo». Ed ancora: «Ecco» disse «v’è un posto qui vicino, e tu sarai sopra la roccia; quando passerà la mia gloria, ti metterò in una spaccatura della roccia e ti proteggerò con la mia destra sinchè non sarò passato; poi leverò la mia mano e tu mi vedrai per di dietro; ma la faccia mia non potrai vederla».
Leggendo questo passo biblico non può non venire alla mente dello studioso di filosofia il radicale concetto di Ereignis heideggeriano. Il “secondo Heidegger” tenta invano di risolvere l’insoluta questione dell’Essere posta in Sein und Zeit (1927) introducendo il termine «evento». L’Ereignis è l’Essere che contemporaneamente si dà e si nasconde, si mostra e si ritrae nella stessa azione, nello stesso tempo e nella stessa direzione, impedendoci di farne un significato, poiché nel momento stesso in cui l’Essere si fosse mostrato come significato lo si sarebbe già perso. Rivelazione e contemporaneo nascondimento, buio e luce insieme, impossibilità di significato, di linguaggio, di parola. È puro misticismo.
L’evento è ciò che sorge e immediatamente viene perso, è un passaggio che non è afferrabile concettualmente – e linguisticamente – nel momento in cui accade, ma di cui restano delle tracce visibili, è un quid atopico e acronico, che non ha né causa né fondamento, perché è slegato dalle condizioni stesse che l’hanno preceduto. L’evento, dice Jacque Derrida, è un assoluto, è l’impossibile, è qualcosa che si fa avanti in modo imprevisto, che noi non vediamo arrivare, che si produce laddove non ce n’è un’anticipazione né un orizzonte. L’evento, per il filosofo francese della difference, è una sorta di miracolo, che non può essere visto arrivare perché non ha margini di visibilità, è ciò che ci coglie impreparati, ed è proprio questo stordimento per il quale non siamo pronti che lo rende tale. L’evento è quindi l’arrivo di un unicum che ci sorprende, ma che tuttavia ha a che fare con una logica del ritorno. Ed ecco che l’evento è anche necessariamente un ri-evento, perché se in esso vi è l’arrivo di un qualcosa di unico, di singolare e di imprevisto, c’è sempre anche una ripetizione, si ha sempre l’impressione che esso si replichi in modo traumatico non solo perché ripete delle cose già passate, ma perché annuncia delle possibili ripetizioni future, dei ritorni che si riproporranno sotto altre forme, un ritorno che però non esclude l’unicità dell’evento. In altri termini: l’unicità dell’evento è data dal fatto che esso ha luogo per la prima volta, senza alcuna attesa, ma questa “unica volta” è già elaborata dalla ripetizione.
Pensiamo ad esempio – per chiarire queste complicate riflessioni – agli eventi rivoluzionari geografici, cosmologici, politico-istituzionali o culturali, dalla Rivoluzione atlantica a quella copernicana, dalla Rivoluzione inglese a quella francese, da quella russa alle rivoluzioni totalitarie, da quella cubana al ‘68. Tutti questi eventi li potremmo lacanianamente definire delle irruzioni del Reale nella storia, dei lampi che rompono la continuità coerente del buio della notte, degli squarci nel tessuto simbolico della realtà che determinano l’inizio di un’altra storia, sono eventi che sovvertono il nostro modo di vedere la realtà, creando un vuoto fra il loro spazio e quello del mondo. Le rivoluzioni sono il farsi avanti dell’impossibile che genera delle smagliature così profonde nel tessuto coerente della realtà simbolica che costringono il simbolico stesso a ridefinirsi: il mondo dopo le rivoluzioni non può più essere lo stesso, l’evento rivoluzionario è una soglia che distrugge un mondo e, girando su se stesso, si avventa su un futuro che è di fatto una nuova storia, riscrivendo spesso anche il passato in funzione delle nuove categorie e dei nuovi codici che l’evento porta con sé.
L’evento rivoluzionario – nel quale non si sa più chi comanda, dove si vogliono smontare dei meccanismi di potere, dove le classi dirigenti hanno sempre paura di perdere i propri privilegi, dove si contestano e rifiutano dei codici culturali, dove si sperimenta – è la testimonianza che qualcosa è possibile nell’impossibilità, è un brusco risvegliarsi dal sonno della realtà che sfugge all’orizzonte del possibile. Esso è un quid scioccante e non prevedibile, per il quale non esiste un momento buono (rivoluzionario), perché l’evento accade nella totale imprevedibilità, ma allo stesso tempo non si può dare una rivoluzione permanente, dato che tutte le rivoluzioni sono destinate a “fallire“, a scaricarsi, a compiersi troppo presto nell’imprevedibilità e a far fare esperienza di sé troppo tardi, trasformandosi immediatamente in un qualcosa d’altro, in un nuovo codice, in un nuovo simbolico. Ed ecco che capiamo come l’unica risposta possibile alla rivoluzione sia quella di Napoleone, o di Stalin: congelare la rivoluzione e codificarla costruendo un ordine nuovo, prima che questa perdita della carica evenemenziale porti a una volontà di cancellazione della rottura avvenuta. Pensiamo a cosa è stata la Restaurazione post-napoleonica, la volontà politico-culturale europea di cancellare la Rivoluzione francese e il periodo napoleonico, fare come se non fossero mai esistiti, privare l’evento rivoluzionario della sua sostanza, ricucire la lacerazione e tornare indietro: operazione storicamente impossibile.
L’evento ‘rivoluzione’ arriva alle spalle della storia per spostarla su binari paralleli, essendosi caricato di un potenziale distruttivo che, dopo aver avviato una nuova storia, è preludio necessario a una sua ripetizione, in altri tempi, in altri luoghi, in altri contesti e in altre forme.
Un altro caso esemplificativo che ci aiuta a comprendere che cosa filosoficamente si intenda con il termine «evento» è quello proposto per l’idea platonica da Slavoj Žižek in Evento. Platone è scolasticamente considerato il padre di una concezione dualistica della realtà: per lui esiste un divenire soggetto a mutabilità e poi vi sono delle super-cose eterne, perfette e immutabili che lui chiama «forme» (τὰ εἴδη) e che fungono da modelli per la realtà diveniente. Žižek ci fornisce invece una lettura platonica antimanualistica: nel Fedro e nel Simposio Platone parla delle idee a partire dall’esperienza traumatica dell’Amore (e non viceversa!), e ci presenta l’èros come un desiderio desiderante generato da una mancanza, in quanto – come sostiene Umberto Galimberti – l’essere umano desidera ciò che non ha, mentre ciò che possiede appieno se lo gode. Ecco invece che proprio il godimento consuma la portata evenemenziale del desiderio amoroso, scaricandone la forza e trasformandolo in un qualcos’altro, facendolo diventare una relazione fra l’io e l’oggetto, trasformando quella carica originaria in una storia d’amore. Pensiamo a cosa ci capita quando ci innamoriamo. Quando ci si innamora si frequenta lo stesso mondo di prima ma non nello stesso modo, si vive il mondo con un’ossessione, con un desiderio – quello che Freud avrebbe chiamato «pensiero dominante» –. Quanto facciamo non ci interessa più, perde di significato, la nostra vita e quello che la circonda sono catturati dall’evento della follia amorosa che continua a farci vivere nel mondo senza farci essere nel mondo. Quindi la vera intuizione platonica sta nel fatto che le idee non sarebbero dei modelli eterni e immutabili che si contrappongono al divenire, ma sono l’apparire dell’evento, sono una forma formantesi, sono l’imminenza che precede la realtà: questa è la forma platonica, è l’e-venire di una realtà prima che essa sia evidente. Platone invece ha reso l’apparire dell’evento una super-cosa, ha scaricato l’energia evenemenziale cristallizzandola in un modello eterno e immobile, in altre parole ha ontologizzato l’intuizione dell’idea-evento rendendola un Essere.

Abbiamo quindi compreso come l’evento sia ciò che ci prende alla sprovvista, che ci coglie impreparati – «negati e senza talento» avrebbe detto Carmelo Bene –, che ci paralizza per un istante prima di provare qualsiasi tipo di emozione: la notizia di un figlio in arrivo, una perdita improvvisa, un’offerta di lavoro che non ci aspettavamo, lontano da casa e dagli affetti più cari, l’innamorarsi o la fine di un amore. Sono traumi, sono rotture incidentali della realtà che fanno franare la nostra vita e ci costringono a riprogettarla. L’essere umano non è quindi un “autoprogetto” – come vorrebbe Heidegger –, o meglio, lo è solo in astratto. Noi, al contrario, siamo il prodotto degli sgambetti del progetto, siamo ciò che si genera dal turbamento dell’aspettativa, dai suoi inciampi, dalle sue mancate realizzazioni, dai suoi eventi. «La vita è ciò che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti» diceva John Lennon: questo è l’uomo.
Ognuno di noi ha vissuto e vivrà l’esperienza dell’evento e ognuno di noi deve sapere che sono proprio questi vuoti improvvisi sulla strada della nostra esistenza che ci permettono di crescere, di maturare, di cambiare e di diventare ciò che siamo.
Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno agito esattamente come una rivoluzione o come l’idea platonica proposta da Žižek: sono arrivati all’improvviso traumatizzando il mondo occidentale, hanno terremotato gli equilibri geopolitici seguiti alla fine della Guerra fredda e hanno scritto un nuovo corso degli eventi: la fine del predominio unico e indiscusso degli Stati Uniti, le guerre in Iraq e in Afghanistan, l’incubo del terrorismo. La questione, ancora aperta, è se gli Stati Uniti siano stati in grado di ripensarsi dopo l’11 settembre, se abbiano realmente saputo elaborare il loro trauma.
