Jack Gladney (Adam Driver), anzi, diciamo bene, J.K. Gladney, è il più stimato professore universitario di studi hitleriani del paese. La moglie, la quarta, Babette (Greta Gerwig) lavora in chiesa, come il marito – come chiunque – ha paura della morte; di nascosto, acquista un farmaco antidepressivo sul mercato nero, il Dylar. Jack e Babette hanno una figlia, gli altri tre lui li ha avuti dai matrimoni precedenti. Nel Midwest, dove vivono, un giorno un “evento tossico aereo” (un carico di liquido infiammabile non identificato si disperde nell’atmosfera) sconvolge la loro quotidianità.

Rumore famigliare
Noah Baumbach ha un’ossessione vecchissima, attuale, cattolica, tanto italiana quanto americana, cioè la famiglia, un’unità di analisi fenomenologica. White Noise, l’adattamento del romanzo omonimo di DeLillo del 1985, è l’ultimo tassello. Al centro ha Gladney, voce narrante, osservatore della ritualistica famigliare; gli altri, Il calamaro e la balena, o The Meyerowitz Stories, tre anni fa Storia di un matrimonio, che in White Noise si distingue a occhio nudo: ancora i dialoghi esasperati, le iperboli, le crisi isteriche, stereotipi del genere (narrativo). E poi mancano due cose (del romanzo): i soldi, il reddito della famiglia medio borghese, e la tivù, cioè «il mezzo di fondamentale importanza della casa americana». La geometria del botta e risposta genitori-figli funziona, ma quelle sono le parole di DeLillo; l’extradialogico, lo sceneggiato, televisivo, perfetto per il cinema, cosa propongono? Chi lo regge il regime semiotico? I soldi – si può trasporre un romanzo che mostra il veleno post-industriale, consumista, senza parlarne? – sono un gradiente; «non saprei immaginarmi la morte a quella fascia di reddito» dice Babette, l’ennesimo elemento della simbologia di DeLillo, il gioco linguistico della morte, soprattutto in un romanzo domestico, l’ossessione – in teoria – proprio di Baumbach.
L’ho detto: l’aderenza al testo salva la baracca. Baumbach deve a tutti i costi saziare la sua fame sincategorematica, cioè spiegarti, indicarti cosa sta facendo, perché, cosa appartiene a chi e viceversa: postmodernismo, satira, apocalisse, horror. White noise te lo urla che è tutte queste cose. Se è un difetto, forse, per alcuni, non per altri, di sicuro non è delilliano. White noise è un romanzo che rielabora la tipicità, ossia estrae dal particolare al generale, e Baumbach va al contrario, costruisce un film che fa del teorema l’assioma.
White Noise, rumore bianco: in fisica un rumore caratterizzato da un’ampiezza costante, insondabile, priva di periodicità. Eppure, White Noise accelera e decelera, ogni urto è anelastico, didascalico, come i movimenti apparenti della camera, zoom a esacerbare il grottesco. Interessante, al contrario, l’uso di inquadrature dall’alto in molte sequenze lente, intime, perché sì, c’è distacco nella narrazione di DeLillo, e se ha bisogno di un’etichetta, è quella della distopia, etimologica: cattivo (dis-), luogo (topos). Jack Gladney lo dice due volte: «Non sono importanti i nomi ma i luoghi».
Baumbach flirta con l’esercizio estetico, e l’alterità, la corruzione – forse, le dimensioni di DeLillo – scivolano nel disaster movie. Allora bastava la visionarietà di un racconto del consumo, senza Stranger Things, senza Don’t look up, perché la ricerca bulimica dell’effetto, della parodia solenne – a volte anche a fuoco – anestetizzal’angoscia del sogno di DeLillo. L’ironia era uno strumento, non una funzione diegetica per un ritmo forsennato, sconnessa con la regolarità illusiva e coalescente dell’angoscia di DeLillo, che al contrario di Baumbach non fa così rumore.
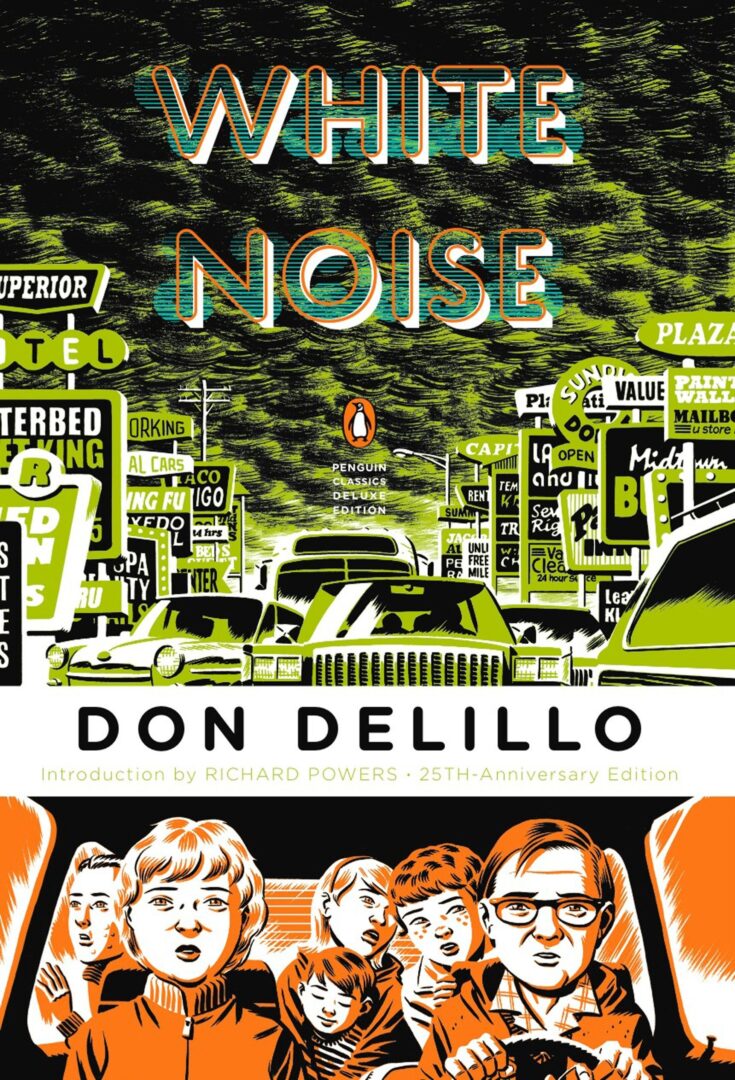
Supermarket
«I tibetani cercano di vedere la morte per quello che è. Ovvero la fine dell’attaccamento alle cose». Ecco, l’abbandono o il rovesciamento, che in Baumbach è disastroso, consumato, e in DLlillo, invece, è il motore della perturbazione, dell’implosione dell’io, indistinguibile nella pellicola, se non nella culla dell’aspetto, il supermercato. La fotografia brillante di Laurie Crawley (come in Vox Lux, poco, giustamente, white) è il veicolo per l’iper-realtà (diatopica), quasi pornografica, per un centro di elaborazione antropologica ed estetica, riflesso dell’impero (accademico) hitleriano fondato da Gladney, e non-luogo della domanda fagocitata dall’offerta, taciuta, incomunicata; insomma: l’Io lirico per fottere la morte (ma che è già fottuto in partenza). Qua Baumbach si è perso, strozzato (dal contratto Netflix?), e l’apocalisse – questa sì – della semiurgia – cioè la proliferazione di segni e immagini – di DeLillo resta abbozzata, e più che un peccato è un rimpianto se penso alle potenzialità semiotiche dello schermo. Per fortuna – almeno – Baumbach ripropone la scena del short for “Simulated Evacuation”, cioè quando Gladney parla con l’operatore sanitario nell’accampamento dopo l’ “evento tossico aereo”; e DeLillo incontra Baudrillard – il filosofo de La società dei costumi –, il mondo di White Noise dischiude la propria natura oscillatoria, la società dell’informazione contro la realtà oggettuale, distrutta, poi, dai segni che prendono il posto del reale stesso.

Vivo o morto
Tra gli scaffali del supermarket Murray (Don Cheadle) – professore di “Icone viventi” – dà a Gladney la soluzione: «uccidere qualcuno è una forma di rinascita», provocatoria per un modernista – Gladney – in un mondo postmodernista. Il confronto finale tra Gladney e Mink – il pusher del Dylar – è tematico, generazionale. Questa intuizione, credo, si conserva bene in Baumbach, cioè l’ “escatologizazzione” della violenza, o forse un determinante ontologico, o assassini o morenti; è la legge della competizione, del supermercato? Si tratta di fare i conti con la bestia che è in noi. Del consumismo da un lato, o della stasi, di cui la violenza è effrazione, perché Gladney e famiglia sono dentro e fuori l’evento – non sono veri personaggi quelli di DeLillo (altra idea lasciata nel cassetto) – insistono tra intercapedini, dei segreti, quelli che «ci possiamo permettere». La morte è il segreto inconfessabile del consumismo, DeLillo l’ha capito da tempo, Baumbach ha avuto un po’ paura.
