Nella diffusa opera di riproposizione del corpus letterario di Giorgio Manganelli, l’editore nottetempo ha di recente pubblicato il volume Lettere familiari (con un testo di Giorgio Vasta). “Lettere familiari” perché indirizzate alla fidanzata e poi moglie, alla figlia (Lietta, che le ha raccolte), al fratello, alla cognata.
La critica – intesa come funzione del distinguere – è un’azione di per sé parziale se non è sostenuta da una sentita partecipazione alle ragioni dell’opera. Partecipazione attiva, sondaggio rabdomantico del vuoto, illusione da parte del critico di essere consustanziale a quel che nell’opera altrui va cercando. Ovvero se stesso, la sua esperienza del mondo.
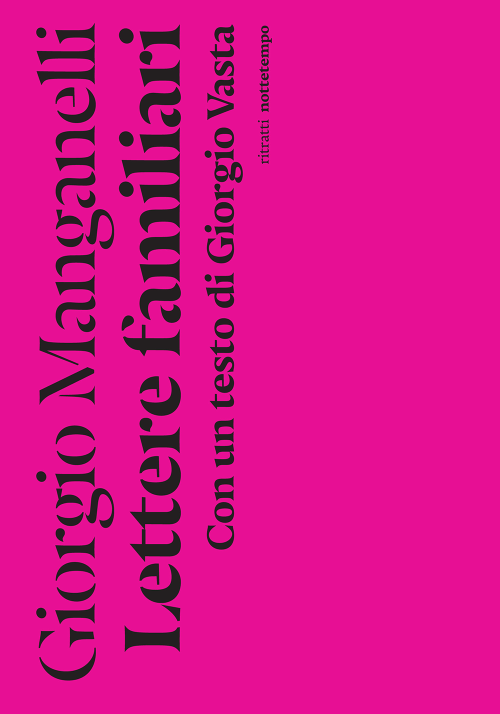
Caro Manganelli,
si scrivono ancora lettere senza destinatario al giorno d’oggi? Io sono certo che i morti ne scrivano. I morti, gli estinti, dolcemente curvi sugli scrittoi, mentre a mano tracciano quei saluti che da vivi non hanno saputo pronunciare, quei dinieghi cui hanno abdicato, quelle maledizioni che poi ci snocciolano in sogno, ridendo. Quando ci penso, Manganelli carissimo, mi commuovo all’idea di questi fogli che si accumulano sul pavimento del Purgatorio, o come tu voglia chiamare quell’anfratto della materia dove tutti resteremo sospesi fino al prossimo lampo di luce senza tempo. Mi domando (posso domandarlo a te?) se vi sia qualcosa di più triste di una casa colma di lettere mai inviate. Eppure ai morti capita così, e forse anch’io aspetterò di esalare prima di raccogliere carta e penna, o di battere isterico alla tastiera di un computer lustrale, e di scrivere a mia madre, agli amici che ho perduto per strada, a tutti quelli che da vivo mi avranno ignorato o amato.
D’altra parte la stessa letteratura che cos’è se non una negazione della vita, qualcosa che può essere esercitato solo da estinti, solo in assenza?
Lo sapevano bene gli sciamani, i protomedici, taluni indovini: il nulla è il nulla, ed è il nucleo di ogni cosa. Ma come farlo accettare agli uomini? Immagino che a qualcuno, un giorno, sia venuto in mente di criptare questa gelida verità nel corpo caldo di una storia. Nascevano i primi eroi, cui la finzione affidava il compito di sondare il destino, osteggiati dalla geometria dei temporali e dei naufragi, dal disegno incomprensibile di un dio o di una dea. In fondo, immedesimarsi con l’ombra di un eroe estinto è la prima vera esperienza della morte che tocca a ciascuno di noi.
Dicevamo delle lettere che i defunti scrivono ai vivi, così fiorite di glosse e di rimandi, così attente a non suscitare vergogna in chi mai dovesse leggerle. Lettere disegnate, che lasciano al loro destinatario il conforto di inventarne il significato, magari quello più utile a sé e alle proprie mancanze. Lettere-vocabolario, fatte di lunghe sequenze di parole e definizioni quasi mai ortodosse, eppure utili a rimarcare l’esistenza di termini ai quali i vivi hanno smesso di ricorrere con la giusta cautela. Pare già di scorgerne qualcuno: solitudine, vaghezza, orrore…

Mi è capitato di leggere alcune delle lettere che hai scritto ai tuoi familiari. Lettere-labirinto in cui si aggira un bambino con una testa posticcia di toro. Lettere-viaggio, peregrinazioni nel cuore della notte, che bene si appaciano con quel tuo ritratto da fotofobico, al riparo perenne nella tua ultima casa romana dove dicevano di rado tirassi su le tapparelle. Anche io sono solito acquattarmi nel buio. Ne ho avuto timore per tutta la vita, ma ora che sono diventato confidente della paura non sono più capace di stare in piena luce. La tempesta di quanti scatenata da una lampadina mi riduce al panico. È questo il mio incubo perfetto, carissimo Manganelli. Non una casa completamente al buio, dove galleggiano quiete le larve di noi e del nostro passaggio, ma una casa al buio dove una sola stanza è accesa. Cosa accade di non visto tra quei muri? Chi è nella stanza? Forse qualcuno che scrive al posto nostro. Forse un doppio di noi. Forse saperlo equivarrebbe a eclissarsi per sempre.
A me che coltivo la passione del genere epistolare, e che pure mi sono esercitato nello scrivere lettere ai vivi durante il mio passaggio in questo mondo, proprio le lettere paiono il vero monumento alla finzione. Soprattutto quelle che principiano con ‘caro’ o ‘cara’, quelle rivolte agli affetti, quelle che parrebbero testimoniare attraverso la loro fibra luminescente una verità che ad altri non sarebbe dato sapere, e che verrebbe svelata esclusivamente al loro destinatario, al loro predestinato. Davvero è così o è solo un gioco delle parti? Davvero lo scrittore ignora che quella carta un giorno diventerà palese al resto del mondo in qualità di reliquia, di amorosa archeologia? Davvero può fingere con se stesso che le sue parole così intime e piane, il desiderio che ne trasuda, la paura di morire, non diventeranno argomento di discussione nella platea cannibale dei lettori? Io non credo. C’è una collaborazione perversa tra le voci che abitano in noi ogni volta che scriviamo una lettera, mascherata da gesto intimo e unico. Le vere lettere, quelle che rimangono tali, caro Manganelli, forse sono quelle che non spediamo. Quelle che restano a marcire nel cassetto acquitrinoso della nostra memoria. Le lettere da soffitta, il pasto preferito dei topi che muovono la ruota del nostro penare. Le lettere da morti.
Così il cerchio è chiuso, alla fine. Nell’eterna lotta tra le idee e la loro caduta nel mondo, le lettere che inviamo sono solo il calco rozzo di qualcosa che non scriveremo mai, e che di noi è la parte più autentica. Questo immane archivio del non-detto è il fondamento burocratico di quello che siamo, il centro del nostro Ministero dell’Io. Da scansie tanto gravide di fogli cerebrali che quasi si spezzano, emana la nostra missione di esseri umani: tacere la parte più vera di noi, attendere la morte per poterla, finalmente, pronunciare.

Io non so quale sia il nucleo che si cela dietro il nostro scrivere a qualcuno. Se è il bisogno vitale di cedere il posto a un altro dentro di noi, oppure se è l’incapacità di usare il nostro corpo come ricettacolo d’amore ricorrendo così alle lettere. Le parole sono il sedimento impuro di un passaggio ideale, eppure solo le parole valgono, perché esistono. E le lettere, caro Manganelli, sono fatte di parole. Le parole stanno tutte in bocca a quell’essere senza nome che ha preso dimora nell’unica stanza illuminata della nostra casa buia, quel diavolo benigno che ci fa da supplente quando non siamo più capaci di oltrepassare la soglia della nostra abitazione, del nostro mondo. Dicevo qualche riga più su che quell’essere abusivo non andrebbe mai guardato in volto, novella Medusa che ci ridurrebbe in una statua di sale (o di inutile pietra?). Facciamo allora come Perseo nella grotta, avvantaggiamoci di una stoviglia specchiata raccolta in cucina, di un ovale di peltro sopravvissuto dalle mani di qualche innominabile vecchia, e a passo accorto addentriamoci nella caverna luminosa per stanarlo. Eccolo lì, assorto anche lui tra mille carte, con il vestito di qualche cerimonia che ha riciclato per il suo stolido ufficio, la mano artritica, mal rasato, spettinato. Eccolo lì lo spirito del tempo, che immaginavamo mostruoso e livido, terrifico e definitivo. Non ci degna nemmeno della sua attenzione. Sta scrivendo a qualcuno. Ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri innamorati. E quando solleviamo la spada per spiccargli finalmente la testa e spegnere l’incubo per sempre, solleva gli occhi e ci implora. Vuole finire di scrivere quest’ultima lettera, almeno un rigo di saluto, prima di andare. E noi attendiamo tutta la vita, la lama in alto che brilla di bronzo.
Con immutata stima, riverente, DS.
